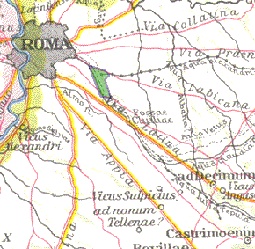![]()
LA STORIA ANTICA DEL QUARTIERE
"...il fondo detto Lauretum (ad duas lauros) con le terme e tutta la campagna dalla porta Sessoriana (porta Maggiore) fino alla Via Prenestina, dalla Via Latina al Monte Gabo (l'attuale Monte Cavo) proprietà di Elena Augusta...".
Tutta l'area era annessa alla residenza imperiale urbana del Sessorio, la grande villa urbana, in parte occupata dalla basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a ridosso delle Mura. La tenuta, almeno per la parte distinta con il toponimo ad duas lauros lungo la Via Labicana, che costituisce il centro di tutto il sistema, dovette entrare per tempo nella proprietà imperiale e la denominazione deriva certamente dall'uso, instaurato da Augusto, di ornare la porta della residenza imperiale con due piante di alloro. In questa località, infatti, risultano insediati già nel II secolo, con il campo di addestramento ed il sepolcreto gli Equites singulares, ossia il corpo di cavalleria addetto alla guardia dell'imperatore che aveva i suoi accampamenti (castra) al Celio ed al Laterano. Massenzio venne qui acclamato imperatore dai militari della guardia, equites e pretoriani. L'anonima epitome de Cesaribus (40, 20) dà infatti una informazione precisa: Massenzio fu fatto imperatore in una villa al sesto miglio da Roma sulla Via Labicana. Tale villa viene definita da Eutropio villa pubblica. Dopo la battaglia di Ponte Milvio Costantino sciolse sia il corpo
dei pretoriani che gli equites, ma il campo ad duas lauros continuò ad essere
usato per le esercitazioni militari. I resti monumentali più cospicui del fundus ad duas lauros lungo il primo tratto della Via Labicana sono rappresentati dalle costruzioni costantiniane al III miglio, presso le catacombe dei Santi Pietro e Marcellino, dalla necropoli lungo la Via Labicana costituita da catacombe e mausolei come quelli lungo la sede ferroviaria Roma-Pantano e comprendenti il sito della necropoli degli Equites singulares, dalla grande villa dei Flavi Cristiani, dalla "Rotonda di Centocelle", dalla villa rustica a Sud della grande villa, verso la attuale Via Papiria, dall'Acquedotto Alessandrino. Come si può vedere dalla immagine della carta dei dintorni di Roma come appariva in epoca augustea, la zona oggi denominata Quadraro (colorata in verde nella piantina), ricadeva in un'area particolarmente ricca di acquedotti, erano presenti: l'Alessandrino, il Claudio, l'acqua marcia, l'anio vetus e l'anio novus, in questi confluiva poi l'Aqua Iulia Tepula.
|
||||||||||||||||