![]()
MONTE DEL GRANO (O MAUSOLEO DI ALESSANDRO SEVERO)
|
In un libro degli anni '40 troviamo scritto: -"Piccole case accatastate sulla sinistra della Tuscolana e tra di esse si apre, di colpo, quel tal Monte del Grano, antico monumento che il piano particolareggiato della zona vuole sia rimesso in degna luce"- A dispetto del piano particolareggiato citato sessanta anni fa, il Mausoleo non gode oggi di grande valorizzazione. In ogni caso il nostro quartiere, il Quadraro, ha l'onore di ospitare un'importantissimo, ed ancor oggi misterioso, monumento risalente all'epoca imperiale romana e che risulta essere la terza tomba a tumulo dopo la Mole Adriana ed il Mausoleo di Augusto; la sua importanza è confermata dalla rappresentazione che Eufrosino della Volpaia ne dà nella sua pianta di Roma e dintorni del 1547, il Mausoleo svetta nella piana della Campagna Romana in primo piano rispetto anche agli importanti acquedotti, ed ancora il Piranesi, nel XVII secolo, lo definisce "uno dei più superbi sepolcri della romana grandezza".
Il Mausoleo, attribuito ad Alessandro Severo, è conosciuto come "Monte del Grano" definizione che dà il nome anche al Parco adiacente e più genericamente alla zona. Il nome Monte del Grano deriva presumibilmente dalla corruzione di "modius grani" (moggio di grano), nome datogli nell'antichità in quanto la sua forma, poco dopo l'asportazione dei blocchi di travertino, avvenuta nel 1387 per opera di tal Nicolò Valentini, ricordava appunto un moggio di grano. Tale nome veniva comunque già usato nel 1386 come risulta da documenti conservati nell'Archivio Storico Capitolino. Il mausoleo faceva parte della tenuta detta "Casale delle Forme" (cogliamo qui l'occasione per dire che il nome della zona, Casale delle Forme appunto, si riferisce ai fornici degli acquedotti ancora oggi largamente presenti in quest'area e che da questo deriva la definizione di Porta Furba -Porta Forma- dato all'arco lungo la Via Tuscolana. Altre fonti la ritengono derivante da fur - furis [ladro]). Il mausoleo lo troviamo definito anche come "Monte di Onorio" o "Monte di Nori" o ancora "lo Montone del Grano". La leggenda popolare vuole invece che fosse un monte di grano trasformato per punizione divina, in terra perché raccolto di Domenica, giorno dedicato al riposo. Il riferimento al grano è comunque legato, chissà se casualmente o no, ad una caratteristica del Quadraro, la toponomastica del quartiere è dedicata, direttamente od indirettamente, a divinità, famiglie o singoli personaggi legati al mondo agricolo. IL MAUSOLEO Questo importante e poco conosciuto mausoleo è collocato in corrispondenza dell’incrocio della grande via consolare Tuscolana con un'altra arteria, oggi scomparsa ma riportata nella Carta dell'Agro e attraversante il quartiere Quadraro, che collegava da Nord a Sud la Via Salaria con la Via Latina, come una sorta di circonvallazione. Possiede, all'esterno, un aspetto piuttosto dimesso, presentandosi come un monticello di terra alto una dozzina di metri e mancandogli del tutto il ricco rivestimento esterno a gradoni di travertino, asportato come già detto, nel tardo Medioevo per farne calce "bonam et congruam" come troviamo scritto in un documento del 28 aprile del 1387. Più conservato e di particolare interesse è l'interno, si accede da una porta il cui arco marmoreo risale almeno al 1750, epoca in cui Piranesi realizzò le incisioni. Un corridoio di 21,50 metri di lunghezza e 1,60 circa di larghezza, al cui termine troviamo lo sbocco di due lucernari, uno obliquo e risalente alla costruzione del monumento ora tamponato ed un altro, verticale più recente, ancora comunicante con l'esterno, conduce ad una cella rotonda di grandi proporzioni, tali da far attribuire il sepolcro ad una destinazione imperiale da molti studiosi; questa un tempo forse divisa in due piani da una volta, demolita, secondo alcuni, per asportare i reperti contenuti; volta che secondo altri era sostenuta da un giro di colonne. Altra ipotesi è che la cella fosse contornata da un giro di colonne che sostenevano una volta a botte anulare che formava una sorta di balconata circolare la quale si affacciava sulla camera inferiore. Nessuna di queste due ipotesi è ancor'oggi confermata. Alla base del muro circolare della cella si trovano dei grandi blocchi di travertino che fanno parte della fondazione e che rappresentavano il piano d'appoggio della pavimentazione ora scomparsa. La pianta disegnata dal Piranesi Un complesso sistema assicura luce ed aerazione alla cella, come detto un lucernario obliquo si apre nel corridoio di accesso che comunica anche con un pozzo verticale, da qui sembra, venne tirato fuori nel 1582, allargando gli imbocchi, il sarcofago sul quale si parlerà più avanti. Un altro lucernario, anch'esso obliquo, si apre esattamente all'opposto, quest'ultimo era forse chiuso da un "colossale chiusino di scolo in travertino, rotondo, con grande stella a 12 raggi in rilievo e 6 fori nel centro, spezzato in due" come lo descrive il Tomassetti nel 1926, ma di cui oggi non vè più traccia. La struttura laterizia fa assegnare il monumento agli anni a cavallo tra il II ed il III secolo d.C., nel corso di un recente restauro è stato possibile leggere altri esemplari di bolli laterizi che indicano una datazione intorno alla prima metà del II secolo d.C., il modulo laterizio invece e la qualità dei materiali impiegati, farebbero collocare il manufatto nella seconda metà dello stesso secolo. Come prima accennato, nel maggio del 1582 un certo Fabrizio Lezaro estrasse il sarcofago che fu attribuito all'imperatore Alessandro Severo in conseguenza della identificazione delle due figure distese, presenti sul coperchio, come Alessandro Severo e sua madre Giulia Mamea. Venne poi, in modo inesatto, riconosciuto come il ratto delle sabine la scena rappresentata sui lati del sarcofago. Dopo il rinvenimento le trattative per l'acquisto da parte del Comune non furono brevi, sappiamo che il sarcofago venne collocato nel cortile del palazzo dei Conservatori nel 1590, venne poi trasferito nel cortile del Museo capitolino nel 1722 ed infine, nel 1817 venne posto nella III sala terrena a destra nello stesso Museo dove tutt'ora si trova. LA TORRE In Epoca medievale venne eretta sulla sommità del Monte una torre da un rappresentante della famiglia Alberti di Parma, una lapide a caratteri di terracotta indicava: ANTONIO DE ALBERTI DI PARMA FECIT 1505
Egli vi pose il proprio stemma: una croce bizantina con ai lati una stella ad otto raggi ed una mosca. La torre subì ulteriori modifiche fra il 1600 ed il 1800 come testimoniano stampe dell'epoca. Nel 1870 vennero eseguiti interventi di consolidamento da Filippo Lovatti ma solo trent'anni dopo la torre crollò, durante un violento nubifragio ed oggi ne rimane solo parte della fondazione. IL SARCOFAGO Particolare interesse merita il sarcofago trovato, come riportano le cronache, all'interno del Mausoleo. Questo reperto è la testimonianza di una serie di eventi misteriosi ed affascinanti che un interessante lavoro del 1987 di Erminio Paoletta ci descrive con colta minuzia. Prima domanda: chi erano Alessandro Severo e Giulia Mamea? Per riuscire a comprendere il significato del monumento di cui stiamo parlando occorre percorrere brevemente la storia di questi due personaggi. Nel II secolo della nostra era, l'Impero Romano aveva offerto al mondo conosciuto uno dei periodi migliori della nostra civiltà, la tecnica dell'"adozione" che determinava il successore di un Imperatore aveva portato alla sequenza fra le più felici: prima Traiano poi Adriano, poi Antonino Pio ed infine Marco Aurelio, ma proprio quest'ultimo decise di tornare all'antico sistema della successione dinastica favorendo così il figlio Commodo e contribuendo alla fine dell'Impero Romano.
Commodo fu ucciso nel 192 e prese il potere Settimio Severo, di origine africana, quest'ultimo aveva sposato Giulia Domna sorella di Giulia Mesa. Con Domna inizia l'avventura imperiale delle quattro appartenenti alla gens Giulia, le figlie di Giulia Mesa, G. Soemia e G. Mamea. Con loro, i mariti contarono ben poco al potere, tanto che il padre naturale dei loro figli fu Caracalla a dispetto dei loro matrimoni, rispettivamente con S. Vario Marcello e M. Giulio Gesso Marciano.
Dopo anni di carnascialesco imperare dove un senato parallelo, tutto femminile, decideva le norme di galateo: chi doveva essere baciata e chi no, chi potesse andare a cavallo e chi su un mulo, chi dovesse pagare le portantine e chi ne era dispensato, ecc., il malumore si diffondeva in Roma. La, oramai nonna, Mesa cercava di gestire gli eventi, ed indusse la figlia Soemia di affiancare ad Elagabalo un Caesar, in pratica il nipote, Alessiano, figlio di Mamea. Alessiano era un seguace delle religioni orfiche e cristiane, buono e soprattutto, bonaccione. Il 10 Luglio del 221 venne adottato il tredicenne Alessiano che prese il nome di Alessandro. Elagabalo cercò in tutti i modi di eliminare il cugino ma l'azione di togliergli il titolo di Caesar fu definitivamente controproducente, l'11 Marzo del 222 Elagabalo e Soemia vennero trucidati dai soldati scatenati e gettati nel Tevere, lo stesso giorno iniziò l'avventura imperiale di Alessandro. L’Impero è, naturalmente, sotto tutela della madre che segue l'Imperatore in ogni passo. Mamea ed Alessandro Severo La formazione di Alessandro era iniziata in Siria ma le sue preferenze andavano alla spiritualità dei culti monoteistici, nel Palazzo Imperiale conservava le immagini di Orfeo, Abramo e Cristo, di questo prese come massima per la sua condotta la frase: "Quod tibi fieri non vis, ne alteri feceris" -Non fare ad altri quel che non vuoi sia fatto a te stesso.-
Negli anni 232-33 la Persia premeva con il suo esercito, Alessandro sconfisse i persiani ed il 25 Settembre del 233 celebrò la vittoria in Roma. Lo squilibrio delle armate romane presenti in Persia prestò il fianco ai Germani che iniziarono a minacciare le provincie romane e danubiane, Alessandro si portò nei pressi di Magonza, l'Imperatore cercò di avviare trattative ma scoppiò una rivolta fra i soldati che lo accusavano di "mammismo" e di dedicarsi più alle corse equestri ed ai piaceri invece di sferrare l'offensiva contro i barbari. Il 19 Marzo del 235 Alessandro venne assassinato nella sua tenda assieme alla madre Mamea. La sepoltura, secondo Erminio Paoletta, ebbe luogo sui colli del subapennino Irpino-Dauno, gruppo montuoso del subappennino pugliese, al confine tra la Puglia e la Campania. Naturalmente era più adeguata una sepoltura nella città di Roma e probabilmente tanto fecero gli appartenenti alla congrega degli Alexandriani, realizzando una tomba di rappresentanza nella Capitale dell'Impero. Questi, pare, fecero le cose per bene, tanto che Lampridio, in età costantiniana parla del magnifico Mausoleo (il Monte del Grano) e lo presenta come la vera tomba senza fare cenno ad iscrizioni o sepolture segrete.
Il sarcofago, falso in quanto non la reale sepoltura, ma verititiera l'attribuzione ad Alessandro Severo, presenta bellissimi bassorilievi sulle quattro facce che narrano apparentemente le vicende di Achille, di cui Alessandro aveva grande venerazione, ma che probabilmente mostrano una rassegna della Gens Giulia. Non approfondiamo in questa sede la presentazione delle epigrafi che in modo misterioso, ma che una volta avuta la chiave, palesano chiaramente il significato di questo monumento. Desideriamo soltanto accendere l'interesse degli appassionati e degli abitanti del Quadraro affinché venga valorizzata ed apprezzata questa nascosta ma preziosa testimonianza del nostro passato, sperando così che non sia soltanto l'Aeronautica, per la presenza del suo moderno radiofaro sulla sommità del sepolcro, ad interessarsene. IL VASO PORTLAND Solo una citazione, ma meritata, per un preziosissimo vaso in pasta vitrea oggi conservato al British Museum che si riteneva rinvenuto nel sarcofago al momento della scoperta. Gli attuali studi lo datano al periodo Augusteo e per tale motivo è da ritenere infondata l'ipotesi del ritrovamento.
Rimane comunque il fascino di questo vaso, probabilmente il più bello fra i "cammei vitrei" oggi conservati. |
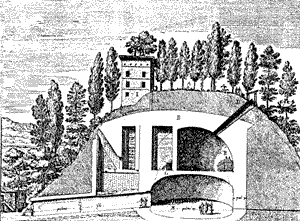 |
L'incisione descrive dettagliatamente gli ambienti interni del Mausoleo e mostra la torre ora scomparsa, notare, in basso a sinistra, presso l'ingresso del monumento il piccolo casale che ancora oggi è conservato e ben visibile su un angolo di Piazza dei Tribuni. |
Il Parco del Monte del Grano è recentemente
oggetto di recupero, ben felici di questo intervento del servizio
giardini ci auspichiamo che vengano presi seri provvedimenti per la rimozione
dei cartelloni pubblicitari abusivi che ne occludono la vista
anche al più attento dei passanti. Di più complessa attuazione ma ugualmente importante riteniamo sia lo spostamento del
capolinea dell'ATAC che comporta lo stazionamento di mezzi davanti al Monumento e proprio
sopra al luogo di rinvenimento dei blocchi di travertino che ne tracciano l'antico
perimetro. |
|
 Particolare della pianta del 1547
Particolare della pianta del 1547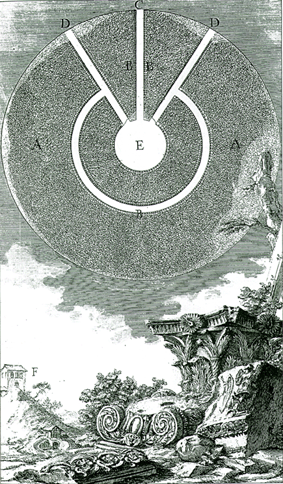
 Foto
della fine '800
Foto
della fine '800 Il
colossale sarcofago
Il
colossale sarcofago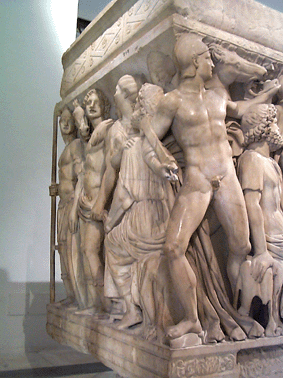 Il
lato sinistro
Il
lato sinistro

 Dettaglio
del coperchio
Dettaglio
del coperchio
