

UGOLINO UGOLINI
Il capostipite della famiglia Ugolini, è un professore di scienze naturali: Ugolino Ugolini, nato a Macerata il 22 maggio del 1856. Aveva conseguito la laurea a Padova, con una tesi sulle ossa d’alcuni crani di scimmia. Dal 1919 in poi aveva fissato la sua dimora a Brescia, trasferito, come amava raccontare, dal ministro Crispi, per le sue convinzioni positiviste. Soprattutto per il suo impegno come presidente della prima Camera del lavoro a Padova (vedi la testimonianza qui sotto). Nella città lombarda, in una casa ai piedi del colle Cidneo, era morto il 23 ottobre del 1942. Il più importante documento della sua accurata conoscenza delle piante, com’ebbe a scrivere un suo discepolo, il professor Valerio Giacobini, fu l’Erbario originalissimo, da lui raccolto e che ora si trova presso l’Istituto botanico di Padova. La leggenda vuole che a Brescia si producesse, all'inizio del Novecento, come militante socialista, tutti i primi venerdì del mese, in "prediche anticlericali" in un teatro cittadino. Una scelta che ripudiò, prima di morire, dedicandosi, invece, a profondi interessi religiosi. Anche su questo pubblichiamo i dati raccolti nella "Enciclopedia Bresciana" curata da Antonio Fappani per le edizioni "La voce del popolo".
L’esperienza socialista di Ugolino Ugolini è stata rievocata in un numero della rivista “Brescia Musica”, diretta da Renzo Baldo. Un articolo di Gianfranco Porta ha indagato, infatti, sulle tradizioni musicali del movimento operaio all’inizio del Novecento. Ad un certo punto è citata una corrispondenza apparsa sul giornale “Brescia Nuova” e proveniente da Odolo, piccolo paese della Valle Sabbia. Scriveva il cronista dell’epoca.
“I socialisti di qui, saputo che anche quest’anno il prof. Ugolini è alla Croce di Valio con la famiglia a passare l’agosto, si sono recati in buon numero con la loro fanfara a visitare il compagno di fede e a salutare la bandiera rossa che sventola sulla cascina da lui stessa abitata”. Dopo le parole di ringraziamento e di plauso pronunciate dal noto esponente socialista “le gagliarde note dell’inno dei lavoratori echeggiano ancora per quelle balze montane".
Un suo amico bresciano, il professor Ferretti Torricelli ebbe modo di ricordare Ugolino Ugolini, quando scomparve, con queste parole: <Ribolliva d’ardore nel cercare fino all’utopia, giustizia e benessere per il popolo. Per questo militò in un partito acceso e si sentì cittadino nostro, entrando nei consigli comunale e provinciale. … >. Aveva sposato, in prime nozze una giovinetta ebrea padovana, Elisa Revere, morta giovanissima, e in seconde nozze, Santina Donà di Vigonovo (Venezia). Otto i figli avuti dalle due consorti: due morti combattendo, decorati al valor militare, nella prima guerra mondiale (Bruno e Ugolino), poi Augusto (generale e medaglia d’oro nella guerra d’Africa), Giulio, Max, Davide, Elisa e Gherardo.
UGOLINO UGOLINI presidente della Camera del lavoro di Padova
Ed ecco un ricordo di Ugolino dalla pubblicazione (aprile
2006) "Le origini della Camera del Lavoro di Padova 1893-1915" di Diego Pulliero:
Il professor Ugolini, pur avendo diretto la Camera del lavoro padovana per
breve tempo, è stato un personaggio che ha lasciato un segno di rilievo nella
storia di questa organizzazione.
Marchigiano d'origine, nasce a Macerata nel 1856 da una famiglia di modeste
condizioni, trasferendosi poi a Padova per effettuare gli studi universitari.
Consegue quindi la laurea in Scienze naturali con una tesi che s'inserisce
pienamente nel contesto del clima positivistico del tempo: uno studio sulle ossa
di alcuni crani di scimmia. Dopo la laurea Ugolini si iscrive alla Scuola di
Magistero per un anno di perfezionamento che gli consentirà di ottenere il
diploma di abilitazione all'insegnamento di Scienze naturali.
La sua carriera di insegnante nella scuola pubblica inizia nell'ottobre del
1883, quando assume l'incarico di professore reggente di Storia naturale presso
l'Istituto tecnico provinciale, l'attuale Istituto tecnico statale per geometri
"G.B. Belzoni". Nel 1894, però, viene trasferito a Brescia per motivi politici.
In questa città Ugolini si stabilisce definitivamente, spostandosi solo per
brevi periodi. A Padova, al termine degli studi, si era intanto sposato con
Elisa Revere, ma era poi rimasto vedovo; in seguito, lasciata la risica veneta,
si risposerà con Santina Dona. Dai due matrimoni nascono otto figli. Muore a
Brescia nel 1942.
Dal punto di vista scientifico Ugolini fu uno studioso attento, serio e
appassionato di botanica, raggiungendo, grazie ad una vasta attività protrattasi
nell'arco degli anni, una considerevole notorietà. Divenne anche autore di
numerosissime pubblicazioni, assumendo diversi incarichi nell'ambito di
autorevoli istituzioni scientifiche ed effettuando viaggi di ricerca,
traduzioni, conferenze; a Padova, presso l'Istituto botanico, è conservato il
suo erbario.
Le cronache e la documentazione dell'epoca ci rinviano l'immagine di un uomo dal
carattere forte, estremamente onesto, molto legato alla famiglia, rigoroso tanto
negli studi, quanto nella vita; inoltre di un insegnante avvincente e
appassionato e di un politico impegnatissimo nella battaglia per la conquista
dei diritti dei lavoratori.
Su quest'ultimo versante la sua convinta militanza socialista viene confermata
da una continua presenza nelle organizzazioni del movimento operaio di Padova e
Brescia, città nelle quali visse ed ebbe un ruolo di rilievo nella vita
pubblica. Nel corso del tempo, tuttavia, si allontanò progressivamente dal
socialismo, accostandosi poi alla fede cattolica con la stessa intensità che
l'aveva caratterizzato in altri ambiti. Il suo allontanamento dagli iniziali
ideali socialisti è anche testimoniato dal nipote, il giornalista de L'Unità
Bruno Ugolini, che ne ricorda la sepoltura in camicia nera, seguendo un percorso
comune a non pochi militanti delle formazioni della sinistra prefascista.
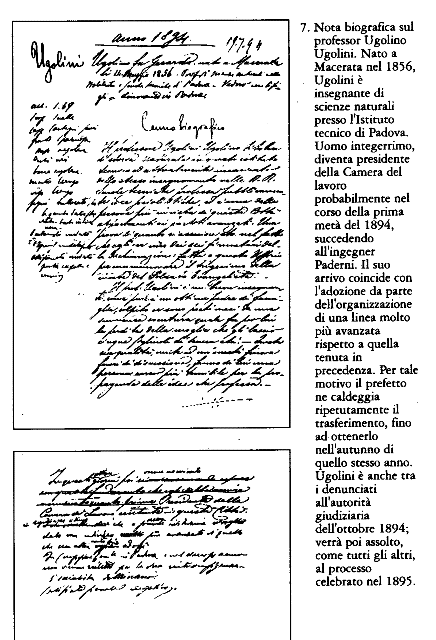
A Padova Ugolini è un personaggio chiave nella storia del sindacato di classe;
fu lui, infatti, l'uomo della svolta nella Camera del lavoro che condusse, nel
corso del 1894, dalle iniziali posizioni moderate a un'impostazione più
incisiva. La novità non sfuggì allo stesso prefetto che intuì benissimo il ruolo
di Ugolini nell'ambito del cambiamento in atto. Il funzionario non mancò infatti
di cogliere e riconoscere gli aspetti positivi della sua personalità: l'onestà,
la determinazione, la stima di cui godeva e lo stesso saldo legame con gli
affetti familiari , ma proprio per questo egli lo ritenne un elemento
particolarmente pericoloso. Il carisma, l'attivismo e l'irreprensibilità di
Ugolini erano infatti le caratteristiche adatte per fare del professore
l'elemento in grado di catalizzare le spinte più combattive presenti sia pure in
modo embrionale nel movimento operaio padovano, facendole poi maturare ed
evolvere verso posizioni più radicali.
L'azione del prefetto che chiese e ottenne dal Ministero dell'Interno
l'allontanamento di Ugolini ebbe dunque carattere preventivo. Il fatto che la
sua richiesta venisse accolta, unita alla chiusura della Camera del lavoro da
lui decretata, servì a scompaginare non poco le fila del nascente sindacato
padovano. Il processo, comunque, non si arrestò e di lì a pochi anni, nel 1900,
la Camera del lavoro rinacque, anche se sotto la guida di Ferruccio Maran.
Nel frattempo, però, il professor Ugolini si era oramai trasferito a Brescia
dove proseguì la sua intensa attività scientifica e politica. Con Padova rimarrà
vivo il legame, testimoniato anche da alcuni brevi rientri. Il difficile compito
di rilanciare l'organizzazione spetterà però ad altri. E' tuttavia alla breve ma
intensa fase della sua presidenza che occorre ricondursi per individuare il
momento in cui storicamente la Camera del lavoro uscì dai limiti imposti
dall'originario moderatismo, entrando definitivamente nel solco delle lotte che
il movimento operaio avrebbe intrapreso nel nuovo secolo.
LA BIOGRAFIA DALLA ENCICLOPEDIA BRESCIANA DI ANTONIO FAPPANI
(Edizioni "La Voce del Popolo")
UGOLINI Ugolino
- (Macerata, 12 maggio 1856 -
Brescia, 23 ottobre 1942). Di Gherardo e di Enrichetta
Firmani. Di famiglia povera, fu avviato lo stesso agli studi classici, ma
corse il rischio di non proseguirli se non fosse stato vivamente
raccomandato dagli stessi suoi insegnanti
al prof. G. Rossetti, illustre fisico dell'Università di Padova,
venuto nel 1876 ad ispezionare il Liceo di Macerata
insieme a G. Carducci. Potè così frequentare i quattro
anni alla facoltà di Scienze Naturali della R. Università
di Padova, aiutato economicamente, grazie ad una borsa
di studio, anche dal prof. G. Omboni per il quale professò poi sempre
profonda gratitudine ed affetto. La tesi di laurea
("La cassa ossea del cervello studiata analiticamente
in alcuni crani di scimmia") fu pubblicata nel 1882 negli "Atti della
Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali"
allora presieduta da Giovanni Canestrini. Dopo un anno di perfezionamento
alla Scuola di Magistero della medesima
Università, conseguì nel 1881 il diploma di abilitazione
all'insegnamento delle Scienze Naturali, dando prova di
conoscere tre lìngue straniere e di possedere una notevole
cultura
generaleIl 1 ottobre 1882 sposa in Padova
una giovinetta ebrea padovana,
Elisabetta Revere, dalla quale ha cinque figli:
Gherardo
(1885 -1960) (v.), Giulio Cesare
(8 settembre 1886 - Brescia, 8
febbraio 1958), viaggiatore di commercio,
Augusto (1887 - 1977) (v.), Ugolino (1892-1925) (v.), Bruno
(1889 -1917) (v.). Trascorre un primo anno
(1882 -1883) a Milano ove si dedica a
lezioni private ed a riduzioni di opere scientifiche e letterarie
collaborando con articoli dello
stesso genere su giornali e riviste, come
il "Corriere della Sera", l"'Euganeo",
l' "Illustrazione Italiana", "La Natura". Entra nell'insegnamento pubblico
nelT ottobre del 1883 come Professore
Reggente di Storia Naturale
nell'Istituto Tecnico provinciale di Padova. Frustrate
le speranze di una carriera universitaria, crescenti
contrasti politici lo spingono nel 1894
a trasferirsi con la famiglia a Brescia come insegnante, come successore di
Giuseppe Ragazzoni, al R. Istituto
Tecnico Tartaglia dove rimane
fino al 1918. Dopo un temporaneo trasferimento
nel 1918 al R. Istituto Tecnico
provinciale di. Bologna e, poco
dopo a Padova, con l 'ottobre 1919 ritorna a Brescia
come insegnante nel Liceo Scientifico e
alla Scuola Pastori. Come è
stato rilevato: «Questi trasferimenti non hanno
interesse soltanto biografico, ma sono in
stretta azione con aspetti della
sua opera botanica. Del resto anche brevissimi
trasferimenti per incarico o per esami a Castiglione
delle Stiviere, a Desenzano, altrove,
lasciarono sempre tracce nei suoi
lavori e nelle sue raccolte». Morta la prima
moglie, il 17 dicembre 1896 sposa a
Brescia Santina Dona di Vigonovo (Venezia) dalla quale ha altri tre figli: Marx Carlo
(n. a Brescia il 15 aprile 1897, geometra); Elisa (n. a Brescia il 12
giugno 1898, sposa nel 1923 a Guglielmo
Marconi, emigrati a Buenos Aires),
Davide Copperfield (n. a
Brescia il 22 ottobre 1903), professore d'orchestra,
che nel 1945 sposa in Berlino Alma
Blandina, con la quale si
trasferisce nel 1948 in quella città.
Fu molto stimato come insegnante anche dall'Abba, ma ebbe pochi allievi,
fra i quali Nino Arietti. Come ebbe a
scrivere Valerio Giacomini, considerò
"l'insegnamento come una missione
e la impartiva con amore alla scienza
e con ardore di educatore, non mancando
mai di trarre dalle nozioni scientifiche significati ed applicazioni
morali. Avvinceva e convinceva gli
allievi accostandoli direttamente
alle cose studiate sui libri, mediante espe![]() rienze,
ostensione di materiali da lui stesso raccolti e
con frequenti gite scientifiche, sempre
instancabile ed appassionato,
sempre in grado di illustrare con profonda competenza ogni aspetto naturale
delle nostre contrade". Tale
passione e competenza travasò in una vasta divulgazione
attraverso «numerosi articoli popolari disseminati su giornali e riviste; le
frequenti conferenze scientifiche
e talora anche letterarie e filosofiche; tenute a Padova, a Brescia, a
Milano ed altrove, oltre ad attestare la sua
notevole cultura generale e speciale, dimostrano un'alta
serietà e nobiltà d'intenti. Egli, scrive il Giacomini, seppe sempre evitare
ogni facilità giornalistica quando trattava,
sia pur in forma popolare, di argomenti scientifici. Talora
è perfino difficile distinguere alcuni di questi suoi scritti
minori dalla produzione scientifica propriamente detta,
perché contengono spesso dati originali, che poi non ebbe
occasione di svolgere in, sede più appropriata».
Incominciò ancora studente nel 1876 a collaborare a la
"Vedetta!' di Macerata per passare poi nel 1882^1883 al
"Corriere della Sera", "Confessioni di un Naturalista"
che per lo stile immaginoso ed originale fecero pensare a lui come ad un
nuovo Mantegazza. Continuò poi con
resoconti di passeggiate naturalistiche dal 1896 al 1897 su "Adolescenza",
dal 1895 su "La Provincia di Brescia" per
collaborare nel 1926 al "Popolo di Brescia" e a "Scuola
Italiana Moderna". Come ha sottolineato il Giacomini,
Ugolini fu
scienziato nel vero termine della parola e
non soltanto «uno specializzato nel,
campo botanico, ma un naturalista
completo, che sapeva intrattenere sui più svariati argomenti, portando
spesso il contributo di sue
personali osservazioni ed esperienze. Riusciva così insegnante veramente ideale ed esemplare unendo al prestigio
di una preparazione vasta e profonda la
stessa autorità di un nome sempre più noto nel campo della scienza
pura ed applicata». Come uomo di scienza
lasciò lavori di scrupolosa
accuratezza e precisione, per la sobrietà
veramente scientifica e la documentazione
bibliografica sempre completa, che il Giacomini classifica in quattro principali
serie: "sistematica", "fitogeografica", "biologica" e "storico
umanistica".
Nella serie sistematica si è distinto fra i più valenti conoscitori della
flora delle Prealpi venete (specie padovana),
trentine, del Canton Ticino e delle Marche e soprattutto delle bresciane cui
dedicò il nucleo dei lavori floristici,
attraverso i quali si propose, come rileva il Giacomini, "di
preparare una nuova Flora Bresciana che aggiornasse il
vecchio Prospetto dello Zersi. A tale scopo si accinse ad
una esplorazione metodica del territorio. I sette Elenchi di piante nuove o
rare nel Bresciano, pubblicati tra il 1898 e
il 1910, segnano con straordinaria evidenza il progresso
della Sua maturità sistematica: da semplici elenchi di
piante e di località, divennero gradatamente sempre più
ricchi di osservazioni morfologiche, sistematiche, biologiche
e fitogeografiche". Dedicò particolare, attenzione
alle piante avventizie e arboricole, con ricerche le più
particolareggiate alla Poa silvicola Guss (1919 e 1929), alla
Campanula elatinoides Moretti e alla Hemerocallis flava L.
Sostenne il yicarismo della Campanula pyrami-dalis
L.
con VAdenophora liliifolia Bess (1928), segnalò
l'apparizione della bella Campanula pyramidalis su un
masso del Sabotino al Vittoriale degli italiani (1926).
Sono ricordate inoltre le sue osservazioni sul Nasturtium
austriacum
(1922).
Nella serie fitogeografica dedicò importanti lavori alla vegetazione della
Valtrompia (1896) e della Valsabbia
(1901)
segnalandosi, come
sottolinea
il
Giacomini, come "osservatore acuto ed
intelligente interprete degli aspetti essenziali di un paesaggio botanico".
Lo stesso Giacomini rileva ancora
più originali ed importanti le due note preliminari sulla vegetazione degli
anfiteatri morenici (1899 -1900)
che diedero "un impulso notevole
ad analoghi studi geobotanici sulle relazioni tra terreni e
vegetazione".
La serie biologica tesa a studiare le piante non soltanto per
scopo sistematico o flogistico, ma soprattutto come organismi
viventi, venne dall'Ugolini considerata "l'espressione
più elevata e completa della sua opera naturalistica".
Al Bresciano dedicò il nucleo dei suoi lavori floristici
puntando l'attenzione sui fenomeni periodici della vegetazione nel corso
dell'anno con particolare riguardo
al risveglio autunnale (fioriture "secondarie" autunnali),
alle forme di stagione ("dimorfismo stagionale"), ai relitti
di stagione (1903 e 1904), alla "vita iemale delle piante"
(1906), studiando l'accrescimento giornaliero invernale
di un certo numero di piante e mettendo in evidenza il
diverso comportamento di vari tipi di vegetazione durante
l'inverno. Il Giacomini tuttavia considera "ben poca cosa
(i lavori biologici) in confronto alla mole dei dati e dei materiali
raccolti in quaranta anni di osservazioni sulla
flora bresciana, attraverso il piccolo orto botanico sperimentale
che egli realizzò nel suo giardino sulla salita di S.
Desiderio e il suo ricco e originale Erbario che passò quasi
integralmente all'Istituto botanico di Padova al quale
cedette anche l'Erbario di guerra del figlio Bruno.
L'ultima produzione scientifica dell'Ugolini venne dedicata
ad una serie di studi storico umanistici su antichi erbari da lui
rintracciati e ad una presunta cattedra pliniana
in Brescia agli inizi del '500. Infine completando l'opera
del Venturi ("I miceti dell'Agro bresciano") compilò un
elenco di 28 specie di funghi mangerecci, ripartite in
sette famiglie.
Notevole anche il suo impegno in campo sociale e politico
fin dagli anni giovanili. Giunto nel 1894 a Brescia,
si dedica
subito alla promozione di una scuola serale,
di una biblioteca circolante, di corsi di
conferenze nell'ambito dei
partiti di sinistra e della Camera del Lavoro. Milita nel Partito
Socialista e dal 1902 al 1910 entra nel
Consiglio del Comune di Brescia battendosi per la
costruzione di case popolari e si impegna
decisamente contro l'introduzione del catechismo nelle scuole; nel
1903 sostiene con Giorgio Montini una
vivace polemica sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici. È attivo
anche nel Consiglio Provinciale e inoltre
è diligente commissario del Pio Luogo Zitelle. Il 13 luglio 1912 aderisce
alla sezione bresciana del
Partito socialista riformista e collabora a "La Provincia di
Brescia". Positivista e anticlericale,
rifiutato il soprannaturale, si
attaccò alla "religione della natura" indicando in essa
una "divinità tangibile" e come "fonte
reale" dalla quale trarre "ogni sorta di benefizi" e dalla quale "temere i
più grandi, mali” tenendo come la
religione della natura "la più
ragionevole". Vera ammirazione ebbe però sempre
per Gesù Cristo così da tenere per anni,
durante la settimana santa, dei
"quaresimali" o "conferenze pasquali"
nei quali esaltava il "mito" di Cristo
povero per i poveri, invitando i compagni a "posare in grembo a Gesù
la nostra testa di socialisti". I
quaresimali suscitarono per anni,
almeno fino alla prima guerra mondiale, veri scontri
anche fisici (come avvenne il 2 aprile
1904) con giovani cattolici e
clamorosi contraddittori con Guido Zadei e altri. Temuto dai cattolici che
lo chiamavano "el diaol sòp", per la sua andatura claudicante e per la
barbetta, la sua conversione, alla quale contribuì la stima e la
conoscenza con mons. Angelo Zammarchi (nel quale
scorse, come ebbe a scrivere il figlio
Gherardo "il modello esemplare della sua stessa vita, insieme con il valore
dello scienziato e
dell'intemerata coscienza del credente, che
erano in lui"), e la pubblica professione di fede non potè non suscitare
vivo clamore. Le dure prove subite nella I guerra mondiale con il sacrificio
del figlio Bruno (v.), e, nel
1925, la morte del figlio Ugolino (v.) per i postumi
della guerra, lo allontanarono sempre più
dal socialismo
rienze,
ostensione di materiali da lui stesso raccolti e
con frequenti gite scientifiche, sempre
instancabile ed appassionato,
sempre in grado di illustrare con profonda competenza ogni aspetto naturale
delle nostre contrade". Tale
passione e competenza travasò in una vasta divulgazione
attraverso «numerosi articoli popolari disseminati su giornali e riviste; le
frequenti conferenze scientifiche
e talora anche letterarie e filosofiche; tenute a Padova, a Brescia, a
Milano ed altrove, oltre ad attestare la sua
notevole cultura generale e speciale, dimostrano un'alta
serietà e nobiltà d'intenti. Egli, scrive il Giacomini, seppe sempre evitare
ogni facilità giornalistica quando trattava,
sia pur in forma popolare, di argomenti scientifici. Talora
è perfino difficile distinguere alcuni di questi suoi scritti
minori dalla produzione scientifica propriamente detta,
perché contengono spesso dati originali, che poi non ebbe
occasione di svolgere in, sede più appropriata».
Incominciò ancora studente nel 1876 a collaborare a la
"Vedetta!' di Macerata per passare poi nel 1882^1883 al
"Corriere della Sera", "Confessioni di un Naturalista"
che per lo stile immaginoso ed originale fecero pensare a lui come ad un
nuovo Mantegazza. Continuò poi con
resoconti di passeggiate naturalistiche dal 1896 al 1897 su "Adolescenza",
dal 1895 su "La Provincia di Brescia" per
collaborare nel 1926 al "Popolo di Brescia" e a "Scuola
Italiana Moderna". Come ha sottolineato il Giacomini,
Ugolini fu
scienziato nel vero termine della parola e
non soltanto «uno specializzato nel,
campo botanico, ma un naturalista
completo, che sapeva intrattenere sui più svariati argomenti, portando
spesso il contributo di sue
personali osservazioni ed esperienze. Riusciva così insegnante veramente ideale ed esemplare unendo al prestigio
di una preparazione vasta e profonda la
stessa autorità di un nome sempre più noto nel campo della scienza
pura ed applicata». Come uomo di scienza
lasciò lavori di scrupolosa
accuratezza e precisione, per la sobrietà
veramente scientifica e la documentazione
bibliografica sempre completa, che il Giacomini classifica in quattro principali
serie: "sistematica", "fitogeografica", "biologica" e "storico
umanistica".
Nella serie sistematica si è distinto fra i più valenti conoscitori della
flora delle Prealpi venete (specie padovana),
trentine, del Canton Ticino e delle Marche e soprattutto delle bresciane cui
dedicò il nucleo dei lavori floristici,
attraverso i quali si propose, come rileva il Giacomini, "di
preparare una nuova Flora Bresciana che aggiornasse il
vecchio Prospetto dello Zersi. A tale scopo si accinse ad
una esplorazione metodica del territorio. I sette Elenchi di piante nuove o
rare nel Bresciano, pubblicati tra il 1898 e
il 1910, segnano con straordinaria evidenza il progresso
della Sua maturità sistematica: da semplici elenchi di
piante e di località, divennero gradatamente sempre più
ricchi di osservazioni morfologiche, sistematiche, biologiche
e fitogeografiche". Dedicò particolare, attenzione
alle piante avventizie e arboricole, con ricerche le più
particolareggiate alla Poa silvicola Guss (1919 e 1929), alla
Campanula elatinoides Moretti e alla Hemerocallis flava L.
Sostenne il yicarismo della Campanula pyrami-dalis
L.
con VAdenophora liliifolia Bess (1928), segnalò
l'apparizione della bella Campanula pyramidalis su un
masso del Sabotino al Vittoriale degli italiani (1926).
Sono ricordate inoltre le sue osservazioni sul Nasturtium
austriacum
(1922).
Nella serie fitogeografica dedicò importanti lavori alla vegetazione della
Valtrompia (1896) e della Valsabbia
(1901)
segnalandosi, come
sottolinea
il
Giacomini, come "osservatore acuto ed
intelligente interprete degli aspetti essenziali di un paesaggio botanico".
Lo stesso Giacomini rileva ancora
più originali ed importanti le due note preliminari sulla vegetazione degli
anfiteatri morenici (1899 -1900)
che diedero "un impulso notevole
ad analoghi studi geobotanici sulle relazioni tra terreni e
vegetazione".
La serie biologica tesa a studiare le piante non soltanto per
scopo sistematico o flogistico, ma soprattutto come organismi
viventi, venne dall'Ugolini considerata "l'espressione
più elevata e completa della sua opera naturalistica".
Al Bresciano dedicò il nucleo dei suoi lavori floristici
puntando l'attenzione sui fenomeni periodici della vegetazione nel corso
dell'anno con particolare riguardo
al risveglio autunnale (fioriture "secondarie" autunnali),
alle forme di stagione ("dimorfismo stagionale"), ai relitti
di stagione (1903 e 1904), alla "vita iemale delle piante"
(1906), studiando l'accrescimento giornaliero invernale
di un certo numero di piante e mettendo in evidenza il
diverso comportamento di vari tipi di vegetazione durante
l'inverno. Il Giacomini tuttavia considera "ben poca cosa
(i lavori biologici) in confronto alla mole dei dati e dei materiali
raccolti in quaranta anni di osservazioni sulla
flora bresciana, attraverso il piccolo orto botanico sperimentale
che egli realizzò nel suo giardino sulla salita di S.
Desiderio e il suo ricco e originale Erbario che passò quasi
integralmente all'Istituto botanico di Padova al quale
cedette anche l'Erbario di guerra del figlio Bruno.
L'ultima produzione scientifica dell'Ugolini venne dedicata
ad una serie di studi storico umanistici su antichi erbari da lui
rintracciati e ad una presunta cattedra pliniana
in Brescia agli inizi del '500. Infine completando l'opera
del Venturi ("I miceti dell'Agro bresciano") compilò un
elenco di 28 specie di funghi mangerecci, ripartite in
sette famiglie.
Notevole anche il suo impegno in campo sociale e politico
fin dagli anni giovanili. Giunto nel 1894 a Brescia,
si dedica
subito alla promozione di una scuola serale,
di una biblioteca circolante, di corsi di
conferenze nell'ambito dei
partiti di sinistra e della Camera del Lavoro. Milita nel Partito
Socialista e dal 1902 al 1910 entra nel
Consiglio del Comune di Brescia battendosi per la
costruzione di case popolari e si impegna
decisamente contro l'introduzione del catechismo nelle scuole; nel
1903 sostiene con Giorgio Montini una
vivace polemica sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici. È attivo
anche nel Consiglio Provinciale e inoltre
è diligente commissario del Pio Luogo Zitelle. Il 13 luglio 1912 aderisce
alla sezione bresciana del
Partito socialista riformista e collabora a "La Provincia di
Brescia". Positivista e anticlericale,
rifiutato il soprannaturale, si
attaccò alla "religione della natura" indicando in essa
una "divinità tangibile" e come "fonte
reale" dalla quale trarre "ogni sorta di benefizi" e dalla quale "temere i
più grandi, mali” tenendo come la
religione della natura "la più
ragionevole". Vera ammirazione ebbe però sempre
per Gesù Cristo così da tenere per anni,
durante la settimana santa, dei
"quaresimali" o "conferenze pasquali"
nei quali esaltava il "mito" di Cristo
povero per i poveri, invitando i compagni a "posare in grembo a Gesù
la nostra testa di socialisti". I
quaresimali suscitarono per anni,
almeno fino alla prima guerra mondiale, veri scontri
anche fisici (come avvenne il 2 aprile
1904) con giovani cattolici e
clamorosi contraddittori con Guido Zadei e altri. Temuto dai cattolici che
lo chiamavano "el diaol sòp", per la sua andatura claudicante e per la
barbetta, la sua conversione, alla quale contribuì la stima e la
conoscenza con mons. Angelo Zammarchi (nel quale
scorse, come ebbe a scrivere il figlio
Gherardo "il modello esemplare della sua stessa vita, insieme con il valore
dello scienziato e
dell'intemerata coscienza del credente, che
erano in lui"), e la pubblica professione di fede non potè non suscitare
vivo clamore. Le dure prove subite nella I guerra mondiale con il sacrificio
del figlio Bruno (v.), e, nel
1925, la morte del figlio Ugolino (v.) per i postumi
della guerra, lo allontanarono sempre più
dal socialismo ![]() per
portarlo su posizioni nazionaliste e addirittura così
decisamente fasciste da chiedere di essere sepolto con
la camicia
nera. Lasciata nel novembre 1926 la
scuola, dopo 40 anni di insegnamento, con i saluti più cordiali del prof. Vincenzo
Lonati e dell' on. Alfredo Giarratana,
continuò nella ricerca
scientifica e nell'attività di divulgatore, partecipando a
congressi importanti come quelli di Milano e di Trento:
Partecipò attivamente al Gruppo
Ragazzoni e ad altre associazioni. Né gli mancarono riconoscimenti. Socio
aggregato dell'Ateneo di Brescia
fin dal 1900 ed effettivo il 17
febbraio 1907 fu iscritto all'Accademia dei Lincei e ad altre accademie
scientifiche quali la Società Botanica
Italiana efu vice presidente della
Sezione Lombarda della medesima; fu anche socio corrispondente dell'Accademia
di Agricoltura, Scienze e Lettere di
Verona (dal 1924). I lavori citati nella bibliografia per gli anni
1904,1905, 1906, furono presentati
dall'Ugolini alla R. Accademia
dei Lincei e gli valsero l'assegnazione di uno dei cinque
primi premi del Ministero della Pubblica
Istruzione per le Scienze Naturali nel 1906.
per
portarlo su posizioni nazionaliste e addirittura così
decisamente fasciste da chiedere di essere sepolto con
la camicia
nera. Lasciata nel novembre 1926 la
scuola, dopo 40 anni di insegnamento, con i saluti più cordiali del prof. Vincenzo
Lonati e dell' on. Alfredo Giarratana,
continuò nella ricerca
scientifica e nell'attività di divulgatore, partecipando a
congressi importanti come quelli di Milano e di Trento:
Partecipò attivamente al Gruppo
Ragazzoni e ad altre associazioni. Né gli mancarono riconoscimenti. Socio
aggregato dell'Ateneo di Brescia
fin dal 1900 ed effettivo il 17
febbraio 1907 fu iscritto all'Accademia dei Lincei e ad altre accademie
scientifiche quali la Società Botanica
Italiana efu vice presidente della
Sezione Lombarda della medesima; fu anche socio corrispondente dell'Accademia
di Agricoltura, Scienze e Lettere di
Verona (dal 1924). I lavori citati nella bibliografia per gli anni
1904,1905, 1906, furono presentati
dall'Ugolini alla R. Accademia
dei Lincei e gli valsero l'assegnazione di uno dei cinque
primi premi del Ministero della Pubblica
Istruzione per le Scienze Naturali nel 1906.
Pubblicazioni.
Nota sull'accartocciamento delle foglie
secche,
«Boll. Soc. Ven. Tren. Se. Nat.», Padova, 1881
(estr. p.
1-20). La costruzione e lo studio dei poligoni
cranici,
«Boll. Soc. Ven. Trent. Se. Nat.», Padova, 1881
(estr. p. 1-12). Nota di anomalie nel
cranio deimammiferi,
«Boll. Soc. Ven. Trent. Se.
Nat.», Padova, 1881 (estr. p.
1-9). La cassa ossea del cervello studiata analiticamente
in alcuni crani di scimmia,
«Atti Soc. Ven. Trent. Se. Nat»,
Padova, 1882 (estr. p. 1-131 con fig. e carte).
La vegetazione del Globo,
Cap. I del voi. II dell'opera
«La Terra» di G. Marinelli, Milano,
Vallardi edit., 1885, p. 1-45 con fig. e carte. Morfologia vegetale,
descrizione popolare della
forma e struttura delle piante,
Milano, Vallardi-edit., 1892, p. 1-305, fig. 345. Ree. in F. A.
Flueckiger in «Chemische Zeitung», 17
mai 1893. Un altro
nemico della Vite (Antispila
Rivillei Staint), Rivista «Il Raccoglitore», Padova, 1893 (estr. p.
1-7). Sulla Flora della Valtrompia: note di Geografia Botanica,
Comment. dell'Ateneo di Brescia pel
1896. Brescia, 1896 (estr. p. 1-21). Riass. in «Annuario Scient.-Industr. pel 1896»,
Milano, 1897. Passeggiate naturalistiche,
«L'Adolescenza», n, n. 50 (12 die. 1897), Milano, Val-lardi edit.,
1897. Contributo allo studio della Flora Bresciana, programma di studi,
elenco di piante del Bresciano aggiunte
al Prospetto Zersi e quadri statistico-tassonomici della flora bresciana,
Comment. dell'Ateneo di
Brescia pel 1897, Brescia, 1898 (estr. p. 1-62). (Anche
col titolo: Contributo allo studio
della flora bresciana
compreso Primo Elenco di piante nuove o rare pel Bresciano).
Ree. di G. Crugnola in «N. Giorn. Bot.
Ital.», 2 apr. 1901. Nota di
specie e varietà nuovej>el Veneto e
segnatamente pel Padovano,
«Malpighia», XI, 1897, p.
554-560, Genova, 1898. Secondo Elenco
di piante nuove o rare pel
Bresciano, Comment. Ateneo di
Brescia pel 1899, Brescia, 1899
(estr. p. 1-5). Ree. di G. Crugnola in «N. Giorn. Bot. Ital.», 2 apr.
1901. Nota preliminare sulla flora
degli anfiteatri morenici del Bresciano con
speciale riguardo al problema delle
glaciazioni, Comment. dell'Ateneo di Brescia pel 1899, Brescia, 1899
(estr. p. 1-16). Riass. in «Annuario
Scient-Industr. pel 1899»,
Milano, 1900. Ree. di E. De Toni in «Riv. Ateneo
Veneto», II, 1899; di C. Errerà in «Riv. Geogr.. Ital.»,
1900; in «Riv. Ital. Se. Nat., gen.-feb.
1900. Terzo Elenco di piante nuove o rare pel Bresciano,
Comment. dell'Ateneo di Brescia pel
1900, Brescia, 1901 (estr. p.
1-8). Ree. di G. Crugnola in «N. Giorn. Bot. Ital. », 2 apr.
1901. Esplorazioni botaniche in
Valsabbia, Comment.
dell'Ateneo di Brescia pel 1901, Brescia, 1901 (estr. p.
1-59). Ree. di E. De Toni in «Riv.
Ateneo Veneto», 1902; di V. Alpe
in «L'Agricoltura Moderna», Milano, 9 mar.
1902. Appendice alla flora degli anfiteatri morenici,
Comment. dell'Ateneo diBrescia pel 1901,
Brescia, 1901 (estr. p. 1-7). Ree.
di G. Crugnola in «N. Giorn. Bot.
Ital.», 2 apr. 1901. Quarto Elenco di piante nuove o rare
pel Bresciano,
«Comment. dell'Ateneo di Brescia pel
1902», Brescia, 1902 (estr. p. 1-15). Ree. di E. De Toni
in «Riv. Ateneo Veneto», 1902. La
galenica dell'Olmo, «L'Italia Agricola», Piacenza, 15 apr. 1902.
Osservazioni su gelsi
colpiti dalla gelata, 19-20
apr. 1903, «Giornale delle
Istituzioni Agrarie Bresciane», n. 12-13 (1903),
Brescia, 1903 (estr. p. 1-12). Elenco
descrittivo dei Funghi mangerecci della Provincia di Brescia,
Ibid., n. 16-17
(1903), Brescia, 1903 (estr. p. 1-11). Nota botanico-agraria
sulle forme di stagione delle piante,
Ibid., n. 24
(1903), Brescia, 1903 (estr. p. 1-7). Riass. in «Annuario Scient.-lndustr.
pel 1903», Milano, 1904 (p. 225). Ifenomeni
periodici delle.pìante bresciane (Risveglio autunnale
della vegetazione e relitti di stagione. Forme di
stagione),
«Comment. dell'Ateneo di Brescia pel
1903», Brescia, 1904 (estr. p. 1-21). Nota preliminare sui fenomeni
della fioritura nelle piante bresciane,
«Comment.
dell'Ateneo di Brescia.pel 1904»,
Brescia, 1905 (estr. p. 1-13). Quinto Elenco dipiante nuove o rare pel
Bresciano, con
osservazioni morfologico-sistematiche e biologiche
su alcune specie, «Comment.
dell'Ateneo di Brescia pel
1904», Brescia, 1905 (estr. p. 1-28). Saggio di
studi sulla vita iemale delle piante,
«Comment. dell'Ateneo
di Brescia pel 1905», Brescia, 1906 (estr. p. 1-51).
Riass. in «Annuario Scient-Industr. pel
1906», Milano, 1907
(p. 307). Curiosità della flora
bresciana: la margheritana grande (Chrysanthemum amplifolium Fiori),«Illustrazione
Bresciana», V, n. 72, p. 7-8 (16 ag. 1906),Brescia,
1906. Contributo, alla flora arboricola della
Lombardia e del Veneto: cenni
preliminari ed elenco delle specie arboricole,
«Comment. dell'Ateneo di Brescia pel
1905», Brescia, 1906 (estr. p. 1-19).
Ree. di A.Béguinot
in «Bull. Soc. Bot. Ital.», 1906, p. 131.
Secondo
contributo alla fionda arboricola della Lombardia edel
Veneto. (Nuovo elenco di ospiti e di arboricole),«Commenti
dell'Ateneo di Brescia pel 1907», Brescia,
1908
(estr. p. 1-8). Sesto Elenco di piante nuove o rare
pel Bresciano, con copiose note
illustrative morfologico-sistematiche,
fitogeografiche e biologiche,
«Comment.dell'Ateneo
di Brescia pel 1907», Brescia, 1908 (estr. p.1-42).
Riass. in «Annuario Scient-Industr. pel 1908»,Milano,
1909. Sugli organi rudimentali: osservazioni
critiche ad una comunicazione dip. A.
Gemelli all'Ateneo di Brescia, «Comment
dell'Ateneo di Brescia pel 1908»,
Brescia, 1908 (estr. p. 1-2). La
Kochia trichophylla inselvatichita nel Bresciano, «Bull. dell'Ateneo
Soc. Bot Ital.», 1909 (Proc. verb.
p. 191), Firenze, 1909. Settimo
elenco di piante nuove o rare pel
Bresciano con copiose note
illustrative morfologico-sistematiche, fitogeografiche
e biologiche. Parte I:
dalle Ranuncolacee alle Ombrellifere p.p. «Comment
dell'Ateneo di Brescia pel1909-1910»,
Brescia, 1910(estr.p. 1-16). Nota botanico-geologica
sui rapporti fra la vegetazione ed il suolo,
«Comment. dell'Ateneo di
Brescia pel 1912», Brescia,1912
(estr. p. 1-21). Riass. in «Annuario Scient.-lndustr.Pel 1912», Milano, 1913 (p. 259). Sulla Campanulaelatines
L. e C. elatinoides Moretti nelle Alpi centrali:nota preventiva,
«Boll. Soc. Bot. Ital.», Adun. Genova
19 ottobre 1912, p. 825-6,
Firenze, 1912. La vegetazione
di un lembo morenico in rapporto colla
natura del suolo:nota
botanico-agraria, Consorzio
Antifillosserico Bresciano «Il
territorio dei comuni di Portese e S. Felice diScovolo ecc.», Brescia,
Lenghi ed., 1912 (estr. p. 1-7).Varietà
e forme nuove di piante e cause probabili della
loro origine (transunto),
«Atti Soc. Ital. per il Progr.
delle Scienze», VI Riun. (1912), p. 826,
Roma, 1913. Sulla flora della
pianura bresciana, «Atti.
Soc. Ital. Progr. Scienze», Riun. VI (1912), p. 827, Roma, 1913.
Forme cavernicole di Scolopendrium vulgare Sm. e loro
rapporti con S. hemionitis Sw: nota
preventiva, «Boll.
Soc. Bot. Ital.», 1913 (Proc. verb. p.
117), Firenze, 1913. Curiosità
della flora bresciana.,Noie, sulla Fenologia
dell'Ippocastano. Divergenze individuali
nelle fasi della vita, «Brixia», 25 aprile 1915, n.38. Brescia
1915. La guerrafra le piante,
«Brixia», 25-VH-1915, 8-VHI-1915,
15-VHI-1915, Brescia, 1915.
Una novità zoologica del
Bresciano. «Brixia», 28 marzo
1915. Avventizie esotiche
della flora bresciana,
« Bull. Soc. Bot. Ital. », 13 gen.
'1917 (Proc. verb. p. 2),
Firenze, 1917. La Poa silvicola
Guss. nel Veneto e nella Lombardia ed i
suoi rigonfiamenti basali, «Acc. Scienze Lett. ed Arti di
Padova» XXXV, p. 311 (1919), Padova,
1919. Ree. di A.. Fiori «Bull. Soc. Bot. Ital.», 1920, p. 10. Due
casi nuovi di felci in pianura,
«Bull. Soc. Bot. Ital. », 13 die.
1919, p. 64, Firenze, 1919.
Contributo alla flora delTìrolo Cisalpino
(ValPusteria edAmpezzano), «N.
Giorn.
Bot. Ital.»,
n. s., XXVH, 2-4 (1920), p. 251-261, Firenze, 1920. Ree.
in R. Wettstein «Oest. Bot.
Zeit», Wien LXX Jg. 1921.
Le felci in
pianura,
«Atti Soc. Ital.
per il Progr. delle Scienze», XI Riun.
(1921), p. 648, Roma, 1921. Le piante
avventizie della flora bresciana. (Censimento e dati sulla
provenienza, introduzione, diffusione e biologia
delle varie specie; Parte I: Cenni
introduttivi — Gimno-sperme
e Monocotiledoni—Avventizie
esotiche), «Com-ment.
dell'Ateneo di Brescia pel 1920»,. Brescia, 1921 (estr. p. 1-51). Ree. di A.
Béguinot in «Relaz. Annuale Istit. Bot. di Padova», 1921. Un episodio
della flora di guerra
(Saggio sul Nasturtium austriacum in Italia),
«La
Provincia» di Brescia, 12-VH-1922 (estr.
p. 1), Brescia, 1922.
Addenda et emendando adfloram italicam,
«Bull. Soc. Bot. Ital.», ott. 1921-apr.
1922, Firenze, 1922 (estr.
p. 1-3). Su quattro avventìzie della flora italiana: Lepi-dium virginicum,
Lepidium densìflorum, Matricaria di-scoidea,
Artemisia Verlotorum,
«Bull. Soc. Bot: Ital.», n. 1-2, gen.-feb. 1923, Firenze, 1923. Di una
pretesa cattedra
Pliniana a Brescia nei primi anni del secolo XVI.
(Contributo ai rapporti tra l'Umanesimo e la Scienza),
«Comment. dell'Ateneo di Brescia pel 1922», p. 167-244,
Brescia, 1923. Il Botanico ab. Porta, «La Provincia» di
Brescia, 26-VI-23, Brescia, 1923. Il Botanico G. B. De
Toni,
«La Provincia» di Brescia, 3-DC-24, Brescia, 1924.
Piante non comuni raccolte a Sirmione,
«Annuario del
R. Liceo Scientifico "A. Calini" di Brescia», anno 1923-24,
1924-25,_Btescia, 1925; e in «La Provincia» di
Brescia, 3-V-1924, Brescia, 1925 (estr.
p. 1-3). Un grande
cimelio botanico bolognese: l'Hortus siccus Florae
Italicae di Antonio Bertoloni,
«Atti Soc. Ital. per il Progr.
delle Scienze», XV Riun. (1926), p. 733,
Roma, 1926. La pianta miracolosa del masso del Sabotino al Vittoria-le
di Gabriele d'Annunzio, «Il
Popolo di Brescia», 25-VIII-26,
Brescia, 1926 (estr, p. 1-6). Un erbario bresciano del
1623. 1: Storia e descrizione dell'Erbario. L'Autore e la data. L'estensore
dei Semplici Giovanni Prèvot. Significati
ed importanza dell'Erbario, «Comment.
dell'Ateneo di Brescia pel 1926 », Brescia, 1927
(estr. p. 1-23). Un Erbario bresciano
del 1623: II: Composizione e disposizione del materiale
dell'Erbario. Schema dell'elenco delle
specie e citazioni abbreviate. Elenco ragionato delle piante
dell'Erbario Richiedei, «Comment.
dell'Ateneo di Brescia pel 1927», Brescia,
1928 e 1934 (estr. p. 1-13). Indicazioni erronee o dubbie
della Campanula pyramidalis L. per il Bresciano, la
Valtellina, il Trevigiano e la Savoia, e
suo vicarismo con l'Adenophora liliifolia Bess.
«N. Giorn. Bot. Ital.», n. s., XXXTV, p. 1224-1245, Firenze, 1928. La
Poa silvicola Guss. in Svizzera e in Francia, «N. Giorn. Bot. Ital.», n.
s., XXXVI (1929), p. 392, Firenze,
1929. L'Erbario di
guerra di mio figlio capitano Dott. Bruno, caduto per la
Patria,
«N. Giorn. Bot. Ital.», n. s., XXXVII
(1930), p. 684, Firenze, 1930.
Note illustrative su alcune piante
raccolte in Canton Ticino e in Val
Poschiavo, «Boll. Soc
Ticinese Se. Nat», XXHI (1928), p. 82 e XXTV (1929)]
p. 33, Lugano, 1930 (estr. p. 1-31).
Fionda del Monte Baldo in
un Erbario veronese del 1675,
«N. Giom. Bot Ital.», n. s.,
XXXVH (1930), 686, Firenze, 1930. Un Erbario
composto nel 1623 con piante dell'Orto dei Semplici di Padova, «N.
Giorn. Bot. Ital.», n. s., XXXVn
(1930), p. 685, Firenze, 1930. Contributo alla flora litoranea
e collinare delle Marche (Pesaro e Gabicce) e
delle Romagne (Cattolica),
«N. Giorn. Bot. Ital.», n. s., XXXVTfl
(1931), p. 563, Firenze, 1931. La flora della
guerra,
«N. Giorn. Bot. It», n. s., 1931, p. 561, Firenze,
1931. Paesi dei nuovi confini e il
loro apporto alla flora
italiana con particolare riferimento a quellafriulana,
«N.
Giorn. Bot. Ital.», n. s?, XXXVIII
(1931), p. 562, Firenze, 1931.
Imiei qiXarant'anni di osservazioni ed esperienze
sulle forme e sulla vita delle piante.
Nuovo contributo alle piante avventizie della flora italiana. (Due note riassuntive),
«N. Giorn. Bot. Ital.», n. s., XXXIX (1932), p.
702-705, Firenze, 1933. Un Erbario bresciano del 1623. Ili: Elenco
nominativo delle piante dell'Erbario, «Comment. dell'Ateneo di Brescia ». Brescia, 1934 (estr. p.
1-9). Una stazione lombarda dell'Hemerocallis
flava L. e presentazione
di altre piante del Bresciano,
«N. Giorn.
Bot. Ital.», n. s. (1937), p. 621.
Firenze, 1937. Oltre a questi
lavori di carattere più schiettamente scientifico, il Giacomini ricorda pubblicazioni divulgative o di
recensione: a) Rassegne di Storia
Naturale: nell'Annuario
Scientifico-industriale dei Fratelli Treves, Milano, dall'anno
1895 in poi; b) Conferenze e Discorsi: pubblicati
su «Cronache del Rinascimento etico-sociale», Venezia,
1898, su «La Provincia di Brescia», dal
1899 in poi, su «Il Gazzettino»
(1894 e 1900), su «Il cittadino» (1909),
su «L'Euganeo» (1886), su «É Popolo di
Brescia», ecc.; e) Relazioni
di escursioni scolastiche: su «L'Euganeo»
(1885-1886), su «Il Veneto» ( 1893), e
per ciò che riguarda la provincia di Brescia specialmente sul quotidiano «La Provincia di
Brescia» degli anni 1895,1896,1899,1901, 1908,1909,1911,1912, ecc; d)
Scritti scientifici di divulgazione:
su «La Vedetta» di Macerata
(1876 e 1880), su «L'Euganeo» di
Padova (1878 fino al 1887), sul «Corriere
della Sera» (1882-1886), su «La Provincia di Brescia»
(1895 e segg.), sull' «Illustrazione
Italiana» (1882-1883), su «La
Natura» (1883), su «Natura ed Arti» (1894-1897),
su «Adolescenza» (1895-1897), su
«Illustrazione Bresciana» (1906), su «Brixia», su «Il Popolo di Brescia»,
su «Scuola Italiana Moderna», ecc.; e
riduzioni di opere scientifiche e
traduzioni varie, nonché pubblicazioni di
carattere economico-amministrativo.
Sugli studi, le ricerche, le opere dello scienziato ha curato una tesi universitaria Caterina Ricci. Cliccando qui sotto potrete leggere l'interessante studio.