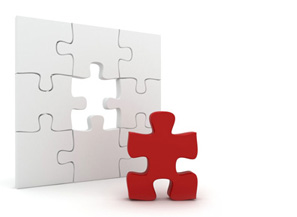

Trauma e memoria: dissociazione
Cos'è la psicotraumatologia
|
|
Pubblicazioni on-line
|
|
Congressi e Formazione
|
|
Bibliografia
|
|
Consulenze gratuite
|
|
| [Sezione per addetti ai lavori]
Il termine dissociazione, traduzione inglese da parte di William James dell'originale termine "desagregation" proposto da Pierre Janet nel 1889 (Lapassade, 1996), è stato per decenni utilizzato solo relativamente alla frammentazione dell'esperienza propria delle psicosi. In origine si riferiva, invece, alla concezione della mente umana come naturalmente frammentata, tale per cui il naturale senso di individualità proprio dell'uomo sarebbe l'esito di un'attività sintetica della mente (Lapassade, 1996). Quello che oggi viene chiamato "modello traumatico" di Janet prevede che il senso dell'unitarietà della persona risulti alterato dall'incontro con esperienze traumatiche che producono stati mentali e parti della persona dissociate (Bremner, Marmar, 1998). La riscoperta del modello traumatico e con esso del concetto di dissociazione ha comportato l'impiego di esso in una tale varietà di contesti che, per alcuni autori, è diventato inutilizzabile (Carlson, Dalemberg, 2000). Nella sua accezione più ampia il termine dissociazione «significa semplicemente che due o più processi o contenuti mentali sono non associati o non integrati. Solitamente si assume che questi elementi dissociati dovrebbero essere integrati nella consapevolezza cosciente, nella memoria e nell'identità» (Cardeña, 1994). Di taglio differente l'interpretazione di Briere, che intende per dissociazione ogni esclusione a scopo difensivo di materiale disturbante (Berliner, Briere, 1999), e similmente Nemiah (1991) propone che la dissociazione si riferisca ad una «esclusione dalla consapevolezza ed alla inaccessibilità al recupero volontario degli eventi» (da Lyn, Rhue, 1994). In queste ultime accezioni, però, una quantità di processi mentali i più diversi sarebbero tutti nominati con lo stesso termine, escludendo anche la possibilità, nella concezione di Briere, che si possano originare fenomeni dissociativi anche in assenza di scopi difensivi, per esempio in coincidenza di gravi traumi che travolgono le capacità di modulazione delle emozioni, ovvero per motivazioni strettamente psicobiologiche. Sono stati dati molti altri significati alla dissociazione che, seguendo Cardeña (1994), possiamo riassumere nel modo seguente: 1. Per caratterizzare sistemi o moduli mentali semi-indipendenti che non sono accessibili consapevolmente e/o non sono integrati all'interno della memoria cosciente, dell'identità e della volizione:
2. Come una modificazione della coscienza, dove l'individuo o alcuni suoi aspetti diventano disconnessi o disinnestati l'uno dall'altro, in un modo simile a come la dissociazione viene intesa dal DSM-IV: «Alterazione marcata delle funzioni usualmente integrate della coscienza, memoria, identità o percezione dell'ambiente. L'alterazione può essere improvvisa o graduale, transitoria o cronica» (American Psychiatric Association, 1994). 3. Come meccanismo di difesa In questa sede si intende per dissociazione anche quanto prodotto con tecniche ecologiche di modulazione della coscienza (trance ipnotica, meditazione, dilatazione transpersonale della coscienza, etc.): può essere incrementata la separazione e la dis-integrazione fra moduli di elaborazione delle informazione e di emissione comportamentale. In questi casi, però, la "dissociazione" non viene prodotta da emozioni fortemente disturbanti, soverchianti la capacità di modulazione delle emozioni, o come strategia di difesa verso emozioni disturbanti, o da alterazioni biochimiche patologiche, ma si tratta della modificazione del normale funzionamento settorializzato della mente umana, che viene modificato, amplificato, modificato, ma in modo ecologico e reversibile, anche quando ci consente di sperimentare l'illusorietà del senso di coesione del Sè (Varela, Thompson, Rosh, 1991). Questa concezione di dissociazione non include i fenomeni spontanei o ecologici di apparente dissociazione, quelli in cui parti modulari della mente gestiscono con perfetta efficienza comportamenti umani, apparentemente senza alcuna volizione, come nel consueto esempio della guida in automobile con il "pilota automatico", mentre altre parti della mente si occupano di tutt'altro; in quest'ottica, per esempio, tutto il comportamento motorio automatizzato sarebbe dissociato. In sintesi, l'apparente dissociazione delle attività elaborative ed esecutive dell'uomo è il normale modo di funzionamento, abitualmente parzialmente occultato da un illusorio senso del sè. La dissociazione è invece un'alterazione di questo abituale funzionamento (con la conseguente alterazione del senso di continuità del Sè nel tempo e nello spazio) causato da alcuni titpi di situazioni: 1) situazioni traumatiche che sopraffanno le capacità attentive, elabarative e di modulazione delle emozioni; 2) stati modificati di coscienza, autoiondotti o eteroindotti, prodotti in modo ecologico o con sostanze tossiche. 3) è possibile che modificazioni autoindotte dello stato di coscienza possano essere prodotte al fine di segregare in unità mentali scisse parte dei ricordi, sotto forma di sensazioni, emozioni, cognizioni, schemi di comportamento, che possono assumere la configurazione di sottopersonalità relativamente indipendenti dal resto della persona (Watkins, Watkins, 1997). Al fine del mantenimento di tali dissociazioni possono contribuire anche meccanismi di repressione e di evitamento e, in generale, meccanismi di esclusione delle informazioni. Il senso di coesione del Sè appare allora una realtà all'interno delle consuete coordinate spazio-temporali, ed all'interno di consueti equilibri biochimici. Attraverso l'impiego di particolari dispositivi come la meditazione vipassana, che incrementano enormemente la capacità attentiva e dilatano la consapevolezza, il Sè appare quindi come assolutamente discontinuo, una frammentazione assoluta cementata dal senso, insostanziale, di sostanzialità del Sè. Anche la percezione di un "osservatore nascosto", deus ex machina decaduto dell'attività mentale, viene colto nella sua intrinseca insostanzialità, frammentarietà ed illusorietà (Giannantonio, Pennati, 1995; Varela, Thompson, Rosh, 1991; Welwood, 1979; Wilber, Engler, Brown, 1986) Questa posizione si discosta rispetto ad una delle più diffuse concezioni sulla dissociazione, ovvero che esista un continnum sulla dimensione dissociativa. è però vero che alcuni autori dubitano sull'esistenza di questo continuum, e che fra la dissociazione dei Disturbi Dissociativi o di altre patologie sembra esistere una differenza qualitativa rispetto alla dissociazione della vita di tutti i giorni (Ray, 1996; Vanderlinden, van der Hart, Varga, 1996). |
| Aggiornamento: Febbraio 2010 |