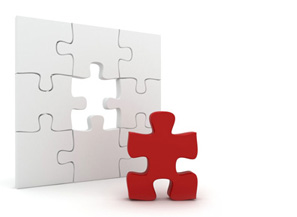

Fenomenologia dei ricordi traumatici
Cos'è la psicotraumatologia
|
|
Pubblicazioni on-line
|
|
Congressi e Formazione
|
|
Bibliografia
|
|
Consulenze gratuite
|
|
| In che modo una persona traumatizzata ricorda il suo o i suoi
traumi?
Non esiste un unico modo in cui si presentino i ricordi, ma ci sono diverse modalità caratteristiche di ricordare eventi traumatici. Infatti, il modo in cui i ricordi traumatici si presentano ad una persona variano in funzione delle diverse componenti del ricordo che, in qualche modo, risultano inadeguate e comunque diverse rispetto al nomale modo di ricordare. Se, ad esempio, noi ricordiamo un evento molto piacevole non troppo lontano nel tempo, ad esempio le ultime belle vacanze al mare, ricorderemo qualcosa come alcune immagini, la sensazione del calore del sole o dell'acqua sulla pelle, il profumo del mare o di qualche specialità gastronomica del posto, l'emozione che ci dava l'essere lì, quello che abbiamo fatto, ed esprimiamo dei commenti e delle valutazioni sulle vacanze stesse: in poche parole, in poco tempo abbiamo libero accesso al ricordo nelle sue componenti sensoriali, emotive, comportamentali, immaginative, di significato. Ogni componente del nostro ricordare, inoltre, risulta chiaramente amalgamata ed in sintonia con le altre. In presenza di ricordi traumatici, invece, la libera compresenza armonica di sensazioni, immagini, comportamenti, emozioni e significati, non è possibile [si tratta del SIBAM model di Levin, 1991, 1994] ma si ha a che fare con una grande variabilità nel modo in cui queste componenti o il loro rapporto reciproco sono alterate rispetto all'abituale modo di ricordare. Alcune modalità sono le seguenti: 1. Innanzitutto le emozioni possono essere peculiari: alcuni ricordi sono così carichi emotivamente tanto che è impossibile parlarne anche dopo anni di psicoterapia, oppure risultano essenzialmente impermeabili ad ogni tentativo di rielaborazione verbale. Possono esserci ricordi estremamente intrusivi, ripetitivi, sempre uguali a sè stessi da anni, che non sembrano risentire di un approccio verbale, specialmente se ciò che si ripresenta alla memoria è sovraccarico di emozioni e non è esprimibile in parole, come sensazioni viscerali o frammenti sensoriali dei ricordi, la materia prima di cui paiono essere costituiti i ricordi altamente traumatici (Levin, Lazrove, van der Kolk, 1999). 2. Alcuni meccanismi di fesa della nostra mente [Meccanismi dissociativi e di esclusione delle informazioni] possono condurre alle seguenti situazioni:
3. La presenza di ricordi traumatici di originerelazionale si può anche manifestare attraverso particolari dinamiche relazionali all'interno del rapporto terapeutico. Le esperienze di trascuratezza emotiva e di abuso nelle loro molteplici sfaccettature posso produrre modalità relazionali distorte che, in modo automatico, possono, ad esempio, portare il paziente alla manipolazione del rapporto terapeutico così da riprodurre un'ulteriore vittimizzazione del paziente stesso, oppure abbandono, rifiuto, eccessiva intimità o fusione, violenza psicologica, abuso sessuale e, in generale, ad effettuare test [di traslazione] per valutare la "tenuta psicologica" dello psicoterapeuta oppure valutare quanto lo psicoterapeuta stesso si dimostrerà diverso dalle persone che hanno fatto stare male il paziente nel corso della sua vita. 4. Possono essere presenti frammenti di ricordi intrusivi, che non si riescono a collocare adeguatamente in un coerente contesto spazio temporale. 5. è possibile che una persona possa essere tormentata da un ricordo al quale non corrisponde un evento fattuale reale oppure da un ricordo che distorce in modo più o meno ampio la realtà fattuale (si veda il paragrafo sui cosiddetti "falsi ricordi") 6. Quando un evento traumatico si è ripetuto più volte nel tempo,è frequente che una persona abbia difficoltà a capire quante volte si è verificato, in quale momento, ed a ricostruire l'esatto svolgersi degli eventi. Sembra che i ricordi siano stati assemblati in uno o pochi eventi prototipici, schemi degli eventi stessi, come avviene frequentemente nell'abuso sessuale intrafamiliare protratto nel tempo. 7. è possibile che alcuni eventi traumatici siano impossibili da recupare verbalmente e congruentemente perchè avvenuti prima che il cervello fosse in grado di collocarli in un contesto spazio-temporale (si veda oltre il paragrafo sulla neurologia e biochimica dei ricordi traumatici). 8. La disarmonia del ricordare appare frequentemente quando una persona ricorda un evento traumatico accaduto durante l'infanzia ed esprime valutazioni di merito all'accaduto come se avesse la maturità psicologica presente al momento in cui è accaduto l'evento traumatico. Ad esempio, è molto frequente che persone abusate sessualmente in età infantile in ambito intrafamiliare si sentano in colpa a molti anni di distanza perchè, a torto, ritengono di essere almeno in parte responsabili dell'accaduto in quanto si sarebbero dovute rifiutare più attivamente oppure avrebbero dovuto evitare sistematicamente la persona abusante: questo è il ragionamento di un bambino o di un ragazzino, non di una persona adulta. |
| Aggiornamento: Febbraio 2010 |