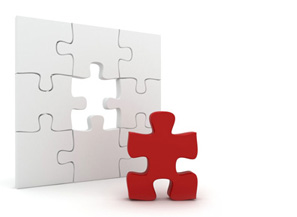

Trauma e memoria:
I cosiddetti "falsi ricordi"
Cos'è la psicotraumatologia
|
|
Pubblicazioni on-line
|
|
Congressi e Formazione
|
|
Bibliografia
|
|
Consulenze gratuite
|
|
| «Ogni particolare memoria», dicono Berliner
e Briere (1999) «è un
amalgama fra ciò che è stato codificato al momento
dell'evento, le conoscenze di base all'interno delle quali l'evento è stato
integrato, l'interpretazione del significato dell'informazione, l'adeguatezza
delle strategie di recupero ed il contesto del recupero»
La memoria, quindi, è tutto fuorchè una fotografia oggettiva di eventi reali. Senza addentrarci in questioni metafisiche relative all'essenza delle cose, ci è sufficiente sapere che la realtà è intrinsecamente e definitivamente soggettiva e che, da un punto di vista assoluto, ogni memoria è "falsa". Se questo vale per ogni singola e quotidiana memoria e ci consente comunque di vivere in modo pienamente adeguato, nel caso dei ricordi traumatici ciò comporta delle complessità maggiori. Infatti, avendo osservato nei paragrafi precedenti le peculiarità dei processi mnestici implicati negli eventi traumatici, ci possiamo rendere conto di come l'alterazione dei processi di codifica e di immagazzinamento dei ricordi possa produrre un ulteriore quantità di soggettività. Inoltre, poichè le esperienze traumatiche possono essere intercorse in fasi evolutive in cui l'aspetto somatico e comportamentale del ricordare è primario, la successiva elaborazione verbale degli eventi può essere rappresentata da notevoli confusioni, errori fattuali, confabulazioni, inclusione di suggestioni provenienti da altre persone, psicoterapeuti compresi. Alcune esperienze traumatiche, inoltre, sono, almeno in parte, sottoposte ad un processo di rielaborazione spontanea da parte della persona, attraverso l'uso della immaginazione e del raffronto con le risorse mnemoniche della persona stessa. Quello che la letteratura sembra indicare, infatti, è che forse è possibile soffrire per fatti mai avvenuti, e non soffrire affatto per gravi traumi realmente avvenuti Per studiare più dettagliatamente la disponibilità della mente umana a creare falsi ricordi, negli ultimi anni sono stati compiuti molti studi di grande interesse. In particolare, sono stati condotti esperimenti che hanno consentito di verificare come elementi falsi o errati possano essere incorporati nel racconto di una persona (misinformation effect), ma è stato anche possibile fare credere l'esistenza di interi eventi mai accaduti in una minoranza di giovani e adulti (come il "ricordo" di essersi persi in un supermercato da piccoli), laddove, secondo Elisabeth Loftus, la possibilità di creare ricordi falsi ex-novo è tanto maggiore quanto minore è l'età della persona; le persone restano, comunque, molto resistenti ad accettare come realmente accaduti fatti altamente implausibili o strani (l'avere subito un clistere in una visita medica da parte di bambini). Le differenze individuali nella dissociazione e nell'immaginazione creativa sembrano essere associate con la disposizione alla creazione di false memorie negli adulti (Berliner, Briere, 1999). Nell'alterazione sperimentale dei ricordi sembra, comunque, che i dettagli fondamentali restino intatti (Pope, Brown, 1996). Hyman & Kleinknecht (in Williams, Banyard, 1999) hanno inoltre dimostrato che, se anche in prima istanza non è possibile fare riconoscer come "vero" un fatto totalmente insesistente collocato nell'infanzia, è possibile farlo riconoscere come "vero" nel corso di tre interviste in una percentuale rilevante di persone. Un questione importante è quella della verosimiglianza dei ricordi in precedenza dimenticati. Alla luce di quanto precedentemente detto, è possibile ipotizzare che alcuni ricordi riemersi, magari all'interno di una psicoterapia, siano falsi o modificati in modo significativo dalla stessa attività di recupero e analisi posteriori. Ciò non significa, però, che tali tipi di ricordi siano necessariamente falsi o non accurati. Williams (1992, 1994) ha effettuato un studio di grande interesse su un campione di 200 donne fra i 17 ed i 20 anni che da bambine erano state portate in Pronto Soccorso in conseguenza di un abuso sessuale subito. Di queste donne, il 38% non era in grado di ricordare l'episodio preso in considerazione, soprattutto chi era più piccola al momento dell'abuso e conosceva personalmente il responsabile dell'atto. Fra queste donne i ricordi dell'abuso emersi ad anni di distanza dall'accaduto «erano altrettanto affidabili di quelli delle donne che avevano sempre ricordato l'abuso» (Pope, Brown, 1996). |
| Aggiornamento: Febbraio 2010 |