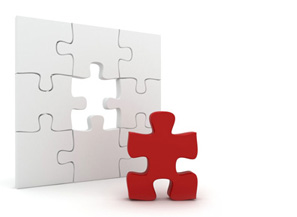

Trauma e memoria
Cos'è la psicotraumatologia
|
|
Pubblicazioni on-line
|
|
Congressi e Formazione
|
|
Bibliografia
|
|
Consulenze gratuite
|
|
[Sezione per addetti ai lavori] «Noi dimentichiamo il corpo, (Emile M. Cioran, Medicina: la borsa e la vita, Milano: Mondadori) Per comprendere adeguatamente la specificità delle memorie traumatiche è opportuno avere in mente alcuni concetti di base della psicologia generale, e connetterli alle conoscenze neurologiche relative ai traumi. La psicologia generale distingue sommariamente fra i seguenti tipi di memoria: memoria semantica: la conoscenza in generale, che possediamo come esito di processi di astrazione e generalizzazione a partire da episodi specifici; composta di schemi, modelli, paradigmi, proposizioni, programmi, script. Inizia a svilupparsi durante il secondo anno di vita mentre la memoria episodica non si sviluppa fino ai tre anni circa di età. Memoria episodica:le nostre memorie personali composte di fatti, distinte dalla conoscenza generale; secondo alcuni autori, la distinzione rispetto alla memoria semantica è essenzialmente di convenienza concettuale, in quanto non rappresenta un vero sistema separato dalla memoria semantica; da un punto di vista clinico, invece, questa distinzione è molto euristica. La memoria autobiografica è un tipo di memoria episodica. Memoria di lavoro: diversa da tutte le altre in quanto non si tratta di un magazzino di informazioni, ma piuttosto di un processo corticale di integrazione di informazioni generate da altre parti del cervello. Questa distinzione, tuttavia, è relativamente opinabile. Si differenzia dagli altri sistemi, essendo interamente processuale e dipendente dagli altri sistemi di memoria. Probabilmente ha luogo nella corteccia prefrontale (Schacter, Tulving, 1994), ma sembra coinvolgere anche l'ipotalamo. Memoria procedurale: il tipo di memoria più ampiamente rappresentata; si occupa, esemplificando, di ogni cosa che è più facile fare e mostrare piuttosto che dire: abitudini ed abilità acquisite (per es. guidare una macchina o una bicicletta, scrivere a macchina, uno sport, etc.); azioni riflesse, risposte da condizionamento classico; modalità di reazione a situazioni di minacciata incolumità (fisica e psicologica); modalità di gestione ed espressione delle emozioni; configurazioni di comportamento interattivo. Si sviluppa prima della memoria episodica. Neurologicamente sembra che i sistemi che mediano questo tipo di memoria siano molteplici (LeDoux, 1996). Ha la grande qualità di potere essere attivata rapidamente, in modo altamente efficace, algoritmico, riducendo l'arbitrarietà della valutazione cognitiva. Rispetto alla memoria semantica presenta però minore flessibilità, correggibilità, accessibilità, analisi sequenziale, riferibilità verbale. Una parte sostanziale ed autorevole della letteratura sui disturbi post-traumatici supporta abbondantemente l'ipotesi che la fonte della sofferenza riguardi essenzialmente la memoria procedurale ovvero, usando un'altra terminologia, è la memoria implicita ad essere fonte di sofferenza nei disturbi post-traumatici, mentre la memoria esplicita può addirittura essere anche assente; negli adulti, sofferenti di disturbi post-traumatici quindi, la memoria implicita è ben conservata, laddove quella esplicita può essere deficitaria. A fronte di questa constatazione si impone drasticamente la constatazione che interventi psicoterapeutici orientati primariamente alla memoria semantica ed episodica hanno poche possibilità di ottenere risultati apprezzabili con i disturbi post-traumatici, specialmente se provvisti di marcate caratteristiche dissociative; i pazienti capiscono tutto quello che c'è da capire sulla loro patologia, in termini cognitivi, psicodinamici, umanistico-esistenziali e così via, ma il disturbo rimane invariato. Al contrario, strumenti più diretti alla rielaborazione della memoria procedurale si dimostrano particolarmente efficaci. Tale concezione viene anche suffragata dalle conoscenze neurologiche e biochimiche sul Disturbo Post-traumatico da Stress: i dati in nostro possesso (sintetizzati nel paragrafo neurologia e biochimica) indicano infatti come ciò che viene saldamente memorizzato in modo indelebile in coincidenza delle esperienze traumatiche sia mediato dall'amidgdala, depositaria della memoria emozionale implicita (soprattutto la paura), ovvero l'aspetto procedurale dell'emozione. La mielinizzazione dell'amigdala, inoltre, avviene prima dell'ippocampo, rendendo possibile la memorizzazione in età infantile di esperienze di paura che sono impossibili da riferire in parole. Tale memorizzazione delle emozioni sarebbe inoltre indipendente dalla memorizzazione episodica e semantica delle emozioni, legata alla funzionalità dell'ippocampo (LeDoux, 1996). La valutazione di uno stimolo esterno o interno ad un trauma, inoltre, sarebbe valutato prima dall'amigdala rispetto all'ipotalamo (ed in modo rapido ma grossolano), e ciò comporta che la persona è portata a rispondere in modo supercondizionato prima che possano intervenire modalità di controllo più raffinate come quelle corticali, e addirittura prima che possa essere portata a termine l'attività percettiva. è addirittura possibile produrre un condizionamento alla paura senza che la corteccia cerebrale sia coinvolta nel processo. Le connessioni fra sistemi emotivi e cognitivi, inoltre, sono sbilanciata a favore delle prime, in quanto sono molte maggiori le connessioni fra l'amigdala e la corteccia rispetto al contrario (LeDoux, 1996). Tutti questi elementi portano a considerare che una psicoterapia rivolta essenzialmente alle memorie emozionali episodiche ed alla loro astrazione semantica è destinata al fallimento in quanto l'aspetto procedurale delle emozioni è supercodizionato a livello di strutture emozionali virtualmente indipendenti dal controllo corticale. La memoria episodica degli eventi traumatici, poi, può risultare alterata da variabili biochimiche, che possono anche esitare in alterazioni del substrato neurologico. Questo riguarderebbe però soprattutto la memoria episodica attraverso la possibile compromissione della memorizzazione effettuata dall'ippocampo a causa di stress eccezionali o protratti. L'ippocampo, poi, sembrerebbe essere coinvolto nel raccoglimento di informazioni provenienti da più siti cerebrali e dalla capacità di contestuallizzare spazialmente e temporalmente il ricordo al quale si accede (Bremner, 1999). Non risulta, invece, che lo stress possa danneggiare la memorizzazione effettuata dall'amigdala, potendo invece esserne potenziata. Ciò renderebbe parzialmente conto della complessa fenomenlogia traumatica, specialmente quando si presentifica attraverso amnesie più o meno parziali, frammenti di ricordi sotto forma di emozioni, sensazioni frammentate, presenza settoriale di residui sensoriali. |
| Aggiornamento: Febbraio 2010 |