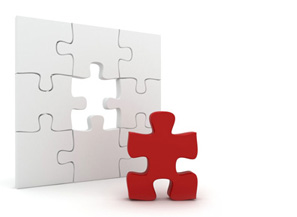| Considerazioni
critiche
 Arbitrarietà del
concetto di trauma Arbitrarietà del
concetto di trauma
 Il
criterio D: iperarousal Il
criterio D: iperarousal
 Il
concetto di intrusività Il
concetto di intrusività
 Reazione
iniziale al trauma Reazione
iniziale al trauma
Arbitrarietà del concetto di
trauma
Le condizioni "estreme" previste dal criterio A1 del DSM-IV
sono quelle richieste per porre una diagnosi di PTSD secondo il DSM-IV,
ma non le sole che è razionale considerare traumatiche (Briere,
1997; Carlson, Dalemberg, 2000). Basti pensare, innanzitutto, a come
la mente di un bambino possa vivere con drammaticità alcune
situazioni non rientrati nel criterio A1, come le liti costanti fra
i genitori o una separazione dei genitori. Ma, in ogni caso, altre
condizioni traumatiche possono certamente essere quelle dell'abuso
psicologico, la separazione ed il divorzio anche se non vissuti nell'infanzia,
condizioni di abuso fisico meno tragiche, la mancanza di sintonizzazione
emozionale nell'infanzia da parte delle figure di accudimento, importanti
cambiamenti di vita, un licenziamento, ristrettezze economiche protratte
o improvvise, gravi alterazioni nella gestione dell'accudimento di
un bambino che non sono previste dal criterio A1, e così via. Tali
condizioni, infatti, non rispettano il criterio A1 del DSM-IV, ma
nondimeno possono minare il senso dell'integrità
del Sè - da un punto di vista psicologico o fisico - ed anche
soddisfare il criterio A2, ovvero suscitare paura intensa, impotenza
o orrore; in sintesi, possono avere un esito post-traumatico, rispettando
anche gli altri criteri posti dal DSM-IV, intrusività, evitamento,
aumento dell'arousal. Di fatto, i criteri adottati dal DSM-IV per
definire che cosa è e che cosa non è un evento traumatico
non hanno un fondamento clinico o teoretico sufficientemente solido
(Carlson, Dalenberg, 2000). In base agli attuali parametri del PTSD,
quindi, molte situazioni stressanti potenzialmente traumatiche non
possono dare origine ad un PTSD, ma al massimo ad un Disturbo
dell'Adattamento. La realtà clinica dimostra però chiaramente
come sia possibile il generarsi di una sintomatologia PTSD anche
in seguito ad altre situazioni di vita escluse dal PTSD. Di fatto,
lo stesso DSM-IV mentre si accinge ad elencare le situazioni potenzialmente
traumatiche, specifica che tali situazioni potenzialmente traumatiche
«non sono limitate a» quelle incluse nell'elenco.
Il Criterio D: iperarousal
Rispetto al DSM-III-R, il DSM-IV include
il criterio dell'iperarousal, oltre all'intrusività ed all'evitamento, già presenti
nella ormai classica concettualizzazione di Horowitz. Non è affatto
detto però che il criterio D del DSM-IV, cioè l'iperarousal,
sia realmente qualcosa di diverso dall'intrusività e dall'evitamento,
in quanto - almeno in parte - può essere spiegato come il
risultato del continuo bilanciamento fra evitamento ed intrusività (Stephen,
2000). Nel caso in cui, invece, si voglia intendere l'iperarousal
come sintomo squisitamente psicobiologico, esito della sensibilizzazione
cerebrale seguente a uno o più traumi (fenomeno del kindling),
e quindi ormai totalmente autonoma rispetto ad ogni evento di vita
specifico, bisogna notare come possano essere osservate situazioni
cliniche identiche al PTSD, ma in assenza di iperarousal. è allora
necessario porsi la domanda se la diagnosi di PTSD attuale non debba
essere modificata nel senso di una esclusione dell'iperarousal come
criterio indispensabile o se, piuttosto, non sia più corretta
la posizione dell'ICD-10, che non considera l'iperarousal come essenziale
per la diagnosi, ma piuttosto alternativo all'impossibilità di
rievocare importanti elementi mnestici del trauma.
Il concetto di "intrusività"
Il DSM-IV indica chiaramente che per porre una diagnosi di PTSD
ci debba essere un continuo rivivere elementi connessi con gli episodi
traumatici (Criterio B), ma l'osservazione clinica dimostra che questa
specifica non è assolutamente fondamentale per l'esistenza
di un disturbo post-traumatico anche molto importante. Infatti, proprio
a causa del meccanismo di evitamento (Criterio C) esercitato nei
confronti di pensieri, immagini, sensazioni, emozioni, luoghi o persone
che possano in qualche modo richiamare l'evento, una persona può vivere
relativamente libera da sintomi intrusivi. Il trauma è stato,
per così dire, "incapsulato" in modo efficace. Il fatto
che tale evitamento non sia totalmente efficace e che di fronte ad
alcuni stimoli esterni emergano elementi del trauma con la conseguente
sofferenza, è sintomo di patologia indefinita, ma attualmente
- e curiosamente - non di PTSD. D'altronde, anche l'ottundimento
della reattività generale (Criterio C), presente a volte all'inizio
di un PTSD o in una alcune sue fasi, è frequentemente assente
oppure tende a scomparire con il passare del tempo (l'ICD-10, per
esempio, non lo considera un elemento fondamentale per porre la diagnosi
di Sindrome Post-Traumatica da Stress).
Ci sono molti elementi, quindi, che portano a ritenere sensata l'introduzione
dei concetto di PTSD in
remissione parziale o subclinico o parziale, oppure che è necessario
effettuare delle riconsiderazioni sul concetto stesso di PTSD, così
come attualmente inteso dal DSM-IV.
Reazione iniziale al trauma
Per quanto riguarda il Criterio A2, ovvero la risposta iniziale
e soggettiva all'evento, probabilmente è troppo restrittivo
richiedere che una persona abbia sperimentato orrore, impotenza o
paura al momento dell'evento: la reazione al momento del trauma,
infatti, potrebbe essere stata di tipo così marcatamente dissociativo
da rendere sostanzialmente nulla la percezione delle emozioni richieste
dal DSM-IV (Carlson, Dalemberg, 2000). Ci si riferisce a questo fenomeni
come alla dissociazione peritraumatica, caratterizzata da derealizzazione,
depersonalizzazione e lacune mnestiche (Marmar), fenomeno che inoltre
sembra correlato alla gravita del seguente PTSD. Questa incongruenza
appare ancora più paradossale se si pensa che questi sintomi
dissociativi sono invece inclusi nella diagnosi del Disturbo
Acuto da Stress, frequente antecedente del PTSD. Il meccanismo
della dissociazione, però, riveste un ruolo che sembra essere
molto importante in una tipica manifestazione sintomatica del PTSD:
la fluttuazione tra l'accesso volontario e involontario ai ricordi
traumatici, accesso che va dalla estrema intrusività di un
flashback fino alla amnesia globale per un evento. Molti elementi
lasciano pensare che, in coincidenza di un trauma, si possa verificare
una significativa modificazione dello stato di coscienza, tale per
cui parte delle esperienze traumatiche vengono memorizzate in stati
di coscienza differenti rispetto a quello ordinario, ed in questo
modo producendo una incommensurabilità fra sistemi mnestici
(codifica, immagazzinamento e recupero), ovvero una dissociazione
fra stati di coscienza e reti mnestiche. L'osservazione di questi
meccanismi, la constatazione che in alcune persone
è presente un'effettiva modificazione dello stato di coscienza
nel ripresentificarsi anche di frammenti di ricordi traumatici e,
infine, l'osservazione che tecniche di modulazione dello stato di
coscienza - più o meno ecologiche - consentono di accedere
con maggiore efficacia di altri approcci a materiale mnestico dimenticato
o accessibile frammentariamente, sono alcuni dei principali motivi
che portano alcuni autori a considerare il PTSD come un Disturbo
Dissociativo piuttosto che un Disturbo d'Ansia. In realtà la
questione è
più complessa di come possa apparire a prima vista, se non
altro per il fatto che con il termine dissociazione sono state intese
una grandissima quantità di fenomeni fra loro certamente non
completamente omogenei (Cardeña, 1994). Per alcuni autori
il temine è ormai tanto confuso da essere difficilmente utilizzabile
(Carlson, Dalemberg, 2000), mentre per altri conviene intendere per
dissociazione ogni esclusione di informazioni dalla consapevolezza
(Briere, 1997), sia che tale operazione sia svolta deliberatamente
(consciamente o inconsciamente) ed in stato di coscienza ordinario,
sia che essa sia il frutto della alterazione e della frammentazione
del processo di memorizzazione causata violente o prolungate alterazioni
biochimiche e/o da radicali modificazioni dello stato di coscienza
(come intende l'approccio psico-biologico di alcuni autori come ad
esempio van der Kolk).
Con ogni probabilità, allora, la caratteristica della dissociazione
peritraumatica dovrebbe essere inclusa nelle modalità della
risposta soggettiva agli eventi stressanti, cioè il criterio
A2 del PTSD, senza peraltro diventare - io credo - una presenza pregiudiziale.
Infatti, a mio giudizio, è possibile la creazione e/o il consolidamento
di disturbi post-traumatici (PTSD o altro) sia per mezzo della dissociazione
che per mezzo dell'evitamento, sia, come frequentemente avviene,
attraverso una loro commistione. |