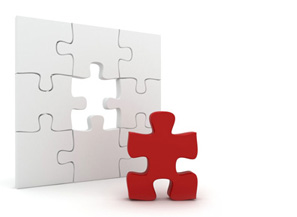

Psicoterapia
cognitivo-comportamentale
Cos'è la psicotraumatologia
|
|
Pubblicazioni on-line
|
|
Congressi e Formazione
|
|
Bibliografia
|
|
Consulenze gratuite
|
|
| La relazione terapeutica L'approccio cognitivo-comportamentale tradizionale è caratterizzato da una impostazione piuttosto tecnica che, nella migliore delle ipotesi, considera la relazione terapeutica condizione necessaria ma non sufficiente alla conduzione ottimale della psicoterapia (Sanavio, 1991). Secondo alcuni autori, non avrebbe ancora sviluppato un impianto teoretico e tecnico sufficientemente solido ed articolato per impiegare attivamente e consapevolmente la relazione nel settore clinico (Safran, Segal, 1990). L'approccio più strettamente comportamentale ha sostenuto, anzi, che interazioni terapeuta-paziente ridotte al minimo non influiscono sui risultati di interventi effettuati con la desensibilizzazione sistematica applicata a paure semplici e circoscritte. Con pazienti disturbati a livello di abilità interpersonali, coinvolti in problematiche multiple o non facilmente circoscrivibili, tale impostazione resta comunque da dimostrare completamente. Al contrario, autori contemporanei appartenenti alla tradizione cognitiva (Beck, Emery, 1990; Liotti, 1993; Safran, Segal, 1990) sostengono che la qualità della relazione terapeuta-paziente è una variabile determinante nell'ottenimento di cambiamenti terapeutici generalizzati e duraturi. Viene considerata fondamentale, in altre parole, non solo la semplice alleanza di lavoro basata su un razionale empirismo collaborativo, ma anche la dinamica relazionale che nasce dall'incontro fra le caratteristiche interpersonali del paziente e del terapeuta. Le emozioni ed i pensieri automatici del professionista, inoltre, assumono la funzione di strumenti potentissimi nella diagnosi e nel monitoraggio della relazione terapeutica. Nella tradizione cognitivo-comportamentale più tradizionale risulta invece che le capacità e le strategie adottate in sede terapeutica per gestire e manipolare la relazione non sono fondate su scoperte della psicologia sperimentale, quanto piuttosto sull'esperienza personale del terapeuta e sulla supervisione clinica (Wilson, 1984). è una situazione perlomeno paradossale, in quanto non è solo frutto di esperienze ed intuizioni, ma anche ampiamente dimostrato che la relazione terapeutica influisce in modo determinante sull'efficacia delle tecniche impiegate (Beck, Freeman, 1990; Safran, Segal, 1990). Negli ultimi anni, quindi, il panorama della letteratura cognitiva si è arricchito di importanti contributi che fanno esplicito riferimento all'importanza della relazione nell'intervento terapeutico (Arnkoff, 1983; Goldfried, 1982; Jacobson, 1989), al suo necessario impiego nel trattamento di pazienti con Disturbi di Personalità (Beck, Freeman, 1990) ed alla necessità di approntare uno schema di riferimento teoretico di più ampio respiro, che superi cioè l'utile ma riduttiva metafora dell'uomo come elaboratore di informazioni (Safran, Segal, 1990). Recentemente Safran e Segal (ibid.) hanno anche elaborato interessanti proposte di intervento operativo bene integrate all'interno di un impianto teorico definito teoria cognitiva ad orientamento interpersonale. Nel trattamento dei tossicodipendenti è addirittura indispensabile un riferimento teorico che tenga in grande considerazione l'aspetto interpersonale del rapporto terapeutico, provvedendo anche al suggerimento di precise modalità tecniche. Ogni operatore delle tossicodipendenze, infatti, ha ben presente che il suo intervento fallisce o ha successo principalmente in funzione della specifica relazione che si è instaurata con l'utente. Con questi soggetti è infatti difficile cementare una solida alleanza di lavoro perchè ampiamente minata e distorta dalla presenza di modalità di relazione patologiche sia nei tossicodipendenti che nei loro familiari. Con questi utenti, allora, si verificano frequenti rotture dell'alleanza terapeutica, se non altro perchè mancano di esperienze passate costituite da correzioni costanti dell'andamento delle relazioni più significative (Safran, Segal, 1990, p. 175). La tossicodipendenza, noi pensiamo, richiede poi anche un approccio di tipo costruttivistico (Bara, 1984; Guidano, 1987, 1991), in quanto non è possibile immaginare di trasformare un tossicodipendente in un individuo con processi di elaborazione cognitiva simili a quelli della logica aristotelica, così come di fatto proposto dagli approcci cognitivi classici (Beck, 1976, 1979; Ellis, 1962). La sua storia e le sue esperienze "diverse", infatti, non sono cancellabili facendo semplicemente riferimento a come stanno "realmente" le cose, ma devono essere rielaborate e ristrutturate in una specifica organizzazione del sè che, pur diventando adattiva ed intrinsecamente equilibrata, potrà ancora apparire deviante rispetto alla "normalità". E' quindi opportuno dedicare un'attenzione più particolareggiata ad aspetti teorici e tecnici utili alla gestione delle relazioni interpersonali con questi utenti, in modo che non si sia costretti a negare la specificità e la drammaticità della loro esperienza passata. Per Safran e Segal l'efficacia di una psicoterapia è condizionata dal «modo di percepire il significato del comportamento del terapeuta da parte del paziente» (1990) e, più specificatamente, dal risultato delle precedenti esperienze interpersonali vissute con le figure significative. In definitiva, quindi, gli autori si riferiscono anche a tutto ciò che nel campo interpersonale esula dall'ovvietà della razionalità dell'hic et nunc. Infatti i pazienti non sono "monadi" che richiedono un intervento specialistico, ma innanzitutto individui interpersonali, che nei rapporti con gli altri hanno sviluppato cognizioni, emozioni, comportamenti e strategie interattive. Trascurare l'aspetto interpersonale implica allora eludere il versante biologico dell'essere umano, e cioè soprattutto il fatto che ogni individuo è una creatura programmata dall'evoluzione per sopravvivere e crescere in un contesto significativo quantomeno diadico (Bowlby, 1979, 1988). In particolare, l'uomo si caratterizza per la presenza di comportamenti di attaccamento che, lungi dall'esaurire i propri obbiettivi nell'infanzia, determinano la sua azione per tutta la durata della vita (Ammaniti, Stern, 1992; Bowlby, 1979; Guidano, 1987, 1991; Liotti, 1984, 1992a, 1994; Stern, 1985). Il mantenimento della vicinanza con altri esseri umani, infatti, si dimostra un requisito indispensabile per la sopravvivenza fisica e l'equilibrio psicologico. In quest'ottica interpersonale, allora, lo studio dell'emozione deve assumere un ruolo determinante ed essere intesa come «una forma biologicamente innata d'informazione circa il sè in interazione con l'ambiente» (Safran, Segal, 1990). Un'attenzione particolare deve essere prestata all'ansia, emozione suscitata dalla «incapacità di integrare relazioni interpersonali» (ibid., p. 74; cfr. Sullivan, 1953, 1956), derivante soprattutto da rapporti disgregati. In questi ultimi casi l'estrema ansia associata alle relazioni interpersonali impedisce una corretta codificazione mnestica delle informazioni sia interne che esterne (Safran, Segal, 1990), causando il mancato riconoscimento di emozioni sia in sè stessi che negli altri. In sintesi, allora, «ripetute esperienze d'intensa ansietà e di scarsa sintonizzazione affettiva possono provocare un senso frammentato del sè. Nei casi più estremi possono svilupparsi stati limite (borderline) o sindromi di personalità multipla» (Safran, Segal, 1990) e, in generale, uno scarso senso di stabilità e di continuità temporale del sè. Effetto opposto sarebbe invece associato a relazioni empatiche ricorrenti, sintonizzate sulle emozioni della persona. Schemi interpersonali e cicli cognitivo-interpersonali In quest'ottica diventa ancora più giustificato ricorrere a tecniche come il Training Assertivo che permettono, infatti, di intervenire in vivo sui cicli cognitivo-interpersonali disfunzionali, complessi mnestici considerabili soggetti al processo della codifica stato-dipendente (Safran, Segal, 1990; cfr. Bower, 1981 e Rossi 1986a, b). Le emozioni e le cognizioni ad essi connessi vengono in tal modo elicitate direttamente, mentre sono contemporaneamente disponibili feedbacks da tutti i partecipanti al gruppo; i cicli cognitivo-interpersonali disfunzionali, in seguito, attraverso ulteriori apprendimenti, sia osservativi che in prima persona, vengono invalidati, ricontestualizzati e corretti. Da un punto di vista cognitivo-comportamentale non è affatto indispensabile la ricostruzione genetica della formazione di un determinato schema interpersonale. Questo modello teorico, in effetti, ritiene che un simile intervento rischi di produrre involontariamente un'intellettualizzazione eccessiva dei problemi affrontati, separando il soggetto dalle emozioni del momento e dall'urgenza di lavorare nell'immediato per cambiare i propri schemi disadattivi (Safran, Segal, 1990). è però da riconoscere che un'operazione simile ad una ricostruzione genetica di transfert deve essere effettuata soprattutto quando ci si trova di fronte a gravi distorsioni cognitive e relazionali che impediscono di incidere sufficientemente nello schema oggetto di intervento (Safran, Segal, 1990). Rimane comunque essenziale produrre una nuova relazione interpersonale rispetto ad una ricostruzione storica (Gill, 1982; Liotti, 1993; Safran, Segal, 1990). L'ottica cognitivo-comportamentale più recente, infatti, considera globalmente più produttivo fornire, nelle problematiche relazionali, nuove e sistematiche esperienze di apprendimento "in vivo" piuttosto che fare fondamentale affidamento sulla riorganizzazione cognitiva ed emotiva (Beck, Freeman, 1990; Safran, Segal, 1990). è ovvio che una pratica simile è più ansiogena per il clinico poichè lo costringe ad analizzare variabili interpersonali che evidentemente lo coinvolgono in prima persona. Il riferimento sistematico a cause passate, seppure potenzialmente positivo, sembra invece una pratica che troppo facilmente è in parte attribuibile al tentativo agito dall'operatore di contenere la propria ansia. Non appena questi è in grado di isolare significativi indicatori interpersonali, dovrebbe invece sottrarsi al ciclo cognitivo-interpersonale disfunzionale agito dal soggetto ed evidenziargli quanto si svolge nel presente. Tale intervento, noto come metacomunicazione, può essere effettuato essenzialmente nei seguenti modi: segnalare 1) un indicatore interpersonale o 2) un proprio sentimento per a) accrescere la consapevolezza del soggetto o b) sondare ulteriori aspetti ideo-affettivi del paziente (Safran, Segal, 1990).La strategia da adottarsi è quindi piuttosto semplice, per lo meno sulla carta: sganciarsi da ciclo cognitivo-interpersonale disfunzionale in corrispondenza di un indicatore interpersonale, metacomunicare il processo in atto eventualmente impiegando le proprie emozioni, confutare empiricamente (relazionalmente) le distorsioni, evocare nuove emozioni e cognizioni (se opportuno con riferimento all'esperienza passata), ristrutturare il ciclo cognitivo-interpersonale stesso (Safran, Segal, 1990). |
| Aggiornamento: Febbraio 2010 |