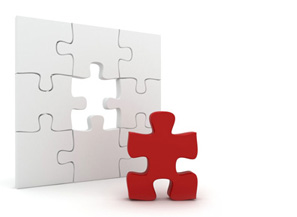

Psicoterapia
cognitivo-comportamentale
Cos'è la psicotraumatologia
|
|
Pubblicazioni on-line
|
|
Congressi e Formazione
|
|
Bibliografia
|
|
Consulenze gratuite
|
|
| Coordinate epistemologiche e cliniche della psicoterapia cognitivo-comportamentale Innanzitutto teniamo a precisare che con il termine "cognitivo-comportamentale" non è corretto identificare una vera e propria scuola, quanto piuttosto un atteggiamento verso la psicologia, contenente al suo interno posizioni variegate ed anche contraddittorie (Sanavio, 1991; Safran, Segal, 1990). L'approccio a cui facciamo riferimento può essere teoreticamente inquadrato per mezzo delle seguenti assunzioni, indirizzando eventualmente alla bibliografia per ulteriori e più completi approfondimenti (in particolare: Meazzini, 1983, 1984; Guidano, 1987, 1991; Safran, Segal, 1990; Sanavio, 1991): 1) determinismo. Si intende che all'interno degli eventi psicologici sono riconoscibili rapporti di causa-effetto, lineari, biunivoci o circolari, che permettono una previsione quantomeno probabilistica di tali eventi (Sanavio, 1991), la loro instaurazione e modificazione programmatica. Un rapporto osmotico con la ricerca psicologica di base rende allora possibile identificare leggi o regolarità negli accadimenti comportamentali o psichici che offrono un immediato potere di intervento in sede terapeutica e riabilitativa. 2) Ambientalismo. Nella insolubile contrapposizione innato/acquisito si ritiene più realistico puntare sul versante ambientale pur senza trascurare gli innegabili apporti genetici. Ne discende che ogni comportamento e caratteristica psicologica sono stati appresi nelle loro specifiche peculiarità e che quindi, per definizione, sono modificabili attraverso ulteriori esperienze di apprendimento che obbediscono a note leggi e regolarità. 3) Riduzionismo. Ogni fenomeno psicologico in linea di principio può essere scomposto in elementi molecolari obbedienti alle leggi della psicologia di base. Dalla possibilità di tale operazione non ne discende però un'opportunità in tutti i casi (Liotti, 1984). Con sempre maggiore insistenza, infatti, i recenti contributi della letteratura cognitivo-comportamentale impiegano, anche da un punto di vista teoretico, macrovariabili che perderebbero di maneggevolezza e di potere euristico se frammentate nelle loro componenti più essenziali (si pensi ad esempio al concetto di "distorsione cognitiva" come inteso da Aaron Beck, 1976, 1979; Beck, Freeman, 1990). 4) Evoluzionismo. L'uomo è parte integrante dell'evoluzione della specie animale e come tale condivide con essa l'appartenenza ad un comune fondamento di leggi comportamentali, sociali e psicofisiologiche, per quanto possa differenziarsi nel particolare sviluppo linguistico e per l'autoconsapevolezza. 5) Concezione della devianza. "Normalità" e "patologia" devono intendersi come astrazioni concettuali da porsi alle estremità di un continuum che non prevede al suo interno alcuna sostanziale differenza nei meccanismi fondamentali del funzionamento psichico, dell'apprendimento e quindi del cambiamento. 6) Atteggiamento situazionale. Si preferiscono effettuare valutazioni ed interventi sulla situazione in uno specifico momento presente, piuttosto che fare riferimento a macrovariabili come i tratti di personalità, generalizzabili indiscriminatamente a tutti i contesti. Nello stesso tempo può essere utile o necessario ricorrere a modelli interpretativi che impiegano macrovariabili riferibili a situazioni differenti (si veda, ad esempio, il concetto di "schema interpersonale" in Safran, Segal, 1990). 7) Atteggiamento molecolare e molare. Vengono privilegiate unità di analisi e di intervento di livello più elementare rispetto a variabili molari impiegate da altri orientamenti. Un approccio molare (peraltro da decenni intrinseco anche a correnti fondamentali del comportamentismo) può comunque essere contemporaneamente o alternativamente impiegato laddove sia ritenuto più opportuno (Liotti, 1984; Safran, Segal, 1990). 8) Atteggiamento pragmatico. L'ottica cognitivo-comportamentale confrontandosi col dualismo teoria/tecnica predilige sicuramente quest'ultima, concentrando la maggior parte dei propri sforzi ed interessi nella produzione di strumenti operativi per l'analisi e la modificazione delle variabili comportamentali, cognitive, emotive ed interpersonali. Nello stesso tempo riconosce che la qualità della relazione è determinante, soprattutto nelle fasi iniziali del rapporto terapeutico, laddove la rilevanza dell'apporto tecnico è necessariamente ridotta (Sanavio, 1991, p. 204). 9) Concezione del versante interpersonale. I comportamenti, le emozioni e le cognizioni umane sono apprese in un contesto interpersonale dal quale non si può prescindere per formulare ipotesi interpretative ed interventi mirati al cambiamento. La relazione terapeutica è uno strumento con potenzialità di monitoraggio, diagnostiche e terapeutiche. Può anche essere intesa come un laboratorio per la rilevazione e l'analisi di processi cognitivo-affettivi, interpersonali e delle emozioni del terapeuta (Beck, Freeman, 1990; Safran, Segal, 1990). La metateoria da noi impiegata, cioè il livello di astrazione teorica di grado più elevato (Safran, Segal, 1990, p. 18), è quindi sia interpersonale che cognitiva. Interpersonale perchè considera un bisogno primario il mantenimento della relazione con gli altri (Bowlby, 1979, 1988), cognitiva perchè contemporaneamente ritiene l'uomo un elaboratore ed un costruttore della propria esperienza e delle immagini del mondo in cui vive. |
| Aggiornamento: Febbraio 2010 |