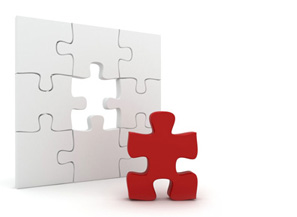Tecniche covert
L'approccio cognitivo-comportamentale, anche prescindendo dal versante
cognitivo in senso stretto, contrariamente a quanto sostenuto da
fuorvianti e datati luoghi comuni, non fa riferimento a tecniche
impieganti esclusivamente indici comportamentali osservabili. Da
alcuni decenni, infatti, può vantare
fra il proprio equipaggiamento di base interventi molto sofisticati
implicanti sia indici psicofisiologici misurabili, sia risposte e
variabili covert,
cioè rilevabili solo indirettamente per mezzo dei resoconti
introspettivi forniti dai soggetti o tramite risposte osservabili solo
successivamente all'intervento effettuato.
Desensibilizzazione sistematica
Oltre alle tecniche di condizionamento verbale di cui abbiamo parlato
in precedenza, fra gli interventi covert il più rappresentativo è sicuramente
la desensibilizzazione sistematica (DS; Wolpe,
1958, 1969) la cui efficacia, sia nelle applicazioni classiche
che in ulteriori varianti (Goldwurm, Sacchi, Scarlato, 1986; Melamed,
Siegel, 1980; Sacco, 1994), ha sicuramente contribuito alla diffusione
dell'approccio comportamentale fra gli psicologi clinici. Molto
sinteticamente l'applicazione classica della DS, fondata sul meccanismo
del controcondizionamento, consiste nella ripetuta associazione
fra uno stimolo ansiogeno - immaginato - ed una reazione antagonista
- abitualmente il rilassamento psicofisiologico - al fine di produrre
una progressiva "inibizione reciproca" fra stimolo e risposta così associati.
Come conseguenza l'individuo sviluppa gradualmente una reazione
più controllata nei confronti di determinati stimoli o contesti,
rappresentando ciò un obiettivo ma contemporaneamente anche
un mezzo per la produzione di apprendimenti maggiormente adattivi,
efficaci e creativi. La DS è efficace nel trattamento dei
tossicodipendenti in quanto incide fortemente sui vissuti di ansia
ed inadeguatezza così frequentemente commisti alle disabilità assertive
ed interpersonali di questi soggetti. Poichè fondata sulle
immagini mentali, è anche una tecnica molto maneggevole,
consentendo la riproduzione plastica delle più diverse e
complesse situazioni interpersonali. è un indubbio vantaggio
se applicata nel trattamento di soggetti che, essendo in Comunità,
hanno a disposizione un numero ridotto di ambienti sociali dove
interagire. Alcuni contesti classici su cui lavorare terapeuticamente,
come i ritrovi dei tossicodipendenti, sono poi particolarmente
pericolosi in quanto ancorati ad una gran quantità di condizionamenti
disadattivi e di ricordi spiacevoli, difficoltà che può essere
scavalcata proprio mediante il ricorso a loro rappresentazioni
immaginative. La DS permette inoltre un controllo ed un monitoraggio
accurato delle strategie di evitamento spesso agite dal tossicodipendente
(in coincidenza o anticipatamente a scopo preventivo) nei confronti
delle situazioni ansiogene o che comunque sono legate ad emozioni
vissute negativamente. Le informazioni così ottenute possono
anche essere utilizzate in ulteriori interventi terapeutici, garantendo
una maggiore razionalità e completezza dell'approccio clinico.
Limite di tali tecniche e di altre a cui accenneremo in seguito, è che
necessitano assolutamente della applicazione da parte di uno psicologo
esperto, soprattutto se vengono stimolate modificazioni dello stato
di coscienza. In tali situazioni, per esempio, non si possono mai
escludere imprevedibili abreazioni spontanee di esperienze ad elevata
valenza traumatica che necessitano, per essere gestite correttamente,
di una specifica formazione dell'operatore.Condizione imprescindibile
per l'applicazione di questa forma di DS è l'impiego di
una tecnica di rilassamento, classicamente quella elaborata da
Jacobson (Goldwurm, Sacchi, Scarlato, 1986; Jacobson, 1928), al
fine di produrre uno stato psicofisiologico antagonista rispetto
allo stimolo ansiogeno che si intende desensibilizzare. Esistono,
comunque, altre tecniche di rilassamento oltre a quella di Jacobson,
che necessita di un lungo e noioso apprendimento.
Gli stati ipnotici e di rilassamento si combinano efficacemente
con una grande quantità di tecniche, alcune per tradizione
appartenenti al filone cognitivo-comportamentale (Cautela, 1966,
1971, 1977; Desoille, 1961; Lazarus, 1977; Meichenbaum, 1985; Sacco,
1994), altre, di tipo psicoanalitico, ad esso estraneo se non proprio
in antitesi, perlomeno apparentemente (Balzarini, Salardi, 1987;
Fretigny, Virel, 1967; Fusini-Doddoli, 1987; Leuner, 1982; Thomas
1967). |