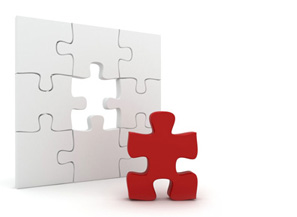

Psicoterapia
cognitivo-comportamentale
Cos'è la psicotraumatologia
|
|
Pubblicazioni on-line
|
|
Congressi e Formazione
|
|
Bibliografia
|
|
Consulenze gratuite
|
|
| Alcuni concetti di base La psicologia cognitivo-comportamentale affonda parte delle proprie radici nella ricerca di base, ed in particolare in quel ramo della psicologia sperimentale che si occupa dell'apprendimento. Una tradizione di lavoro ormai pluridecennale conferma che l'apprendimento - adattivo o meno e non solo umano - è in parte determinato da fondamentali meccanismi di condizionamento. Tale processo può essere essenzialmente di due tipi: 1) rispondente, che si verifica quando «uno stimolo [detto stimolo condizionato: SC] accoppiato ad un secondo stimolo [detto stimolo incondizionato: SI], arriva ad elicitare una reazione [detta reazione condizionata: RC] simile a quella prima elicitata solo dal secondo stimolo [detta reazione incondizionata: RI]» (Melamed, Siegel, 1980, p. 40); 2) operante, riassumibile nel semplice principio che afferma che i comportamenti vengono modificati o mantenuti dalle loro conseguenze. Un esempio di apprendimento per condizionamento rispondente riferito al contesto di cui ci stiamo occupando può essere la reazione di attacco/fuga (RC) che alcuni tossicodipendenti esibiscono nei confronti dei tentativi (SC) di entrare in rapporto con loro. Questi soggetti, infatti, sono spesso vissuti in ambienti in cui le persone significative si sono avvicinate loro con intenzioni manipolative, violente o comunque producendo un effetto emotivamente disturbante (SI). La frequente associazione fra avvicinamento dell'altro significativo e comportamento disturbante ha fatto si che la risposta di attacco/fuga venga poi elicitata dal tentativo stesso di entrare in rapporto con loro, anche se compiuto da altre persone e senza alcuna intenzione negativa. Successivamente si evidenzierà come questo stesso fenomeno può essere efficacemente inserito in un concetto teorico di ordine superiore, il ciclo cognitivo-interpersonale (Safran, Segal, 1990), senza per questo perdere di giustificazione o di valore euristico. La medesima considerazione deve intendersi valida anche per il possibile intervento terapeutico con l'estinzione esposto nel prosieguo dell'esposizione. Questo è un esempio dell'interdipendenza e della compenetrazione fra analisi molecolare e molare in ambito cognitivo-comportamentale. L'esempio paradigmatico di condizionamento operante nei tossicodipendenti è rappresentato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Questi soggetti hanno infatti imparato che utilizzando determinate sostanze ottengono un rapido risultato gratificante: evitamento di una condizione dolosa e/o godimento psicofisiologico. Avendo ben presenti queste due modalità fondamentali di apprendimento è possibile sfruttarle per modificare comportamenti precedentemente acquisti o crearne di nuovi. Seguendo un'impostazione abbastanza classica, passeremo ora ad esemplificare alcune modalità di intervento riabilitativo e terapeutico basate sul condizionamento rispondente: 1) l'estinzione e 2) il controcondizionamento. Il procedimento di estinzione consiste nel presentare ripetutamente ad un soggetto lo stimolo (SC) che elicita una risposta che si intende modificare, facendo però in modo che allo SC non segua mai lo SI. In questo modo lo SC perde gradualmente il potere di elicitare la RC. Applicando questo principio all'esempio precedente, si effettuerebbe un intervento di estinzione entrando in relazione con il soggetto tossicodipendente senza mai motivare realisticamente una reazione attacco/fuga (cioè al tentativo di entrare in relazione con il soggetto non segue un comportamento negativo da parte dell'operatore). All'interno di questa situazione si potrebbe però verificare che il comportamento disadattivo medesimo, cioè la reazione l'attacco/fuga indiscriminata, impedisca lo stesso processo di estinzione in quanto il soggetto si sottrae alla relazione. Può allora essere adottata una versione differente dell'estinzione e cioè un intervento di tipo implosivo o flooding. Seguendo questa tecnica è possibile presentare in modo reale o immaginativo lo SC ponendo il soggetto in condizione di non potere evitare (se non con reazioni estreme) lo SC stesso, fornendogli contemporaneamente sicurezza circa la propria incolumità. La Comunità terapeutica stessa, quindi, si serve largamente del flooding in quanto i suoi utenti sono continuamente "immersi" in relazioni potenzialmente ansiogene dalle quali non possono sottrarsi se non abbandonando la Comunità stessa o comunque alterando notevolmente la relazione in atto. Si tratta di una tecnica che in ogni caso deve essere utilizzata con cautela poichè in alcuni casi invece di produrre estinzione conduce alla sensibilizzazione verso lo SC (Melamed, Siegel, 1980). L'effetto esercitato dall'estinzione non è inoltre profondo, soprattutto se l'associazione SC-RC è molto forte (Meazzini, 1984, p. 113). Non dovrà quindi essere mai impiegata come tecnica esclusiva per il trattamento di un comportamento disadattivo, poichè non si può mai escludere completamente l'eventualità di un recupero spontaneo. Tale intervento, inoltre, può anche essere vanificato se effettuato in concomitanza a sporadiche associazioni SC-SI. Il principio del controcondizionamento sostiene che si riduce l'associazione fra SC e RC se si associa sistematicamente allo SC un nuova RC antagonista. La tecnica più nota applicante il controcondizionamento è la desensibilizzazione sistematica, della quale parleremo più estesamente in seguito. Anche se raramente ricordato, è molto importante sottolineare che il controcondizionamento viene applicato anche solo a livello comunicazionale. Esemplificando, se un tossicodipendente vive negativamente alcune sue caratteristiche perchè ripetutamente hanno elicitato negli altri atteggiamenti di rifiuto, allora possiamo spezzare l'associazione esistente reagendo alle medesime caratteristiche in modo completamente differente. Anche lo stesso raccontarsi avrà quindi un esito controcondizionante se sarà seguito, per esempio, dalla accettazione da parte dell'operatore, piuttosto che dal rifiuto, dal disgusto o dalla critica. Esiste anche una forma di controcondizionamento detto avversivo, che prevede l'associazione fra una risposta, appunto avversiva, ed uno stimolo che precedentemente elicitava risposte gratificanti ma disadattive. Un esempio a livello covert, cioè non direttamente osservabile, potrebbe essere l'insegnare ad un tossicodipendente ad associare sistematicamente alla fantasia di assumere sostanze stupefacenti (stimolo con valenza positiva) una conseguenza estremamente spiacevole derivante dalla messa in atto di tale fantasia (reazione avversiva). Osservato da questo punto di vista, il controcondizionamento avversivo risulta essere una tecnica di intervento estremamente comune sia a livello comportamentale quanto, soprattutto, a livello cognitivo (cioè covert) grazie all'impiego di elementi comunicazionali (verbali e non) che suscitano un effetto avversivo. Il fenomeno dell'estinzione non riguarda solo il condizionamento rispondente, ma anche quello operante, da cui i termini di "estinzione rispondente" ed "operante". Secondo il modello dell'apprendimento operante, una risposta di un soggetto viene mantenuta o modificata se rinforzata, intendendosi per rinforzo «l'aumento di probabilità che una risposta si ripeta, in seguito alla presentazione di un evento contingente positivo o ad eliminazione di uno negativo» (Davison, Neale, 1986, p. 626). Di conseguenza, se si vuole eliminare un comportamento ritenuto disfunzionale è necessario non rinforzarlo più, facendo cioè in modo che non sia seguito nè da eventi positivi nè dall'eliminazione di una condizione vissuta negativamente. Un'altra tecnica finalizzata alla riduzione della frequenza dei comportamenti fondata sul condizionamento operante è la punizione, le cui varianti sono essenzialmente due: 1) somministrazione di stimoli avversivi, 2) eliminazione di stimoli positivi. La punizione del primo tipo ha il grande vantaggio di ridurre, anche drasticamente, l'emissione di un comportamento disfunzionale. Nello stesso tempo può anche esitare in numerosi effetti collaterali negativi, come la paura, la fuga, la produzione di comportamenti di evitamento magari autolesionistici, l'apprendimento osservativo di atteggiamenti aggressivi, l'incrinazione di un eventuale preesistente rapporto terapeutico fondato sulla fiducia e sulla collaborazione. Inoltre la punizione di per sè dice cosa non fare ma non cosa fare e conseguentemente deve essere necessariamente integrata da altre tecniche di modificazione del comportamento. Esistono essenzialmente quattro tecniche operanti tendenti ad incrementare un comportamento:
Il rinforzo positivo è sicuramente la tecnica di condizionamento operante più sfruttata e duttile. Consiste essenzialmente nel fare seguire ad un comportamento spontaneamente emesso una conseguenza positiva. In una Comunità terapeutica i rinforzi positivi possono essere i più vari, andando dalla retribuzione monetaria, alla possibilità di uscire da soli fino alla semplice approvazione con un cenno del capo. Determinante è che tali rinforzi abbiano caratteristiche tali da essere reperibili nel maggior numero di situazioni e, soprattutto, nell'ordinario contesto sociale. Il rinforzamento negativo, invece, prevede che un vissuto spiacevole venga eliminato, attenuato o posticipato grazie all'emissione di un determinato comportamento. Un esempio di rinforzamento negativo in Comunità può essere la diminuzione dell'ansia o della depressione in un tossicodipendente che si confida con un altro utente o un operatore. L'efficacia di un rinforzamento può essere accresciuta in diversi modi. Innanzitutto, come già accennato, può essere applicato uno schema di rinforzamento costante se si intende fare apprendere ex novo un nuovo comportamento oppure se si ha a che fare con soggetti con ridotte o compromesse abilità di elaborazione cognitiva. Nello stesso tempo ci si orienta a rinforzare successivamente lo stesso comportamento in modo intermittente e per mezzo di rinforzi simbolici più che concreti. In questo modo ci si avvicina a ricalcare le effettive condizioni di rinforzo presenti nella dimensione quotidiana. Lavorando sugli aspetti cognitivi, inoltre, un medesimo rinforzatore può variare notevolmente la propria efficacia. Affidare un determinato compito di responsabilità ad un utente, per esempio, avrà un effetto incentivante se precedentemente si è fatto in modo di informarlo circa la rilevanza di tale incarico. L'apprendimento osservativo Nell'apprendimento osservativo sono distinguibili due momenti separati, il primo essendo l'osservazione propriamente detta, il secondo la prestazione. Nella prima fase risultano essere variabili determinanti lo status del modello e la similarità fra modello ed osservatore. Un modello autorevole avrà molte più possibilità di incidere col proprio esempio comportamentale. Allo stesso modo, quanto più il modello è simile all'osservatore (per sesso, età, convinzioni, caratteristiche psicologiche e culturali, etc.), tanto maggiore è l'eventualità che si verifichi un apprendimento duraturo. Per tale motivo l'impiego di modelli multipli incrementa l'efficacia delle tecniche di modeling, cioè facenti leva sull'apprendimento osservativo (Rachman, 1972). Sfruttando tale opzione è anche accresciuta la probabilità che l'osservazione dei differenti modelli produca un'integrazione fra essi ed una particolare ricombinazione da parte dell'osservante, così che si possa realmente parlare di un autentico apprendimento trasformativo, piuttosto che di semplice imitazione. Le conseguenze successive all'emissione del comportamento da parte del modello, poi, fanno sì che quanto osservato venga preso in considerazione come meritevole o meno di essere appreso ed applicato. La sola presenza di un modello attendibile che emette un comportamento avente conseguenze gratificanti non è però di per sè sufficiente a generare un efficace apprendimento osservativo. Sono infatti determinanti le variabili cognitive dell'attenzione, della ritenzione, della riproduzione e della motivazione (Bandura, 1977). Un soggetto, quindi, deve essere in grado di dirigere la propria attenzione sugli aspetti rilevanti di ciò che osserva, memorizzare e recuperare successivamente quanto osservato; le strategie di stoccaggio e di recupero mnestico devono quindi essere prese in considerazione nella preparazione degli interventi di modeling. Allo stesso modo, un individuo deve anche essere messo nella condizione di riprodurre quanto osservato così da perfezionarlo e consolidarlo attraverso valutazioni cognitive ed informazioni di ritorno provenienti, per esempio, dai canali cenestesici. Infine, non si verifica nessun grado apprezzabile di apprendimento osservativo o nessuna prestazione di quanto appreso se non è presente una sufficiente motivazione sia in fase di osservazione che in fase di prestazione. è importante comprendere che tecniche di modeling sono parimenti applicabili anche a livello immaginativo e simbolico, impiegando sia la semplice sollecitazione verbale (Sanavio, 1991) che l'immaginazione in stati modificati di coscienza o di semplice rilassamento (Lazarus, 1977; Sacco, 1994). Variabili cognitive Il trattamento in Comunità favorisce l'autocontrollo dell'utente incidendo su ognuna di queste tre categorie. L'auto-osservazione è enormemente potenziata dalla lucidità mentale nonchè dalla grande quantità di tempo a disposizione del tossicodipendente per osservare sè stesso in contesti ambientali e relazionali nuovi e stabili. Come affermato nel capitolo precedente, l'auto-osservazione può avere di per sè un effetto modificatorio temporaneo sull'emissione di un determinato comportamento in quanto fornisce feedbacks sulle componenti comportamentali, emotive e cognitive, spezzando l'automaticità dei comportamenti disfunzionali. Forme di auto-osservazione particolari possono essere rappresentate dall'impiego di videoregistrazioni e di schede di autovalutazione, nonchè dalla semplice auto-osservazione effettuata però in contesti particolari come le situazioni di gruppo ed i colloqui individuali, condizioni che stimolano l'utente ad esplorarsi interiormente ed a valutarsi da punti di vista non abituali. La pianificazione ambientale consiste nell'organizzazione del contesto esterno prima che si verifichi il comportamento disadattivo, attraverso il cosiddetto controllo dello stimolo. Per evitare ricadute nell'assunzione di sostanze stupefacenti è utile, per esempio, evitare luoghi frequentati da tossicodipendenti. Tale strategia viene effettuata inizialmente di concerto fra Comunità e utente, ma viene poi sempre più gradualmente interiorizzata dal tossicodipendente stesso così che impari ad evitare spontaneamente ed automaticamente determinati luoghi, persone o situazioni (prevenzione della risposta) oppure a ridurne la frequentazione (limitazione della risposta). Le attività di programmazione comportamentale consistono nel cambiamento della risposta di una persona di fronte a propri comportamenti. Ciò può avvenire attraverso due modalità: l'autorinforzo e l'autopunizione, entrambi impieganti il condizionamento operante per mezzo dell'auto-somministrazione o dell'auto-sottrazione di rinforzi tangibili o espressi verbalmente. Nel corso di un trattamento comunitario delle tossicodipendenze queste due modalità subiscono grandi trasformazioni, in quanto l'utente spesso non è inizialmente in grado di gratificarsi adeguatamente oppure nelle situazione opportune e, di converso, non utilizza sufficientemente l'autopunizione oppure ne fa un uso perverso e devastante. Il continuo apprendimento a livello cognitivo è utile per l'effettuazione di un'ottimale sensibilizzazione non manifesta, anch'essa utilizzabile ai fini dell'auto-controllo comportamentale. L'utente, sfruttando il principio del controcondizionamento avversivo, impara cioè ad autosomministrarsi a livello non manifesto stimoli avversivi quando si trova nella condizione di immaginare situazioni o comportamenti che in senso assoluto o per la sua particolare situazione sono da considerarsi disadattivi e dannosi. Le tecniche di autocontrollo non intervengono solo direttamente sullo stimolo, ma anche attraverso altri due fronti: a) la valutazione cognitiva dello stimolo e b) l'incremento di abilità. Ogni persona, infatti, decodifica l'ambiente, sia esterno che interno, impiegando mappe mentali costruite sulla base della propria esperienza e composte di schemi (cognitivi, emotivi, comportamentali, interpersonali), strategie, aspettative, sistemi di convinzioni, auto-asserzioni, pensieri automatici. Si può allora modificare il proprio comportamento incidendo direttamente sull'assetto cognitivo attraverso l'automonitoraggio del dialogo interno, la ricostruzione degli schemi cognitivi disfunzionali e l'autosomministrazione di asserzioni atte a ristrutturare o quantomeno a incrinare automatismi fondati su valutazioni cognitive distorte. Un tossicodipendente depresso, per esempio, può essere addestrato a fare fronte ai propri pensieri di autosvalutazione attraverso l'auto-monitoraggio e la compilazione di schede appositamente calibrate, passando successivamente al riconoscimento delle distorsioni cognitive presenti nelle sue auto-asserzioni ed alla produzioni di materiale cognitivo più "realistico". Con l'esercizio questo procedimento diventa sempre più automatizzato, così che non sarà praticamente più necessario riportare per iscritto alcun pensiero automatico, ma spontaneamente si reagirà all'aumentata percezione del dialogo interno distorto per mezzo di conoscenze ed abilità cognitive più raffinate ed efficaci (Beck, Rush et al., 1979). Le elaborazioni cognitive disfunzionali, soprattutto se assumono l'aspetto della coattività, possono anche essere controllate per mezzo di tecniche di arresto del pensiero, consistenti nell'indirizzare l'attenzione verso stimoli neutri, attività coinvolgenti o semplicemente alternative, così da non rimanere sopraffatti da dialoghi interni parassitari. Implicitamente questa metodica viene immediatamente insegnata ai tossicodipendenti in trattamento comunitario, in quanto la stessa Comunità può essere vista come una grande tecnica di arresto del pensiero nel momento in cui invita i suoi utenti, specialmente all'inizio del trattamento, ad applicarsi con costanza e tenacia in attività manuali che producono l'effetto di concentrare la mente sul presente liberandola dal devastante rimuginio interiore spesso presente in un soggetto che ha appena iniziato un percorso riabilitativo così difficile. Allo stesso modo, sfruttando nuove abilità assertive e di risoluzione di problemi (vedi oltre) l'individuo diventa sempre meno reattivo nei confronti degli stimoli elicitanti comportamenti disfunzionali, essendo più padrone del presente e della progettualità. Una variabile cognitiva che è sempre importante tenere in considerazione in qualsiasi processo di apprendimento è l'aspettativa di auto-efficacia, cioè «la convinzione di poter attuare con successo il comportamento necessario a produrre risultati voluti. Bisogna operare una distinzione fra le aspettative di efficacia e quelle del risultato, dal momento che alcuni soggetti, malgrado siano convinti che particolari azioni produrranno risultati sicuri, hanno dei seri dubbi sulle loro capacità di metterle in atto: in questo caso le informazioni non influenzano il comportamento» (Bandura, 1977). Nei tossicodipendenti è frequente riscontrare un livello di autoefficacia molto basso, e questo soprattutto nelle condizioni psicopatologiche più frequentemente ad essi associate: la depressione ed i Disturbi di Personalità. Allo stesso modo, spesso ritengono di non potere nulla contro alcune delle proprie difficoltà, di non essere in grado di fare fronte agli eventi poichè il locus of control (Rotter, 1966) degli stessi è posto all'esterno degli individui. Spesso infatti sentiamo dire dai tossicodipendenti che non possono cambiare perchè "è troppo tardi", perchè la famiglia, la società o il loro passato hanno determinate caratteristiche immodificabili. Se non vengono ristrutturate queste convinzioni, spesso profondamente radicate perchè fondate su "reali" e ripetute esperienze passate, difficilmente potremo ottenere risultati terapeutici appena decenti, a dispetto della precisione e della costanza con cui applicheremo i principi dell'apprendimento ai soggetti tossicodipendenti. Non c'è allora da stupirsi se i risultati con questi utenti si ottengano con tanta difficoltà, poichè è la stessa percezione di sè come individui ad essere intimamente minata, anche se, probabilmente, macrovariabili come il locus of control dovrebbero essere dettagliatamente valutate in funzione degli specifici contesti, così da assumere una configurazione multimensionale piuttosto che globale (Sanavio, 1991). Nel modificare l'impatto dello stimolo sull'elicitazione di determinati comportamenti disfunzionali sono poi molto utili le tecniche di rilassamento che, incidendo direttamente sul versante psicofisiologico, accrescono le capacità di controllo dell'ansia e di de-automatizzazione dei comportamenti. |
| Aggiornamento: Febbraio 2010 |