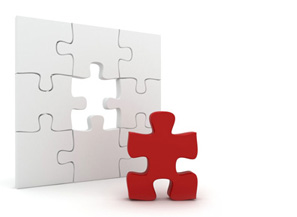

Eye Movement Desensitization
and Reprocessing (EMDR)
Cos'è la psicotraumatologia
|
|
Pubblicazioni on-line
|
|
Congressi e Formazione
|
|
Bibliografia
|
|
Consulenze gratuite
|
|
| Efficacia dell'EMDR nella psicoterapia del PTSD Fino a pochi anni fa la ricerca sull'efficacia della psicoterapia del PTSD era estremamente esigua (Shapiro, 1995). Negli ultimi anni, invece, questo settore ha collezionato un crescente numero di pubblicazioni sull'efficacia delle psicoterapie, e l'EMDR è uno degli approcci terapeutici che vanta il maggior numero di conferme di efficacia nella psicoterapia del PTSD. Nonostante le vivaci polemiche ed incomprensioni, questo stato di cose ha consentito all'EMDR nel 1995 di essere considerata "trattamento probabilmente efficace" (valutazione A/B) nella terapia del PTSD dalla Task Force on Psychological Intervention dell'American Psychological Association. Questa attribuzione di efficacia è spartita solo con lo Stress Inoculation Training e con le terapie basate sull'esposizione (Chambless et al., 1998). Più recentemente, l'EMDR è stata riconosciuta efficace nel trattamento del PTSD anche dall'International Society for Traumatic Stress Studies all'interno della pubblicazione delle sue linee guida per il trattamento del PTSD (Chemtob, Tolin, van der Kolk, Pitman, 2000). Al di là di ogni ragionevole dubbio, l'EMDR risulta essere una psicoterapia efficace per il PTSD, come dimostrano innanzitutto recenti reviews sull'efficacia dell'EMDR e studi meta-analitici sull'efficacia di differenti approcci terapeutici al PTSD, sia farmacologici che psicoterapeutici (Cahill, Carrigan, Frueh, 1999; Maxfield, 2000; Shepherd, Stein, Milne, 2000; Van Etten, Taylor, 1998), sebbene il meccanismo esatto del suo funzionamento sia al momento oscuro ed oggetto di speculazione (vedi oltre; per una rassegna sulle teorie al riguardo, Shapiro, 1995). A tale conclusione si arriva anche se vengono adottati rigidi criteri di selezione nella valutazione della metodologia delle ricerche (Shepherd, et al., 2000). Infatti, sono attualmente disponibili alcune ricerche ben strutturate sull'efficacia dell'EMDR nel PTSD, che sembrano non essere vanificate da sostanziali critiche metodologiche (i.e.: Marcus, Marquis, Sakai, 1997; Rothbaum, 1997; Scheck et al., 1998; Wilson, Becker, Tinker, 1995, 1997), con follows-up fino a 15 mesi (Wilson et al., 1997); con ciò tali studi si differenziano da una parte non irrilevante di letteratura sull'EMDR, anedottica o sprovvista di adeguata o verificabile evidenza sperimentale (Shepherd et al., 2000), diventata bersaglio (a volte correttamente) di alcuni critici. Fra le ricerche più accreditate alcune sono caratterizzate dalla presenza di valutatori indipendenti dell'efficacia dell'intervento con l'EMDR o con altri interventi o dell'inclusione in una lista d'attesa (Carlson, Chemtob, Rusnak, Hedlund, Muraoka, 1998; Rogers et al., 1999; Rothbaum, 1997; Scheck et al., 1998; Vaughan et al., 1994). Le ricerche, globalmente considerate, hanno dimostrato l'efficacia dell'EMDR in una grande varietà di situazioni traumatiche connesse al PTSD: guerre recenti o lontane nel tempo, incidenti e ustioni, violenze sessuali attuali o pregresse, calamità naturali, lutti, azioni terroristiche. Sintetizzo succintamente alcuni dati provenienti da alcune fra le pubblicazioni di maggior rilievo e che non verranno ripresi nel prosieguo. Rothbaum (1997). Un campione di 21 donne vittime di stupro è stato trattato con quattro sedute di EMDR da 90 minuti a cadenza settimanale. L'assessment pre- e post-trattamento (a tre mesi) è stato effettuato da un valutatore indipendente all'oscuro sul tipo di intervento effettuato. Strumenti psicodiagnostici utilizzati: PTSD Symptom Scale (PSS; Foa, Riggs, Dancu, Rothbaum, 1993), Impact of Event Scale (IES; Horowitz, Wilner, Alvarez, 1979), Rape Aftermath Symptom Test (RAST; Kilpatrick, 1988), State-Trait Anxiety Inventory (STAI; Spielberger, Goruch, Lushene, 1970), Back Depression Inventory (BDI; Beck, Ward, Mendelsohn, Mock, Erbaugh, 1961), Dissociative Experience Scale (DES; Bernstein, Putnam, 1986) più altri reattivi psicodiagnostici meno noti. Il 90% dei soggetti non ha più soddisfatto i criteri per la diagnosi di PTSD, contro il 12% dei soggetti di controllo, cioè una lista di attesa. Un valutatore esterno ha valutato l'elevato grado di adeguamento al protocollo EMDR. Wilson et al. (1995, 1997). Un campione di 80 soggetti vittime di traumi (di cui 37 con diagnosi di PTSD) sono stati trattati con tre sedute da 90 minuti di EMDR, con attribuzione randomizzata ad un terapeuta, con assessment pre- e post-trattamento effettuato da un valutatore indipendente. Strumenti psicodiagnostici utilizzati: IES, STAI, Symptom Check List (SCL 90-R; Derogatis, 1992), misurazioni soggettive di intensità del disagio e della ristrutturazione cognitiva (SUDS: Subjective Units of Disturbance Scale e VOC: Validity of Cognition Scale) e Post-Traumatic Stress Disorder Interview (PTSD-I; Watson, Juba, Manifold, Kucala, Anderson, 1991). L'EMDR è risultata globalmente efficace rispetto ai soggetti in attesa di trattamento nei controlli effettuati a 30 e 90 giorni. A 15 mesi di distanza è stata registrata una riduzione dell'84% delle diagnosi di PTSD. Marcus et al. (1997). Un campione di 67 soggetti con diagnosi di PTSD è stato trattato con assegnazione randomizzata con tre sedute da 90 minuti di EMDR. Un valutatore indipendente ha valutato la condizione pre- e post-trattamento attraverso: SCL-90, BDI, STAI, SUD, IES, Modified PTSD-Scale (Falsetti, Resnick, Resnick, Kilpatrik, 1993). Il 100% dei soggetti vittime di un solo trauma e l'80% dei soggetti pluritraumatizzati non hanno più soddisfatto i criteri per la diagnosi di PTSD, risultati molto superiori rispetto al controllo, ovvero al trattamento standard del Kaiser Permanente Hospital, composto da terapia individuale (o cognitiva, o comportamentale o psicodinamica) più terapia farmacologica, più terapia di gruppo (riferirsi alla pubblicazione per maggiori precisazioni). Scheck et al. (1998). 60 donne di età compresa fra i 16 ed i 25 anni, vittime di stupro, sono state assegnate in modo randomizzato a due sedute di EMDR o di "ascolto attivo" (Gordon, 1974). La valutazione pre- e post-trattamento è stata effettuata in modo indipendente attraverso i seguenti strumenti: BDI, STAI, Penn Inventory for Posttraumatic Stress Disorder (Hammarberg, 1992), IES, The Posttraumatic Stress Disorder Interview (PTSD-I; Watson et al., 1991), Tennessee Self-Concept Scale (Roid, Fitts, 1991). L'EMDR si è dimostrata più efficace dell'ascolto attivo su tutti i parametri. Nonostante la brevità dell'intervento, i valori registrati dai soggetti trattati con EMDR sono risultati, per tutti gli strumenti utilizzati, non significativamente diversi da quelli della popolazione generale o da quelli dei gruppi normativi trattati con successo. L'EMDR ed altre psicoterapie nella psicoterapia Lo studio meta-analitico di Van Etten e Taylor (1998) indica che l'EMDR ha una efficacia uguale a quella dello Stress Inoculation Training, ma porta i pazienti a non soddisfare più la diagnosi di PTSD in un tempo minore (4.6 contro 14.8 sedute). L'EMDR sembra essere ugualmente efficace delle terapie comportamentali basate sull'esposizione (Boudewyns et al., 1993) e del training di abituazione immaginativa accoppiato al rilassamento muscolare (Vaughan et al. 1994), più efficace del biofeedback (Foa, Meadows, 1997; Carlson et al, 1998) e dello ascolto attivo nella tradizione di Carl Rogers (Scheck et al., 1998), meno efficace della variante cognitivo-comportamentale rappresentata dal Trauma Treatment Protocol (Devilly, Spence, 1999). L'EMDR è risultata meno efficace degli SSRIs nel trattamento della depressione associata al PTSD (Van Etten, Taylor, 1998), ed inoltre la sua efficacia in questo ambito varia notevolmente all'interno degli studi (Maxfield, 2000) e non è ancora adeguatamente compresa (Cahill et al., 1999). Rispetto alla terapia comportamentale basata sull'esposizione, l'EMDR si è dimostrata superiore nel ridurre i sintomi intrusivi (Van Etten, Taylor, 1998; Rogers et al., 1999) e più confortevole per i pazienti (Rogers et al., 1999). Nello studio di Van Etten, Taylor (1998), attraverso la confrontazione fra 61 studi sulla psicoterapia e la farmacoterapia del PTSD, emerge che l'EMDR, insieme alla terapia comportamentale (esposizione in vivo, immaginativa e mista), sembra essere l'intervento più efficace se paragonato ad un ampio spettro di altre forme di intervento: supporto psicologico, ascolto attivo, psicoterapia psicodinamica, ipnotica e training di rilassamento (Van Etten, Taylor, 1998); le pubblicazioni utilizzate per la comparazione con gli ultimi tre di questi approcci sono comunque estremamente ridotte, e quindi i risultati non possono assolutamente considerarsi definitivi. Nonostante l'apparenza di una sostanziale equivalenza rispetto ai risultati delle terapie comportamentali o cognitivo-comportamentali, l'EMDR sembra ottenere i medesimi risultati in tempi sensibilmente inferiori (i.e.: Foa, Rothbaum, Riggs, Murdock, 1991; per una rassegna di comparazioni: Shapiro, 1995, 1999, 2000). In ogni caso, l'evidenziazione di definitive ed univoche differenze in quest'ultimo ambito è attualmente impossibile poichè l'EMDR è stata confrontata con differenti modelli di intervento comportamentale o cognitivo-comportamentale a causa dell'assenza di omogeneità fra questi approcci terapeutici (Shapiro, 2000). L'EMDR, invece, dal 1995 in poi ha adottato un unico protocollo di intervento per il PTSD (anche se Rosen, 1999, nega tale evidenza) e quindi, laddove tale protocollo sia stato applicato correttamente e da terapeuti adeguatamente formati, gli studi degli ultimi cinque anni rappresentano un corpus di letteratura omogeneo. Inoltre, la quasi totalità delle affermazione sulla differente efficacia fra EMDR e tecniche cognitivo-comportamentali si basa su comparazioni effettuate paragonando molteplici ricerche dove si applica uno o l'altro metodo (Cahill et al., 1999). |
| Aggiornamento: Febbraio 2010 |