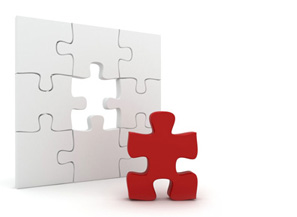

Psicoterapia Cognitivo-comportamentale
Cos'è la psicotraumatologia
|
|
Pubblicazioni on-line
|
|
Congressi e Formazione
|
|
Bibliografia
|
|
Consulenze gratuite
|
|
| L'importanza
del cognitivismo contemporaneo L'approccio al quale facciano riferimento pensiamo sia di ampio respiro e non incontri le secche epistemologiche e riduzionistiche del comportamentismo cosiddetto "radicale" di diretta derivazione skinneriana. Il modello di uomo con il quale argomentiamo e discutiamo è si plasmato dal condizionamento classico ed operante, ma apprende anche per osservazione, è inserito e si è sviluppato all'interno di una complessa rete di relazioni sociali ed è provvisto di un "sistema del Sè" (Bandura, 1978, 1985; Guidano, 1987, 1991; Safran, Segal, 1990; Stern, 1985) con funzione conoscitiva e regolativa, caratterizzato da aspettative, schemi di pensiero, fantasie, immaginazione ed emozioni (Beck, 1976, 1979; Beck, Freeman, 1990; Ellis, 1962; Meichenbaum, 1985), il cui scopo principale è il mantenimento del senso di coesione e di continuità dell'identità individuale (Liotti, 1984, 1993c; Guidano, 1984, 1987, 1991). Un tale orientamento è allora reso sofisticato mediante il ricorso alle teorie cognitive classiche (Beck, 1976, 1979; Ellis, 1962), cioè di tipo "associazionistico" (Reda, Mahoney, 1984). Queste concezioni sostengono globalmente che il comportamento, le emozioni e le modalità relazionali sono in stretta relazione con una serie di fattori cognitivi non direttamente osservabili come gli schemi di pensiero, le cognizioni, le autoasserzioni ed il dialogo interno, variabili sulle quali è opportuno incidere per ottenere cambiamenti terapeutici duraturi. Nello stesso tempo teniamo anche nella massima considerazione approcci più recenti che presuppongono il primato di un livello tacito dell'elaborazione dell'informazione che funge da impalcatura di base per ogni esperienza e pensiero degli individui; viene anche riconosciuto il principio regolatore dell'attività psichica umana nella ricerca di coerenza, del pieno sviluppo della identità di sè e della continuità storica. Questo approccio, detto "costruttivistico" (Bara, 1984; Guidano, 1984, 1987, 1991; Liotti, 1984, 1993; Reda, Mahoney, 1984), concepisce l'oggetto della psicologia cognitiva tradizionale (schemi di pensiero, distorsioni cognitive, aspettative, etc.) come la struttura superficiale del livello organizzativo implicito che continuamente occorre trasformare in esplicito per produrre conoscenza, autocoscienza, coerenza, senso di continuità e identità personale. Il livello implicito sarebbe poi in gran parte modellato sulle esperienze fondamentali instaurate con le principali figure di attaccamento, relazioni che, pur avendo un'origine antica, manifestano prepotentemente il proprio peso sia nel presente che nelle possibili proiezioni nel futuro (Liotti, 1992a, b; 1993a, b; 1994). Il passato delle persone non deve allora intendersi in modo statico, ma piuttosto come una continua ricostruzione a partire dai processi di pensiero e di memoria operanti nel momento presente (Bara, 1984). Con questa visione dell'uomo non si può più dire allora che «il passato è passato e non si può cambiare», ma il Sè è pensato come un «processo di elaborazione della memoria» (Liotti, 1984, p. 263), poichè «attraverso i processi e le strutture mentali esistenti che operano nell'adesso del sistema, il sistema produce il proprio passato, presente o futuro soggettivo» (Bara 1984, p. 62). Nel rapporto terapeutico, allora, quest'ultima attività è monitorata, incrementata e diretta, in modo tale che anche i vuoti «tra un episodio e l'altro [che] sono solitamente riempiti da processi di soluzione di problemi o processi di ragionamento» (Bara, 1984, p. 63) vengano riformulati all'interno di una costruzione più coerente e coesa della storia personale. La struttura profonda di un soggetto in trattamento, quindi, se opportuno può e deve essere ricostruita all'interno di un rapporto terapeutico dotato di una funzione contenitiva, catalizzante, riparativa ed elaborativa (Safran, Segal, 1990). Una diversa relazione interpersonale, unita a nuovi apprendimenti, informazioni ed equilibri psicofisiologici, può cioè permettere un raccontarsi ed un ricostituirsi differente della propria individualità, possibilmente attraverso un meno frammentato e distorto processo di integrazione fra le discordanze esistenti fra il livello tacito ed esplicito dell'elaborazione delle informazioni e dell'esperienza umana nella sua globalità (Guidano, 1991). Un approccio ai disturbi cognitivi di tipo dialettico e persuasivo (cioè il cognitivismo cosiddetto associazionistico) dimostra invece i suoi limiti in quanto intervento "di superficie" (Guidano, 1987, 1991), non potendosi sistematicamente e programmaticamente estendere a tutte le dimensioni temporali di un individuo per mezzo di un cambiamento profondo delle strutture cognitive. Nell'ottica costruttivista «il risalire alle prime esperienze, all'origine dei processi cognitivi distorti di un adulto, può essere invece un punto di svolta nel corso del processo di psicoterapia cognitiva, un punto in cui si verificano un distanziamento ed un decentramento realmente stabili dalle proprie presupposizioni» (Liotti, 1984). Questa impostazione, poi, fornisce spiegazione e strategie operative in quei casi in cui interventi di superficie si dimostrano poco incisivi perchè si scontrano con schemi di elaborazione tacita risalenti ad antiche esperienze di attaccamento disfunzionale di difficile rielaborazione, come spesso accade nella psicoterapia dei Disturbi di Personalità. |
| Aggiornamento: Febbraio 2010 |