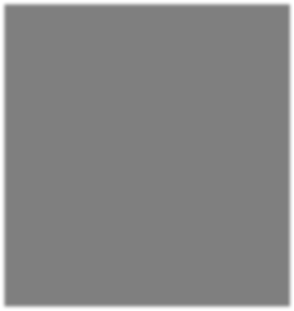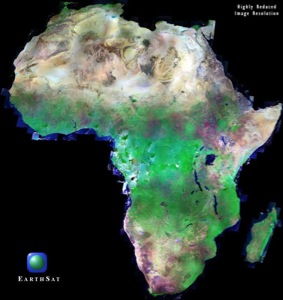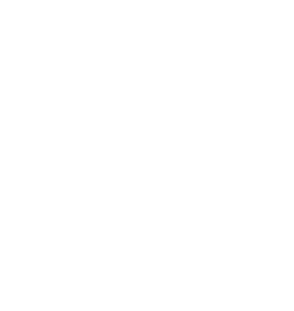Globalizzazione e marxismo
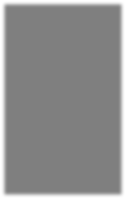

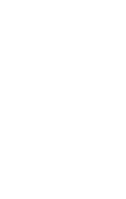
Appare utile una rilettura in termini attuali del pensiero di uno dei più acuti studiosi delle società capitalistiche fin dal loro sorgere ed affermarsi, per facilitare la comprensione del profilo che presentano in una fase, come quella in sviluppo, densa di pericoli e non solo di promesse di un progresso stupefacente. Proporsi come terreno di ricerca da parte della nostra Associazione di Cultura Critica quello dell’attuale situazione mondiale, definita in modo generico “ Globalizzazione “, facendo ricorso all’intera ricerca svolta da Carlo Marx nel corso della sua esistenza, ricorso che abbiamo definito “Attualità del marxismo “, rappresenta una scelta difficile e nuova all’interno dell’interesse per Marx, che è peraltro in ripresa diffusa.
la consapevolezza che non è sufficiente una semplice ripresa di interesse per garantire che non si tratti di un pur importante fatto culturale bensì della necessità di ritrovare un orientamento valido nell’affrontare la situazione mondiale attuale che si sviluppa in forme sempre nuove. Cosa che gia di per se rende ancora più indaginosa ogni ricerca sulle cause di fondo di questa sua caratteristica, resa possibile però dalla consapevolezza che il suo pensiero,gia nel passato, ha inciso in profondità sugli equilibri politici del mondo intero, sia attraverso l’attività dei partiti socialisti, socialdemocratici, comunisti, sia con l’attività di quei sindacati che hanno avuto un forte spirito di classe,sia soprattutto, attraverso le modifiche dei rapporti di forza tra le tradizionali potenze capitalistiche e quelle nuove, socialiste, sorte nel ‘900. Quel pensiero è ancora utile per fornire risposte valide oltre che per guidare oggi il difficile compito delle forze di progresso in questa nostra epoca drammatica verso sbocchi che riescano a salvare sia lo sviluppo del progresso che l’umanità che lo ha prodotto ?
Di attualità del marxismo non può certo parlarsi, agli inizi degli anni 2000,sul piano di una riaffermazione pura e semplice di tutte le tesi affermate da Marx nel corso della sua lunga ricerca a fronte della realtà economico-sociale del XIX secolo. Non c’è infatti nulla di più estraneo al pensiero di Marx che un atteggiamento acritico e di cieca fedeltà al testo che non tenga conto dei radicali cambiamenti intervenuti nelle realtà delle società avanzate e nel mondo intero e non cerchi di comprenderne il senso. Proprio per questo meraviglia, tra l’altro, che dopo il crollo del cosiddetto “ socialismo reale “ da parte degli esponenti politici di formazione marxista ( non forse di studiosi )si assista ad un mutismo ed a una mancanza di nuove elaborazioni di fronte ai cambiamenti ed ai fenomeni che hanno sconvolto e continuano a sconvolgere lo scenario mondiale.
Il nostro è un impegno per dare una risposta utile a tanti quesiti, da esaminare criticamente, certo, ma col rigetto di ogni residuo di impostazioni propagandistiche pro o contro il socialismo o contro i partiti comunisti che, nati nel ‘900 dai partiti socialisti gia orientati dal marxismo, hanno provocato reazioni di paura da parte di quanti temevano una presa ancora più piena tra le masse operaie ( e non solo di quelle) delle idee rivoluzionarie di Marx, con la sua penetrante analisi delle caratteristiche del suo secolo. Occorre in primo luogo sgomberare il campo dai troppi tentativi di imbalsamare il pensiero di Marx, tesi a congelare il riesame alle formulazioni che corrispondevano ad una fase superata storicamente gia nel corso delle ricerche dello stesso Marx. Analisi che aveva esaminato nell’800 la rapida espansione del capitalismo nella produzione di beni di ogni genere, assieme a quella degli strumenti per sempre nuovi impianti industriali. Si trattava di un processo produttivo storicamente nuovo, comparso e sviluppatosi nel secolo precedente e che si era rapidamente sostituito alla antiquata produzione feudale-corporativa ma entro le vecchie strutture sociali e che tendeva necessariamente a rivoluzionare gli assetti ormai obsoleti delle società che lo avevano espresso. Idee scaturite in Marx sia dalla precoce attenzione alle sofferenze dei più deboli nella società, come il nuovo proletariato industriale, sia dalla analisi storica ed economica sul nuovo meccanismo produttivo che aveva consentito per la prima volta nella storia, assieme ad una più rapida ed abbondante produzione di beni di consumo, anche la formazione altrettanto rapida di ingenti ricchezze provenienti dal plusvalore ottenuto dai nuovi capitalisti a spese dell’intenso sfruttamento del lavoro operaio. Nuovo meccanismo ,dunque, ma gia così efficace per il padronato che tra l’’8oo ed il ‘9oo aveva consentito l’accumulo di immense ricchezze ad un polo della società mondiale dell’epoca, rendendolo sempre più esclusivo padrone delle ricchezze prodotte dall’intera società umana. Fenomeno anche questo sconosciuto in precedenza nella storia, che si esteso ormai all’intero pianeta. Mentre all’altro polo, si aggravava l’esistenza di immense masse popolari in gravi difficoltà, con massicce aree di miseria e di disoccupazione, con la spinta crescente, da quelle epoche in poi, ad emigrare da parte di milioni di disperati verso i paesi ritenuti più floridi, nella speranza di procurarsi un avvenire diverso da quello al quale erano condannati nella loro terra di origine. Oggi tra le più acute cause di tragedie tra quanti sono alla ricerca di lavoro nei paesi più poveri del mondo.
0ccorre approfondire dunque cosa vi è ancora di stimolante anche per l’oggi nelle idee e nelle analisi di Carlo Marx , frutti di una mente certamente eccezionale che si è saputa misurare con i nuovi problemi sorti nella sua epoca caratterizzata da una storia che ormai appare tanto lontana e quasi sfocata, eppure distante da noi poco più di un secolo, e trapassata poi nel turbinio del tremendo 1900.
Nuovo secolo, questo ultimo, che ha visto tra le cose più tragiche conosciute dall’umanità due devastanti guerre mondiali che, tra l’altro, anziché favorire solo qualcuna delle potenze coloniali dell’epoca che si combattevano ormai con le armi, hanno determinato anche le condizioni per delle rivoluzioni che hanno causato successivamente gravi difficoltà alle borghesie stesse dei maggiori paesi del mondo. Secolo che ha visto inoltre emergere il gravissimo rischio dell’uso dell’energia atomica per scopi bellici (la realizzata distruzione istantanea di Hiroshima e di Nagasaki da parte degli Stati Uniti ancora pesa sulla coscienza moderna), oltre che a dare vita a un ulteriore susseguirsi di altre guerre, di stragi di massa, di saccheggi e di miseria diffusa, e che ha consegnato ancora al XXI secolo sempre nuove guerre, un terrorismo che si espande, la fine dell’inopinato unipolarismo degli USA (realizzato approfittando del crollo dell’Urss) sostituitosi al bipolarismo precedente. Crollo che ha fatto emergere, tra i tanti fattori che vi hanno contribuito, le cause di fondo dei risvolti teorici della fine dell’esperimento del cosiddetto “ Socialismo reale “ durato 73 anni, consistenti in un marxismo inteso come estremo sviluppo dell’industrialismo, con la crisi del soggetto rivoluzionario centrale di riferimento quale la classe operaia, conseguente anche alle trasformazioni del soggetto dominante capitalistico nel mondo da borghese industriale a èlite finanziaria. Fine dell’unipolarismo USA e inizio di una fase di multipolarismo provocata anche dal comparire sulla scena mondiale di nuovi giganti dell’economia quali la Cina, l’India, il Brasile ed altri minori in vari continenti.
Occorre sottolineare che la sfrenata ricerca del profitto va determinando anche i gravi fenomeni macroscopici che sono sotto gli occhi di tutti quali la devastazione della natura e il pericoloso l’effetto serra che pongono problemi del tutto nuovi che non hanno riscontro con alcuna fase del passato dell’umanità e che prospettano un avvenire sempre più a rischio per le popolazioni del mondo intero e per la sopravvivenza della specie umana, se non si modifica radicalmente il modello di produzione di vita civile e di consumo.
Marx si era cimentato a fondo con i problemi che sorgevano per la prima volta nella società umana col capitalismo. Aveva cercato di approfondire e fare emergere la principale contraddizione insita nel nuovo meccanismo produttivo ed i problemi anch’essi del tutto nuovi che quello induceva all’interno delle società che si avviavano a superare, soprattutto in Inghilterra ed in Francia (qui a seguito della allora recente rivoluzione del 1789) tutti gli assetti giuridici, politici, culturali, sociali, ideali, di società ancora impregnate di residui feudali. In particolare era riuscito a comprendere la portata della contraddizione più netta emersa in quel periodo, consistente nella contrapposizione di interessi tra la nuova classe, il proletariato, sorta nella storia nel momento stesso in cui nasceva la borghesia capitalistica. Classe che si era gia affacciata in Francia nella rivoluzione del 1789, pur se in forme non organizzate ne sindacalmente ne politicamente, o con qualche consapevolezza ideale, ma che mostrava,gia a quel tempo, la tendenza ad una autonomia politica, culturale e ideale dalla borghesia, che la repressione non riuscì a sopprimere ma solo ad impedire( anche se a lungo) che potesse dare luogo a strutture politiche autonome. Autonomia che si manifestò poi rapidamente con la formazione di una “ Lega dei giusti “ trasformatasi in “ Lega dei comunisti “ alla quale aderirono, come è noto, Marx ed Engels gia noti per le loro idee rivoluzionarie e dalla quale ricevettero l’incarico di enunciare il programma politico della Lega. Programma che apparve nel 1848 col titolo, ormai ben conosciuto persino da quanti non lo hanno mai letto di “ Manifesto del Partito Comunista “. Uno dei testi che, in particolare, ha dato origine ai molti tentativi di dissacrazione del pensiero di Marx, che va invece correttamente collocato e compreso nel contesto storico e negli scopi politici ravvicinati che si proponeva e che con quel documento è riuscito, assieme ad Engels, a dare una prospettiva al possibile sbocco rivoluzionario immanente nella contrapposizione, ormai già tanto marcata, tra la borghesia ed il proletariato, al quale ultimo forniva in tal modo anche gli elementi per la rapida crescita di una coscienza di classe autonoma. Quel testo da allora in poi sempre tanto discusso e spesso male interpretato, può essere infatti correttamente compreso solo nel contesto storico e politico di una fase di rivoluzioni diffuse in tanta parte d’Europa che si svolsero tra il 1848 ed il 1850, rivoluzioni che videro i nuovi proletari tra i più risoluti protagonisti. Fase che si esaurì senza risultati politici utili per la nascente classe operaia ma che concorse a dare successivamente vita ad un profondo cambio di orizzonti, del tutto diversi dal recente passato rivoluzionario europeo, che notevolmente alla successiva crescita del movimento operaio.
Quanti hanno creduto di poter ipertrofizzare il significato delle espressioni di quel testo ricco di analisi originali e di formulazioni avanzate, che individuava la possibilità di altre future rivoluzioni in Europa guidate dalla classe operaia, contro un capitalismo sempre più invadente, ed individuava nella nuova classe l’affossatrice della società borghese-capitalistica, per dare luogo a delle società socialiste, dinanzi al mancato riscontro nei decenni successivi, di quanto sembrava ipotizzato in quel testo ( che ovviamente invece non poteva avventurarsi in previsioni specifiche ne sui tempi effettivi ne sui luoghi dove avrebbero potuto realizzarsi le possibili rivoluzioni ) hanno reagito con una disillusione totale che ha finito con l’investire l’intera opera di Marx. Non essendosi realizzato in quel unico modo lo sviluppo successivo profilato a loro dire nel Manifesto, molti, frettolosamente, hanno giudicato fallite non solo le previsioni ( che erano indicate solo come linee di tendenza ) ma anche l’insieme di quelle analisi che Marx ed Engels avevano prospettato. Posizioni che ancora oggi ignorano di fatto, più o meno consapevolmente, che la storia cambia in continuazione e che occorre saper cogliere il filo fondamentale dello sviluppo e non cercare, attraverso l’opposizione astratta, le motivazioni per indebolire l’azione rivoluzionaria, in qualunque forma si presenti ancora oggi, a seconda delle concrete condizioni storiche delle masse, attualmente non meno duramente sfruttate del passato
. Perché questo suggerisce ancora oggi la rilettura di Marx. In considerazione del fatto che, dovrebbe essere ovvio, ma che invece pare ignorato, che le trasformazioni tecnologiche avvenute nei processi produttivi di ogni settore merceologico, quelle scaturite dalle conseguenti trasformazioni delle qualifiche avvenute dentro la composizione della classe operaia, ne hanno certo modificato il profilo come si presentava nell’ottocento, ma non l’oggettiva contrapposizione agli interessi della borghesia,.classe divenuta poi non più elemento pressoché unico di opposizione sociale al meccanismo capitalistico. Dal suo interno ed affianco ad essa si sono prodotte naturalmente profonde modifiche dell’intero mondo del lavoro, anche fuori dalla produzione industriale, tali che dovevano necessariamente cambiare gli scenari politici e sindacali più caratteristici dell’800 ed accrescere però, nel contempo, gli oppositori ad un meccanismo produttivo che,nel suo insieme, sempre più viene avvertito da grandi masse popolari, da studiosi e spesso anche da settori della stessa borghesia, come un pericolo per l’ambiente, la salute e la sopravvivenza della specie umana.
La paura dei capitalisti per questa nuova e originale situazione culturale e politica alimenta ancora oggi l’ostilità verso chi come Carlo Marx aveva saputo fornire i primi solidi elementi alla critica di massa del capitalismo e non solo al proletariato. Continua, pertanto, l’ondata critica demolitrice, che del resto appare dura a morire, al punto che oggi molti non riescono nemmeno ad accorgersi delle nuove pesanti contraddizioni che, affianco a quelle di classe, nascono ininterrottamente dall’attuale espansione del capitalismo nel mondo. Segnatamente in rapporto alla continua aggressiva ricerca di materie prime e di un sicuro dominio su tutte le terre extra europee, ancora col ricorso ( anche se oggi in forme diverse ma quasi sempre no0n meno tragiche col neo colonialismo USA) alla nota e feroce ondata della colonizzazione dei secoli scorsi, che a sua volta diede origine a contrasti tali tra le grandi potenze da sfociare nelle gia ricordate due sanguinose guerre mondiali, che continuano con le dure tensioni attuali.
. Mentre il pensiero di Marx ancora una volta aveva dato luogo ad uno sviluppo teorico di elevato valore laddove è stato usato per aumentare la sua funzione rivoluzionaria, come è avvenuto in Russia con Lenin, che diede vita ad un nuovo impulso al marxismo e condusse ad un nuovo sviluppo critico originale che consentì di individuare l’analisi del nuovo fenomeno dell’imperialismo. O come in Cina con Mao Tse Dong, col quale il marxismo è riuscito ad estendere la sua visione alle potenzialità nuove dell’immenso mondo contadino di quel paese, collocandolo all’interno della lotta del terzo mondo contro lo sfruttamento capitalistico. In entrambi i casi ( unici episodi riusciti di rivoluzioni tendenti al socialismo,a conferma che le rivoluzioni, se non sono storicamente necessarie, non diventano nemmeno vittoriose) fu mantenuto, tra l’altro, anche l’impegno preso solennemente dalla II Internazionale nel 1914 di indicare ai partiti socialisti e socialdemocratici la necessità di opporsi alla guerra che si stava chiaramente organizzando e di trasformare, laddove non si otteneva l’abbandono di quei preparativi, la gravi crisi della propria società coinvolta in quei preparativi, in rivoluzioni contro quelle borghesie che mostravano l’ intenzione di scatenare la guerra. Come avvenne però solo in Russia a seguito della I guerra mondiale ed in Cina con caratteri peculiari a seguito della feroce invasione giapponese nella II guerra mondiale. Cosa che ha portato i marxisti ed i loro alleati minori a governare quegli immensi paesi, sconvolgendo del tutto i vecchi e precari equilibri tra le potenze capitalistiche. Processi, quelli nuovi, del resto venuti in luce di gia nel 1905, ad appena 22 anni dalla morte di Marx, con l’esplosione della prima rivoluzione russa antizarista che resistette fino al 1907 prima di essere del tutto schiacciata. Seguita però un decennio dopo da quella ben più organizzata ma questa volta vittoriosa, del 1917 nel corso della prima guerra mondiale, da parte dei soviet dei soldati, degli operai e dei contadini, e vittoriosa perchè orientata strategicamente da Lenin.( Materie importanti ma che non possono essere qui sviluppate perché esulano dal nostro impegno su Marx ).
Nel secolo XX sono divenute sempre più gravi ed esplicite le tante e nuove contraddizioni che, senza nulla togliere a quella principale tra capitale e lavoro, vanno crescendo a dismisura man mano che il capitalismo si espande sempre più nel mondo. L’approccio più produttivo per comprendere l’entità di tali novità appare quello di esaminare a fondo ancora una volta Marx, correttamente ed in profondità, che seppe cogliere nelle società della sua epoca il nesso sempre esistente, nella sua qualità di filosofo rivoluzionario ad orientamento materialistico dialettico e storico, tra le caratteristiche della formazione economica-sociale di quella fase storica del modo di produrre e le caratteristiche nuove della sovrastruttura filosofica, culturale , morale,giuridica e così via, che si modificava nelle società che ne venivano trasformate di pari passo. Cosa che gli consentì tra l’altro di divenire un dirigente politico della I Internazionale dei più abili del suo tempo oltre che uno dei più approfonditi e capaci studiosi del nuovo meccanismo produttivo di quell’ epoca. Non certo un profeta mancato, come talvolta vorrebbe sostenere insulsamente la vulgata.
Un meccanismo produttivo, quindi, che se ha consentito un veloce ed ampio sviluppo della civiltà nei paesi nei quali era nato ( Europa e la sua successiva espansione nel nuovo continente, in particolare negli Stati Uniti d’America ) ha anche mostrato fin dall’inizio di avere una doppia qualità: un più efficace sistema produttivo,un intensa capacità di produrre ricchezza, sempre a scapito delle masse proletarie alle quali veniva estorta una massa di plusvalore ( da trasformare al più presto in elevati profitti ) distribuendo agli operai salari di fame e praticando l’ intenso sfruttamento non solo di operai maschi, giovani o adulti, ma anche di donne e bambini. Sfruttamento che resta a tutt’oggi in tutti paesi del mondo una condizione che investe l’insieme del personale dipendente, qualsiasi rapporto abbia dovuto stabilire con il capitalista ( solo o associato in modi che anch’essi variano), che nell’evolversi continuo della tecnologia, coinvolge ormai non più solo la massa operaia ma anche i tecnici,il personale amministrativo di ogni tipo e quello di livello scientifico dipendente o solo collegato col complesso produttivo. Oltre ad essere dilagato in settori non produttivi attraverso spregiudicate attività finanziarie dalle quali ricavare comunque alti profitti che vanno ad ingrossare la speculazione finanziaria mondiale e modificano notevolmente il profilo originario del capitalismo stesso, che pur aveva presentato al suo sorgere anche una valenza di progresso che si è andata però stemperando sempre più col risultato inevitabile di produrre anche nuovi avversari a tanta frenetica avidità nella maggior parte della società mondiale, sempre più sfruttata. Oltre a provocare assai spesso decise reazioni anche di gran parte del mondo scientifico e intellettuale in quasi tutti i paesi .
Da questo insieme di problemi emerge un primo importante elemento della nostra analisi: ancora dopo tre secoli di capitalismo affermato, alla base della ricchezza complessiva che si produce nel mondo intero, rimane uno sfruttamento avido e senza scrupoli del tutto simile a quello dei secoli precedenti. Le novità scientifiche e le conquiste tecnologiche del mondo intero non sono andate a vantaggio dell’intera società mondiale che le aveva espresse, ma nemmeno delle attuali centinaia e centinaia di milioni di lavoratori di ogni età, dai bambini alle donne, addetti alle nuove strutture produttive dei paesi emergenti o colà delocati dalle patrie del capitalismo, trattati oggi come in passato, ancora peggio dei loro colleghi maschi o più anziani; stressati oggi come ieri da orari incontrollati e da paghe del tutto insufficienti e ancora una volta soggette a repressioni d’ogni tipo se avanzano delle proteste. Ma ancora oggi, come per il passato, tali condizioni non sono più solo oggetto di esame critico da parte degli elementi più avanzati delle diverse società quanto anche dal giornalismo di stampa o di quello televisivo odierno che non può ignorare la realtà e la fa conoscere ad ampi strati di popolazione vicina e lontana. Cosa preziosa, anche se non esente, spesso, da esigenze politiche redazionali e dal condizionamento che proviene dallo scontro politico in corso a livello mondiale. Per cui accade più di frequente di leggere quello che concerne le condizioni lavorative presenti attualmente nei paesi emergenti come la Cina, l’India, Brasile ed altri, mentre vengono facilmente sottaciute quelle persistenti nei paesi capitalistici più antichi che mostrano la tendenza ad equiparare non i nuovi nuclei di classe operaia dei paesi emergenti alle condizioni conquistate con aspre lotte da quelli più antichi, bensi di fare arretrare progressivamente proprio quelli dei paesi che rappresentano la madre patria del capitalismo
. Situazioni nuove, dunque, quelle dei paesi emergenti, in contesti profondamente diversi da quelli dell’800 europeo, che potrebbero però dare, anch’esse, origine a movimenti di tipo sindacale e poi anche politico, ai quali, a differenza di quanto poté giovare al nascente proletariato europeo la tradizione rivoluzionaria del 1789 in Francia, potrebbe venire oggi un appoggio ed un orientamento positivo alla crescita di una coscienza di classe diffusa anche ai nuovi paesi emergenti dall’esperienza maturata dalla sinistra europea, memore della sua origine. Obiettivo non irrealizzabile alla luce della possibile utilizzazione a tale scopo degli attuali mezzi del sistema mediatico e di internet, che vanno diffondendosi lentamente in gran parte del mondo odierno. Occorre precisare, però, che per ottenere un reale sviluppo della necessità della lotta per emancipare il proletariato ovunque è sfruttato non è sufficiente solo il ricorso all’esperienza maturata dalle sinistre europee nel corso dell’intero 900, in quanto le differenziazioni verificatesi nell’interpretazioni del pensiero di Marx sono state molteplici e spesso tragicamente divergenti. Non si possono certo prendere in considerazione al riguardo, come potenzialmente capaci di fornire un utile contributo di idee alle lotte dei lavoratori dei paesi emergenti, le esperienze che si sono richiamate alla visione moderata del cosiddetto “ Riformismo socialista “, dato il sostanziale naufragio della II internazionale con la prima guerra mondiale e le successive sconfitte dei tentativi più elevati quali quelli tentati da Brandt e da Palme (liquidati dalla Cia) e superati, per giunta in positività dal riformismo liberale di Keynes .Riformismi ambedue, che, tra l’altro, hanno potuto operare, entrambi, in Europa ed ottenere risultati apprezzabili grazie ad una condizione ,oggi inesistente, dovuto alla necessità del capitalismo di concedere qualcosa sul salario, sotto la pressione del socialismo reale dell’ Urss. Concessioni che, come si può amaramente notare, ma non nascondere, oggi si sta ampiamente riprendendo tutto con gli interessi, riducendo in tal modo la socialdemocrazia ad inutile orpello.
Ma al di la dell’esame della continuità nei soli tre secoli della esistenza del peggiore sfruttamento dei lavoratori dipendenti, ovunque ve ne siano le condizioni per un capitalismo che si espande sempre più nel mondo, vi sono i fenomeni del tutto nuovi nello sviluppo dell’organizzazione e delle strutture soprattutto finanziarie di supporto della produzione che a livello mondiale il capitalismo si è andato costruendo al fine di affrontare più efficacemente del passato le sue periodiche crisi e per aumentare le sue possibilità di dominio non solo dentro le singole società nelle quali era gia presente, come negli USA, in Europa, in Giappone e altrove, ma anche di invadere tutte quelle altre che sono entrate nell’ambito del sistema produttivo capitalistico. Fino a quelle che lo sono solo marginalmente, ma che si trovano collocate geograficamente in aree ricche di materie prime che appaiono indispensabili per sostenere il continuo accrescimento della produzione mondiale, quali i combustibili fossili ed altre sostanze, dalle quali si possono ricavare prodotti non meno importanti, come quelle radioattive. E, sempre più spesso, l’utilizzazione spregiudicata e talvolta al di fuori degli indispensabili controlli sulla pericolosità attuale o successiva( purchè capaci di procurare subito alti profitti) delle più importanti novità scientifiche e tecnologiche, al fine di ampliare la sua presa su tutta la società mondiale, senza che ancora una volta i benefici giungano in alcun modo anche alle popolazioni. L’Africa, come è tragicamente noto, è tra le principali vittime delle attuali esigenze capitalistiche e dell’indifferenza verso la sorte di milioni di esseri umani che la abitano, pur in presenza di un modesto sviluppo industriale locale qua e là.
Troppo spesso si ha l’impressione che da molte parti si cerchi di nascondere i nuovi aspetti pericolosi di quello che nonostante tutto continuiamo a chiamare” Civiltà “pur con tali caratteri negativi, cercando di occultare,dietro sigle incomprensibili ai più, di recente conio, attività quali quelle della Banca Mondiale, del Fondo monetario internazionale, dell’organizzazione del commercio ed altre che, in sintonia con le più grandi Multinazionali e col capitalismo degli USA, dominano l’economia mondiale e la finanza speculativa, col risultato , spesso ottenuto, di condizionare il tipo di sviluppo di molti paesi. E non solo di quelli più arretrati ma anche di quelli più tradizionali, con l’imposizione, attraverso scelte culturali e pressioni di ogni genere, di impostazioni di tipo iper-liberiste fatte divenire quasi dogmi intoccabili o persino presentati come nuove teorie economiche. Col risultato, ormai fin troppo evidente, di un arretramento delle condizioni sociali dei lavoratori e delle grandi masse popolari conquistate nel secolo scorso, almeno in Europa, con meccanismi che sempre più spesso sfuggono ormai non solo al controllo democratico e popolare ( come del resto è chiaramente nell’interesse del capitalismo di ciascun paese e di quello mondiale nel suo insieme ) ma anche attraverso la più difficile comprensione dei meccanismi che realmente presiedono all’attuale economia mondiale.
Si prospetta pertanto ancora una volta assai proficua la rilettura critica del pensiero di Marx visto che, come si è gia accennato, allo stato attuale, dopo oltre 120 anni dalla sua morte, non è comparsa nel mondo capitalistico alcuna dottrina che facendo perno sulla pretesa insostituibilità del capitalismo per sviluppare ancora la società moderna, sia in grado di offrire una reale capacità di comprendere la storia dell’economia pre-capitalistica, il ruolo che effettivamente il capitalismo svolge oggi nello sviluppo della mondializzazione e l’individuazione di una prospettiva diversa da quella che purtroppo si profila per il futuro dell’umanità sul pianeta.
Vi sono ancora e sono evidenti le potenzialità del marxismo anche in altre parti del mondo attuale pur che vi sia una capacità analitica da un punto di vista autonomo,in grado di elevare a teoria le ragioni delle popolazioni subalterne e che sappia al contempo distinguersi dal dogma del profitto perseguito dagli sfruttatori che hanno globalizzato, secondo i loro indirizzi, l’economia. Se la consideriamo entro un positiva ripresa dell’interpretazione dialettica , tale antinomia può rappresentare il momento della negazione, determinata, cioè, dal conflitto che evidenzia ( porta alla luce ) l’esistenza di un soggetto trasformatore. Mentre per prospettare una sintesi politica delle contraddizioni occorre rintracciare negli attuali conflitti confusi ( come ad esempio le più recenti manifestazioni di ostilità verso l’occidente capitalistico del vasto mondo mussulmano e tante altre) il filo rosso dell’agire di un capitalismo parassitario, da superare contro cui prospettare una differente visione del progresso per arrivare ad un nuovo modello di sviluppo del mondo.
Cosa che nel nostro Paese significa anche rilanciare ( contro i vari formalismi Bobbiani ) il nucleo Russoviano e sostanzialista della democrazia: tutti decidono tutto. E in ciascun paese del mondo lo sforzo di collocare lo sviluppo del marxismo e della soluzione possibile per l’oggi all’interno della propria storia, della propria cultura, delle condizioni materiali soggettive e oggettive della gran parte della popolazione.
Al riguardo vale la pena di notare che i rapporti di forza in quasi tutti i paesi del mondo non consentono attualmente al proletariato, pur enormemente aumentato di numero ma sparso in tutti i continenti, di guidare anche una decisa reazione ai pericoli che il capitalismo fa gravare sull’intera collettività dei paesi del mondo. Cosi come non è possibile fare alcun confronto tra le condizioni nelle quali maturò una coscienza di classe tra molti strati di proletariato europeo nell’800 e nel 900 e quelle delle condizioni complessive di oggi dei nuovi agglomerati di proletariato nel resto del mondo,stante l’evidente differenza di condizioni soggettive ed oggettive storiche, economiche, giuridiche, culturali ( senza trascurare l’intreccio con le credenze religiose ) tra l’Europa di allora e quelle dei paesi che oggi si è soliti definire come emergenti. Pur se rinasce in forme sempre diverse la necessità di trasformare la conflittualità immanente nelle condizioni lavorative di intenso sfruttamento, in lotte sindacali e, laddove è possibile, anche in lotte politiche coerenti, all’interno della società nella quale vive la sua difficile vita ogni nuovo nucleo proletario. Mentre ancora oggi ogni generazione di proletariato può essere in grado, pur cosi sparpagliato ma partendo dalle proprie ragioni di opposizione al tipo di sviluppo in corso in ogni paese, di sollecitare, sostenere e tentare( dove può )con maggiore coerenza di altri oppositori al tipo di sviluppo in corso, di unificare le reazioni di quanti sono indotti ad opporsi al parassitismo del capitalismo attuale, e questo proprio per essere quella parte della società che sperimenta ogni giorno i risultati dello sfruttamento del proprio lavoro, come è avvenuto nel passato tra le generazioni che l’hanno preceduta, derivante dal rapporto tra sistema produttivo e rapporti di produzione, portata perciò ad essere del tutto ostile ad un sistema produttivo che non è più in grado di assicurare sviluppo e progresso ma che anzi fa sorgere sempre pericoli nuovi per l’intera umanità. A questo rinnovato processo politico nelle forme possibili oggi, possono contribuire il rilancio del pensiero di Marx laddove può ancora essere reso noto a quanti non ne avevano alcuna nozione e sviluppare nuove elaborazioni rivoluzionarie nel proprio paese.
. La situazione italiana, del resto, può rappresentare uno degli esempi, tra i tanti, di come lo sviluppo e l’aggiornamento del pensiero di Marx sia stato non solo possibile ma necessario e riuscito, pur attraverso le drammatiche vicende seguite all’unificazione del Paese sotto la monarchia sabauda, l’adesione nel 1915 alla prima guerra mondiale, il sorgere ed affermarsi di un fenomeno storicamente del tutto nuovo quale il fascismo, che si concluse( attraverso le tragedie della guerra, dell’occupazione nazista sostenuta dai fascisti ancora dopo il 25 luglio del 1943 e l’arresto di Mussolini) con la distruzione di tanta parte del Paese e con grandi perdite umane. Quello sviluppo fu reso possibile anche per l’intenso lavoro di Antonio Labriola speso nel tentativo, in parte riuscito, di trasmettere al Partito Socialista Italiano, allora di recente costituzione a fine ‘800, il senso profondo del pensiero di Marx. Tentativo realizzato in un difficile contesto politico e culturale per tentare di radicare il marxismo nella realtà nazionale come un pensiero critico rivoluzionario(anche dietro i suggerimenti epistolari di Engels in quanto capo della seconda internazionale) che avrebbe però avuto bisogno, per riuscire, di una preesistente cultura nazionale dei gruppi dirigenti dimostratasi scarsamente presente in Italia, sia per i limiti dell’egemonia borghese che del particolarismo degli intellettuali italiani (obiettivo al quale si dedicò anche Croce per fare a sua volta attecchire il liberalismo ma frustrato in quell’epoca dal crescente nazionalismo e dal suo sbocco verso la reazione fascista) tentativo che era teso, ciò nonostante, a fornire una nuova visione a tanti intellettuali ed operai italiani, molti dei quali raggruppati a Torino intorno a Gramsci e Togliatti. Visione tesa all’approfondimento dei caratteri della borghesia italiana e dei suoi limiti storici che hanno finito col distorcere gli aspetti positivi del Risorgimento e di impedire di fatto l’individuazione di un possibile sviluppo della rivoluzione italiana. Materie quelle che furono oggetto di acute osservazioni originali in carcere da parte di Gramsci che si riscontrano nei suoi “ Quaderni del carcere”. Il marxismo in Italia da allora è riuscito ad avere ulteriori importanti sviluppi innovatori, non esenti, ovviamente, da errori, divergenze, distorsioni anche profonde. Ma lasciando una traccia nella cultura del Paese che si avverte tuttora e in vario modo nella società italiana attuale. Tra marxismo e correnti filosofiche resta un rapporto problematico( dialettico ) da mantenere senza ne cedimenti ne dogmatiche chiusure. Cosa che rende ancora una volta necessaria una rilettura critica del pensiero di Marx vista la imponente campagna di revisione della sua opera complessiva mai venuta meno, che è divenuta spesso di vera e propria demolizione, quando non del tutto di demonizzazione . Necessità che si pone anche a chi non ha mai creduto alla urgenza di una svolta radicale nell’organizzazione della produzione di beni essenziali alla vita della popolazione mondiale, che sia tale però da non mettere ancora più a rischio l’equilibrio della natura che abbiamo ereditato e l’urgenza di affrontare quelle misure che si prospettano da più parti come condizione posta al progresso per le sopravvivenza della specie umana.
In primo piano appare pertanto l’esigenza di nuove forme di società che, pur non avendo i caratteri attribuiti nell’800 al socialismo, offrano però lo stesso la possibilità, che sembra improcrastinabile, di togliere al capitalismo la sua egemonia di natura anarchica nella società, visto che quella conduce ormai sempre e soltanto verso il cinismo e l’indifferenza ai problemi vitali per la collettività umana. Processo nuovo che non può che significare il sottomettere il capitalismo e44 la produzione da esso gestita ( finché vivrà questo sistema produttivo, nuovo storicamente ma non certo eterno, come non lo sono stati quelli che l’hanno preceduto) alle decisioni che le singole società e l’insieme della collettività mondiale potranno ritenere indispensabili per ottenere sia lo sviluppo del progresso generale sia l’equità sociale che la difesa dell’ambiente e delle condizioni lavorative, in forme ed occasioni che oggi non sembrano ancora presenti ma che l’aggravamento dell’immiserimento di tanta parte della popolazione mondiale ed i pericoli crescenti causati in particolare dal già citato effetto serra possono anche bruscamente ed in modo imprevisto, rendere urgenti ed indifferibili.
Potrebbero sorgere, per quegli insopprimibili motivi, delle situazioni rivoluzionarie, intese nel senso letterale del termine, non limitato quindi alla sole ed uniche transizioni violente ma anche a quelle, forse più probabili, di tipo processuale, che si presenterebbero ciascuna in forme del tutto peculiari per ogni società in movimento. Con evidenti differenze dovute alle specifiche condizioni storico-ambientali, ai concreti rapporti di forza interne ai ceti, alle classi ed eventualmente alle varie etnie e credi religiosi ( dove quelle contano ) e ad altre caratteristiche tipiche di ciascun paese, tali da dar luogo ad una gamma di strategie tese riorganizzare la vita produttiva e sociale di ciascun paese.
Al riguardo il pensiero corre al precedente storico del passaggio dal feudalesimo alle società comunali, in particolare in Italia, che vide nascere una nuova organizzazione che sarà definita in seguito come nascita della borghesia. Qualcuno abituato solo a demolire ogni prospettiva anche di solo indebolimento del potere preponderante delle forze capitalistiche mondiali, griderà ancora una volta all’utopia. Senza forse nemmeno ricordare, se lo conosce, o ignorare del tutto se non lo ha mai sentito nominare, che l’etimo del termine, usato da Tommaso Campanella come “ non luogo “, è divenuto un incentivo alla ricerca di atteggiamenti orientati verso il disinteresse personale e l’elevato valore morale dei cittadini nella vita pubblica. Necessari per una società più equa, che aveva gia ispirato, da Platone in poi,( ma anche in precedenza ) tanti studiosi ed intellettuali di ogni epoca, a ricercare, per questa specie animale ormai tanto evoluta, una diversa prospettiva di organizzazione della società umana ,capace di tirarla fuori da ogni residuo di ricorso alla legge della giungla nei rapporti sociali interni ed internazionali, e che ha avuto, tra l’altro, il merito notevole di aver concorso alla ricerca concreta di nuove e più elevate norme di convivenza civile in ogni epoca.
Si tratta di un compito di alto profilo anche per l’oggi, che deve indurre le forze intellettuali aperte al progresso a riesaminare con spirito aperto il lavoro di Marx per trovare nel suo insegnamento e in particolare nella sua opera maggiore e più approfondita “Il Capitale” orientata dalla sua visione di materialismo storico e dialettico, il bandolo del filo di una capacità critica puntata sulla difficile situazione del mondo d’oggi, tale che consenta di individuare le caratteristiche attuali con le quali si presentano oggi le vecchie contraddizioni a fianco delle nuove che nascono dall’ attività capitalistica in corso attualmente, al fine di poter fare leva sia sulle prime che sulle altre, in quanto punti deboli della forza del capitalismo, per limitarne progressivamente il potere sulla società e tendere a metterlo sotto controllo.
Vi sono teorie, analisi economiche e visioni politiche diverse da quelle di Marx in grado di offrire oggi un metodo critico alternativo a quello da lui prospettato, tale da aiutare la comprensione delle caratteristiche della Globalizzazione, e in grado di indicare come superare le terribili contraddizioni tra sviluppo e devastazione dell’ambiente ( come il gia ricordato effetto serra ), tra progresso della civiltà e miseria e sofferenza di enormi masse in tutto il globo, oltre che schivare i pericoli che si profilano per le sorti della stessa umanità ? Specie ora che uno dei falsi miti che stanno alla base dell’ideologia della globalizzazione e del pensiero unico neoliberista che ha pervaso il mondo e anche le culture della sinistra europea che era la sua pretesa capacità di unificare il mondo sotto il segno dello sviluppo e di una più equa opportunità per tutti i popoli della terra di goderne anch’essi i presunti benefici. Oggi quel velo è caduto e la globalizzazione neo- liberista si rivela per quella che è realmente: una rivoluzione che “ libera “ il capitale dai suoi condizionamenti sociali, politici e territoriali; amplia le disuguaglianze nella distribuzione del reddito e delle risorse globali tra Nord e Sud del mondo e nelle aree più ricche del pianeta; aumenta l’irresponsabilità sociale dell’impresa; distrugge le regole e la coesione sociale; impoverisce le popolazioni e la stessa democrazia, come dimostrano i recenti rapporti ONU sulla povertà nel mondo.
Si può dunque ancora ricorrere a Marx ed al suo metodo critico materialistico dialettico e storico ma solo con un esame attento, consapevole del fatto che non è lecito utilizzare, come si è accennato all’inizio, le sue formulazioni su uno qualcuno degli argomenti da lui affrontati ed espressi nati in un contesto del tutto diverso da quello attuale, al solo scopo di confortare o confutare i tentativi di analisi che oggi sono ancora possibili specie sulla base delle sue opere. L’assunto iniziale non può che essere quello di individuare quali fenomeni economico-finanziari, politici e culturali hanno ancora caratteri simili a quelli dei secoli precedenti in tema di sviluppo industriale capitalistico, sempre più diffuso negli altri continenti, che mostrano anch’essi, tra l’altro, caratteri assai simili a quelli registrati a suo tempo nella prima industria inglese, francese e nord-americana e altrove in Europa, al fine di delineare quanto vi è di continuità nel meccanismo produttivo capitalistico che ha invaso il mondo intero, nei nuovi aspetti del tutto originali e recenti nel suo procedere odierno, con i suoi elementi negativi che sembra stiano probabilmente arrivando al loro limite . Analisi delle quali non vi traccia solo negli scritti di Marx e di Engels, ma anche di Lenin e di tanti altri marxisti, oltre ad essere presenti nelle opere di numerosi intellettuali delle epoche diverse in volumi che fecero impressione sull’opinione pubblica e l’informarono delle nuove realtà del mondo del lavoro.
Roma - Novembre 2006