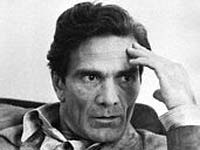 |
| Pier Paolo Pasolini |
 |
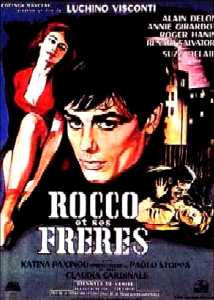 |
| Alain Delon |
 |
 |
| Ninetto Davoli |
 |
Ma
non per tutti quel periodo a cavallo tra gli anni
cinquanta e i sessanta è fatto di spensieratezza, coca
cola e rock'n'roll: l'Italia, appena uscita dalla prima
fase della ricostruzione post-bellica, presenta anche
aree rurali depresse e povertà diffusa in vaste zone
del territorio. Tra queste, balza particolarmente
all'occhio la condizione critica delle nuove periferie
delle grandi metropoli, cresciute disordinatamente dopo
la fine della guerra in seguito alla rapida
urbanizzazione, all'immigrazione dal Sud e al fenomeno
degli "sfollati", rimasti senza casa dopo la
fine della guerra. Il visitatore casuale non può
evitare di essere preso da un groppo alla gola, a
contemplare quei quartieri dove si vive privi dei più
elementari servizi, in cui, a fianco di enormi prati
incolti, campeggiano casupole screpolate e vere e
proprie baracche. E' questa l'ambientazione in cui,
messi al mondo subito dopo la fine della guerra, vive
una pattuglia di adolescenti con un passato familiare
spesso poco felice alle spalle e un futuro pieno di
incognite. I loro genitori, solitamente analfabeti e
costretti a fare lavori precari e umilianti,
rappresentano il loro primo modello di vita; il
secondo modello è invece composto da tutto un
sottobosco di piccola delinquenza, che molti teenager
vedono come possibile via d'uscita dalla periferia.
Il
primo a cogliere il lato poetico di queste realtà
adolescenziali difficili è lo scrittore, e poi anche
regista e saggista, Pier Paolo Pasolini, che nel 1955,
nel suo primo romanzo "Ragazzi
di vita", descrive le giornate sciatte e
ingloriose di un gruppo di amici di una di quelle
periferie romane comunemente denominate
"borgate". L'eroe della storia è il
tredicenne "Riccetto", conosciuto, non a caso,
solo con il suo soprannome, che abita in un edificio dai
muri screpolati, una ex-scuola elementare che prima
della guerra era servita per alloggiare i tedeschi, e,
successivamente, i canadesi, e in cui in seguito si
erano sistemati "gli
sfollati, e da ultimo gli sfrattati, come la famiglia
del Riccetto". Pasolini si sofferma a
descrivere con cura le occupazioni giornaliere
dell'adolescente borgataro nel corso di una torrida
estate romana: piccoli furti, approcci con le
prostitute, e lunghi pomeriggi passati in fatiscenti
luna-park periferici, dove Riccetto e i suoi amici
giocano a calcio balilla finendo regolarmente per
picchiarsi con dei "borgatari" loro
antagonisti; il ragazzo volge lo sguardo, inoltre, con
stupore e senso di inferiorità verso il mondo dei suoi
coetanei borghesi e danarosi, con cui sente di non avere
niente in comune. Il borgataro viene guardato malissimo
da tutti: se il cosiddetto "figlio di papà"
prova il maggior disgusto quando è costretto ad
entrarci in contatto, in generale qualsiasi ragazzo che
abiti all'interno delle mura cittadine non prova
simpatie per lui; e, a dire il vero, è lo stesso
adolescente di borgata a soffrire di una sudditanza
psicologica notevole nei confronti degli abitanti del
centro. Prova ne è che lo stesso Riccetto, nel romanzo
di Pasolini, subisce le umiliazioni più cocenti proprio
quando cerca di omologarsi agli ragazzi, lasciando il
proprio quartiere per andare a farsi un giro al cento di
Roma. Non per questo il borgataro detesta la città in
cui vive solo ai margini: anzi, quando entra in contatto
con forestieri e stranieri ci tiene a sottolineare e a
far valere la sua appartenenza alla metropoli, come se
questo gli possa in qualche modo conferire maggiore
importanza a livello sociale.
E'
un altro intellettuale, il regista Luchino Visconti, a
gettare invece un occhio a quei ragazzi le cui famiglie
sono emigrate dal Sud al Nord Italia alla ricerca di
lavoro: nel film "Rocco
e i suoi fratelli" del 1960 si raccontano le
gesta di un gruppo di adolescenti, che devono convivere
con il fastidioso appellativo di "terroni", e
la loro difficile esistenza nel sobborgo di Lambrate,
nei pressi di Milano. L'unica speranza di una vita
migliore, per il protagonista Rocco (interpretato
dall'attore francese Alain Delon) consiste nel praticare
lo sport "povero" per eccellenza, il pugilato;
e tutto questo mentre, tra i ragazzi emarginati di tutta
Italia, si diffonde il mito di Nino Benvenuti, il nostro
connazionale capace di conquistare la medaglia d'oro dei
pesi welter alle olimpiadi di Roma.
Pasolini
torna a descrivere la deprimente realtà del "borgataro"
romano nel 1959 in un nuovo romanzo, "Una
vita violenta": il protagonista stavolta si
chiama Tommasino, abita sempre a Roma sulle baracche in
riva al Tevere e ha circa 17 anni, l'età giusta per
potersi innamorare di una ragazza, Irene, naturalmente
"borgatara" come lui. A cui però, a causa
della sua cronica mancanza di quattrini, non può
offrire più di tanto: Tommasino non ha nè l'automobile
nè la motoretta, nè può portare la sua fiamma a
ballare o a cena fuori. E così, il massimo del
divertimento, per i due, è andare in uno di quei
cadenti cinema di quartiere detti, alla romana, "pidocchietti",
e osservare come da dietro le sbarre di una gabbia un
mondo che non riusciranno mai a toccare con mano: lo
sfavillante universo dei grandi film hollywoodiani e
delle pellicole "storiche" alla "Ben Hur" (1959).
Per
il teenager dei margini, che non sa nemmeno come
sbarcare il lunario, i Clark Gable e le Liz Taylor
restano miti distanti, inafferrabili; ben più vicini
sono, invece, i protagonisti di alcuni film neo-realisti
italiani del cosiddetto filone del "romanzo popolare". Si
tratta, in particolare, di pellicole dirette da Luigi
Comencini e Dino Risi, dai titoli già espliciti come
"Pane, amore
e fantasia", "Pane
e amore e gelosia", "Poveri
ma belli" e "Belle
ma povere", che propongono nuovi modelli di
riferimento onesti e coraggiosi con cui potersi
identificare, come Renato Salvatori, Marisa Allasio,
Lorella de Luca, Alessandra Panaro e Maurizio Arena.
Quest'ultimo è il classico "bulletto" romano:
ex-calciatore, ex-pugile, ex-barista, ex-commesso,
ex-camionista, in breve tempo diventa l'oggetto dei
desideri di tutte le ragazze dei sobborghi, grazie alle
sue spalle da lottatore e al suo sorriso conquistatore.
Ma
un modello in cui il "borgataro" si possa
riconoscere al cento per cento il mondo del cinema
glielo propone solo nei primi anni sessanta: è l'attore
Ninetto Davoli, portato alla ribalta, ancora, da Pier
Paolo Pasolini, nel frattempo diventato regista. Davoli,
per tutti i ragazzi italiani delle periferie deleritte,
diventa l'esempio di "uno di noi che ce l'ha
fatta". Nato nel 1948, di origine calabrese, si era
trasferito in tenera età a Roma alla borgata Prenestina,
a due passi dall'Acqua Bullicante. I suoi anni
adolescenziali li passa scorrazzando per strada o
dedicandosi a divertimenti da due soldi, come "nizza",
"spacca-picchi", "tre-tre-giù-giù"
e "zecchinetta". La scuola la abbandona
presto, perchè è costretto a portare soldi a casa: fa
il meccanico, il falegname e anche il cascherino. Poi,
all'età di 16 anni, il colpo di fortuna: trovatosi per
caso ad assistere alle riprese di un film di Pasolini,
fa la conoscenza del regista, che prende subito in
simpatia questo "ragazzo di vita" dagli occhi
buoni e dagli atteggiamenti naif. Improvvisamente
Ninetto, dalla sua borgata, si trova catapultato sui set
di Cinecittà: dapprima ottiene una particina da
pastorello nel film "Il
vangelo secondo Matteo" del 1964; poi è
addirittura il co-protagonista di uno dei più
importanti film italiani del decennio, "Uccellacci
e uccellini"; e il suo partner è nientemeno
che il grande Totò. Il giovane Ninetto diventa così,
dal giorno alla notte, oggetto di adorazione, e anche di
invidia, da parte dei suoi coetanei delle periferie
degradate di tutta Italia, che si riconoscono in questo
adolescente che sembra possedere un costante senso di
stupore bambinesco verso il mondo. A diciannove anni,
con i primi guadagni della sua carriera di attore,
Davoli lascia la borgata di origine per andare ad
abitare, per la prima volta nella sua vita, in un
"palazzo", con tanto di luce e acqua potabile,
nel quartiere romano di Cinecittà. Ma in molte
interviste successive, l'idolo di tanti ragazzi poveri
dichiara di continuare a rimpiangere le case e i prati
dell'Acqua Bullicante, una borgata in cui, a parer suo,
si conduceva una vita priva di comodità, ma anche tanto
semplice e senza tante ipocrisie.
|