 |
| Alberto Sordi |
 |
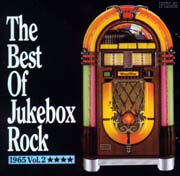 |
| Il juke-box |
 |
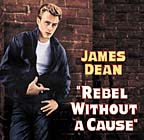 |
| James Dean |
 |
Se
un po' in tutti i Paesi dell'Europa occidentale ci si
rifà al prototipo di "teenager" inventato
dagli americani, tra i ragazzi italiani la voglia di
guardare agli Stati Uniti è particolarmente viva. I
motivi sono da ricercarsi nella presenza americana sul
nostro territorio durante la seconda guerra mondiale,
che aveva lasciato, in chi era bambino in quegli anni,
molti buoni ricordi e, soprattutto, dei modelli da
imitare. Il ragazzo italiano cresce a immagine e
somiglianza di quello americano; due sono i canali
principali attraverso cui impara dai modelli di
oltreoceano: il cinema e la musica.
Gli
eroi di celluloide funzionano a meraviglia: Marlon
Brando, Montgomery Clift, Sal Mineo, Natalie Wood,
Marylin Monroe e James Dean sono i grandi e universali
punti di riferimento di tutti i ragazzi italiani degli
anni cinquanta. Di questi, è Dean a colpire la fantasia
della maggior parte dei giovani: a differenza di Brando,
sempre sicuro di sè e quasi scostante, l'interprete di
"Gioventù
bruciata" è l'incarnazione di un nuovo tipo di
adolescente, ribelle ma allo stesso tempo inquieto e con
più dubbi che certezze. Un idolo che, oltretutto, è
destinato a non invecchiare mai, a restare per sempre
giovane: l'incidente in cui James Dean trova la morte
schiantandosi a tutta velocità sulla sua Porsche, il 30
settembre 1955, conferisce all'attore originario
dell'Indiana un'aureola romantica che permane ancora
oggi.
E'
così che molti ragazzi, talvolta senza nemmeno
rendersene conto, si fanno coinvolgere dal grande mito
dell'America consumista e benestante: cominciano a bere
coca cola e, se capita, whisky e soda, a dirsi
reciprocamente "occhei", a vestirsi in
"pantaloni da tuta di lavoro" (i jeans) e in
"magliette a mezze maniche" (le t-shirts), a
imporre alle proprie mamme di cucinare hamburger in
luogo della pastasciutta e, addirittura, a imitare gli
atteggiamenti da "duri" e le cadenze vocali
degli attori di oltreoceano. Una figura di adolescente
"americano" arriva anche sul grande schermo:
si tratta di Nando Moriconi, il personaggio interpretato
da Alberto Sordi nel film "Un
americano a Roma". In quella pellicola c'è
tutto, ovviamente parodizzato e portato all'eccesso,
l'americanismo del ragazzo italiano della metà degli
anni cinquanta.
La
divulgazione del rock'n'roll avviene invece con un paio
di anni di ritardo rispetto all'America e inizialmente
incontra qualche difficoltà a prendere piede. Sono i
tempi in cui da noi dominano ancora incontrastate la
canzone italiana e la melodia napoletana: per orecchie
abituate ad assorbire suadenti melodie, l'irruzione del
nuovo genere è un vero e proprio shock. Tanto più che,
inizialmente, i dischi di Elvis, di Little Richard e dei
grandi del rock'n'roll sono reperibili solo
d'importazione. Solo in un secondo momento, verificato
l'impatto che il fenomeno sta avendo all'estero, le case
discografiche italiane si danno da fare per divulgare il
genere alle grandi masse. "La radio aveva delle rubriche, ogni tanto arrivava qualche disco, ma era
difficile", ricorda Renzo Arbore, all'epoca
sbarbato adolescente in Puglia e tra i primi ad
appassionarsi al nuovo "verbo", "ci
sentivamo una specie di setta, perchè a noi piaceva
questa musica e ai nostri genitori no, anzi la
giudicavano l'anticamera della depravazione. Trovare i
dischi nei negozi era complicato anche perchè non
avevamo molti soldi, ti dovevi affidare a qualche amico
ricco che se li poteva permettere. L'unica alternativa
era 'Il Discobolo', la trasmissione di Zivelli alla
radio, era una sorta di porto franco in cui il rock, nel
silenzio del resto della programmazione, aveva un suo
spazio. Il primo rock in Italia lo ha trasmesso lui..."
Oltre
al "Discobolo", a far conoscere il nuovo
genere ai nostri adolescenti "americani" ci
pensa il juke-box: il suo nome significa "scatola
per ballare" ma, per fortuna, nessuno pensa mai di
utilizzare la sua traduzione letterale italiana. Prima
del 1955 in Italia ne era arrivato espressamente
dall'America un solo esemplare, quello impiantato
durante la guerra dagli americani a Roma, al Foro
Italico. Si chiamava "swinging tower", la
torre urlante, e conteneva fino a dieci dischi. Negli
anni cinquanta i juke-box, impiantati nei bar, nelle
latterie, nei locali e negli stabilimenti balneari,
diventano un amico fidato di cui gli adolescenti
italiani non possono più fare a meno: peraltro,
permette ai ragazzi di superare allegramente la censura
imposta sul rock'n'roll da radio e genitori assillanti:
basta inserire una monetina e tanti saluti agli
scocciatori. Nel 1956 i juke-box in Italia sono già
500; e all'inizio degli anni sessanta, c'è chi è
pronto a giurare che ce ne siano almeno diecimila.
|
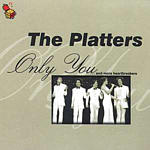 |
| The Platters |
 |
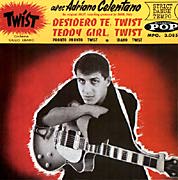 |
| Adriano Celentano |
 |
 |
| Giorgio Gaber |
 |
Ad
attecchire subito in Italia è la variante melodica del
rock'n'roll, eseguita da gruppi vocali di colore, il
doo-wop. Il gruppo dei Platters, con le sue "Only You" e "Smoke
gets in your eyes", è il portabandiera del
genere. Ma presto arriva anche il rock'n'roll
"vero", quello ribelle e dissacratorio di Bill
Haley, di Elvis e di Little Richard, di "See you later alligator", di "Heartbreak Hotel" e di "Rip it up"; e riesce a conquistare masse sempre più larghe di
giovani. All'interno delle famiglie scoppia la guerra
generazionale, tra gli anziani, legati ai moduli
tradizionali della canzone, e i figli, trascinati
dall'energia della nuova musica che gli adulti non
possono sopportare.
Insomma,
dopo lungo torpore, nel 1957 sembra che gli adolescenti
italiani stiano cominciando ad accostarsi a quei nuovi
ritmi che emanano ribellione da tutti i pori. In quello
stesso anno escono nelle sale, inoltre, i film americani
"Il re del rock'n'roll" (titolo originale "Rock, Rock,
Rock") e "I
frenetici" (tit. orig. "Don't knock the
rock") che diffondono ulteriormente le nuove
trasgressioni d'oltreoceano. Ma la nuova musica, per la
maggioranza dei ragazzi italiani, resta ancora qualcosa
di folcloristico, soprattutto a causa
dell'incomprensibilità del linguaggio: sì, Elvis si
muoverà anche bene, ma cosa biascicherà mai? Insomma,
è venuto il momento di creare degli equivalenti
italiani, che i ragazzi possano comprendere e in cui si
possano riconoscere.
La
culla del rock'n'roll in versione italianizzata è
Milano: è qui che il discografico di origine svizzera
Walter Guertler ha le intuizioni che procureranno a lui
i denari, e ai teenager italiani nuove mode e idoli.
Guertler comincia dal "soffice", creando
dapprima il fenomeno dei cosiddetti
"urlatori", così chiamati perchè, dicono gli
adulti, invece di cantare nel microfono, urlano: il
caposcuola è Tony Dallara, al secolo Antonio Lardera,
che imita alla perfezione il singhiozzo di Tony
Williams, la voce dei Platters, e che raggiunge uno
strepitoso successo tra il 1957 e il '58 con la canzone
"Come prima".
La maggior parte degli adolescenti scopre la novità
rappresentata dagli "urlatori" guardando alla
televisione il programma "Il Musichiere",
presentato da Mario Riva. E così si affeziona anche ad
altri personaggi quali Fred Buscaglione, Peppino di
Capri, e i cosiddetti "urlatori melodici",
come Joe Sentieri e Betty Curtis.
Il
rock'n'roll vero, però, quello scatenato, è un'altra
cosa. E Guertler, che è un tipo che tiene sempre
drizzate le orecchie, è in prima fila al Palaghiaccio
di Milano il 18 maggio 1957, ad assistere al "Primo
Festival Nazionale del Rock and Roll". L'evento ha
luogo in un delirio di giovani "truccati
da giovani", come commenta il giornalista
Giorgio Bocca.; per la prima volta nel nostro Paese si
assiste allo spettacolo di teenagers vestiti come James
Dean e Natalie Wood, urlanti e strepitanti, che lanciano
in aria camicette e bottiglie di coca-cola e demoliscono
le sedie al suono della nuova musica. Insomma, si
vestono da "ribelli" e si comportano da
"ribelli": il teenager italiano, in senso
moderno, forse nasce proprio quel giorno, in mezzo a
quel vocìo, a quella calca.
E
mentre lo storico parto ha luogo, sul palco si sfidano
due interpreti, anch'essi adolescenti come il loro
pubblico. Di loro si sentirà parlare a lungo negli anni
futuri: uno è alto, allampanato, quasi timido; si
chiama Giorgio Gabershik, ma ha accorciato il suo nome
in Gaber per motivi artistici. Canta pacatamente una
canzone dal titolo "Ciao
ti dirò", e ottiene dal pubblico un responso
altrettanto pacato. Il suo concorrente è un
diciannovenne ribelle e sfrontato di origine pugliese
chiamato Adriano Celentano; somiglia vagamente al comico
Jerry Lewis, e, come asserisce lo scrittore Umberto
Simonetta, aggredisce la canzone, la stessa di Gaber,
"con la furia
di un samurai", nel tentativo di emulare il suo
idolo Elvis Presley. Il pubblico è ai suoi piedi:
Celentano vince a mani basse la competizione, ed esce
dal Palaghiaccio in trionfo, circondato da centinaia di
ragazzine in estasi, come nella migliore tradizione
"americana": è lui il "re del rock'n'roll"
italiano. Guertler non se lo fa scappare e pochi giorni
dopo gli offre un contratto discografico. Dopo due
dischi andati male, il successo arride finalmente al
giovane rocker nell'estate del '58, con un rock'n'roll
scatenato (e urlato più che cantato): "Il
tuo bacio è come un rock". Seguiranno altri
successi come "I
ragazzi del juke-box" e "Ventiquattromila
baci".
A
Celentano seguiranno altri rocker, come Ghigo, Little
Tony, Ricky Gianco e la stessa Mina, ma quello che in
seguito sarà conosciuto come "il molleggiato"
è il primo a diffondere, nel nostro Paese, il rock'n'roll:
traduce, non proprio letteralmente, i testi delle
canzoni americane più in voga e le adatta all'ambiente
italico. D'altro canto, Celentano vanta un passato da
teenager "americano" senza macchia: cresciuto
in un tipico quartiere "povero" di Milano,
aveva passato l'adolescenza con gli amici al bar sotto
casa, tutto il tempo davanti al juke-box cercando di
emulare le gesta e i suoni di Elvis e di Little Richard.
Un vero ribelle in maglietta e blue-jeans, insomma; e
con il tempo, Celentano non si fa pregare per
amplificare quegli atteggiamenti irriverenti e
irrispettosi che lo fanno additare a "ribelle"
da parte degli adulti e lo fanno essere amato dal suo
pubblico: come quando nel '59 si presenta a Sanremo
dando le spalle al pubblico, prima di dar vita a una
scatenata versione di "Ventiquattromila baci".
Come il suo mito Elvis Presley aveva fatto prima di lui,
anche Celentano arriva sul grande schermo, per la gioia
dei suoi fans: sono del 1959 "I
ragazzi del juke-box" e
"Urlatori alla sbarra", entrambi del
regista L. Fulci; è del 1961 "Io
bacio...tu baci" (distribuito anche con il
titolo "Il
Supermolleggiato") di P. Vivarelli.
Affascina
di Adriano, inoltre, il fatto che sia a capo di un
gruppo di coetanei, accomunati dallo stesso entusiasmo,
dalla stessa passione per la musica e dal successo: il
Clan di Celentano evoca, nei ragazzi che lo seguono,
immagini simpatiche di allegri gruppi di amici. Molti
giovani, riuniti in compagnia, si divertono ad emulare i
loro idoli e a creare gruppi, comitive e ruoli, a
imitazione del gruppo di affiatati amici del Clan:
Adriano, il "capo" riconosciuto della banda
che punisce le infrazioni alle regole del sodalizio con
multe severe; Don Backy, il "delfino",
commilitone di Adriano e cantante di successo con brani
quali "Ho rimasto solo" e "Voglio
dormire"; Gino Santercole, il
"pessimista", nipote di Celentano e
specializzato nello scrivere canzoni dai titoli
tristissimi quali "Nessuno crede in me" e
"Sono un fallito"; Mickey Del Prete,
"l'anziano", anche se di anni ne ha solo 29,
che scrive quasi tutte le canzoni del capo Adriano;
Detto Mariano, l'arrangiatore, colui che manipola i
motivi curandone la versione definitiva. E poi c'è
ovviamente la ragazza del Clan incarnata, fino al 1967,
da Milena Cantù. Si può dire che il successo di
Adriano nel mondo adolescenziale precipiti
definitivamente proprio quando si sfascia il Clan, con
la decisione del molleggiato di mollare Milena a
beneficio di Claudia Mori, benvoluta da un pubblico
adulto ma certo non una beniamina degli adolescenti.
Comunque,
in questo scorcio finale degli anni cinquanta e nei
primi sessanta il successo di Celentano e del rock'n'roll
tra i teenagers "americani" è ancora
indiscusso e inattaccabile, anche se l'americanizzazione
della nostra gioventù subisce anche gli inevitabili
sfottò da parte del mondo del cinema, del cabaret e
della canzone tradizionale. La presa in giro più
memorabile è costituita dal pezzo "Tu
vuò fà l'americano" del jazzofilo napoletano
Renato Carosone, la storia in musica di un
"guaglione" napoletano che si atteggia a
"duro", gioca a baseball, balla il rock'n'roll,
ma poi, per comprare un pacchetto di sigarette
americane, è costretto a chiedere i soldi alla mamma. I
nostri teenagers ascoltano, abbozzano un sorrisetto di
circostanza, ma poi, imperterriti, tornano ad inseguire
il loro sogno a stelle e strisce.
|