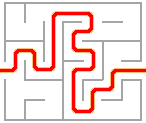
Il filo
di Arianna
aprile 2011
Giancarlo Livraghi
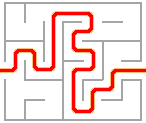
Il filo
di Arianna
Giancarlo Livraghi
Disponibile anche in
pdf
(migliore come testo stampabile)
Also in English – también en español
Pubblicato nel
numero
18 (aprile 2011)
della rivista l’attimo fuggente
Le contraddizioni
della
“meritocrazia”
Sembra facile. Adottiamo un sistema “meritocratico” e, per incanto, tutto funzionerà molto meglio. Ma l’esperienza dimostra che ci sono parecchi problemi. Perché non è facile definire che cosa sia il “merito”. E sono spesso discutibili i criteri con cui si pensa di poterlo riconoscere, stimolare, premiare o retribuire.
Stranamente (o forse no) per migliaia di anni, mentre il concetto di “merito” è sempre in qualche modo esistito, non si è mai usato il termine “meritocrazia”. Pare che la parola sia nata, in inglese, nel 1958 – e, fin dall’inizio, usata in senso critico.
C’è chi fa risalire il concetto (ma non la parola) a Confucio – o a un altro antico autore cinese, Han Feizi – e all’applicazione nel secondo secolo a.C., durante la dinastia Han, di un metodo di esami per valutare il “merito” dei funzionari nell’apparato burocratico. Cosa tutt’altro che facile. Due millenni più tardi, e in un diverso contesto politico, culturale e sociale, stiamo ancora affrontando gli stessi problemi, come vedremo più avanti.
Non è un caso che ora in Cina si stia rivalutando il pensiero di Confucio. In una difficile transizione da un bimillenario potere mandarino e burocratico a uno sviluppo necessariamente meno rigido – e in una difficile convivenza fra un sistema politico dichiaratamente comunista e la turbolenta crescita di un capitalismo selvaggio, insieme a una diffusa corruzione – diventa necessario cercare una forma e un metodo di “meritocrazia”. Finora, a quanto pare, con scarsi risultati. Nel resto del mondo, in situazioni e culture diverse, ci sono comunque problemi complessi e diffusi errori in ogni criterio di gerarchia.
C’è anche chi attribuisce opinioni “meritocratiche” ad Aristotele, ma si tratta di “aristocrazia”, che non è la stessa cosa. Si potrebbe, analogamente, pensare al ruolo dei filosofi nella Repubblica di Platone, ma anche quella è un’impostazione diversa.
Michael Young e l’invenzione della meritocrazia
Il fatto è che la parola “meritocrazia” è comparsa per la prima volta cinquantatre anni fa, in un interessante libro di Michael Young The Rise of the Meritocracy.
Non è un esercizio di futurologia, anche se la vicenda che racconta è proiettata nel futuro. Pubblicato nel 1958, si presenta come cronaca di una ribellione nel 2034 e ricostruisce la serie di sviluppi, a partire dagli anni ’60, che hanno portato a quella crisi.
Michael Young descrive lo sviluppo e l’ascesa della “cultura del merito”, dal 1870, con cronache e documentazione di fatti reali. Mentre, ovviamente, sono immaginarie le conseguenze successive alla pubblicazione del suo libro.
È basato sulla particolare struttura politica e sociale della Gran Bretagna, ma se ne possono dedurre considerazioni valide anche in contesti diversi. Con penetrante ironia, racconta come un sistema scolastico intenzionalmente ugualitario e basato sul “merito” si possa trasformare in un nuovo genere di aristocrazia ereditaria.
Michael Young immagina che, in seguito alla riforma scolastica e alla più ampia possibilità di accedere alle università, le oligarchie tradizionali vedano indeboliti i loro privilegi – e li recuperino impadronendosi dell’intelligenza.
Si crea così un solco fra una minoranza mentalmente e culturalmente evoluta e una maggioranza intontita dalla banalità dei mass media e da varie forme di soporifero spettacolo.
La discriminazione è spietatamente selettiva. I figli stupidi degli aristocratici sono degradati alle “classi inferiori”, mentre le famiglie privilegiate adottano i più intelligenti nati dai plebei. I sudditi sono privati delle risorse mentali e organizzative necessarie per potersi ribellare.
Il sistema sembra inattaccabile, ma residui di tradizionale maschilismo tengono troppe donne intelligenti in condizioni di inferiorità. Molti anni dopo l’instaurazione del regime, giovani aristocratiche si alleano con vecchi sindacalisti (rimasti nelle classi oppresse prima che fossero private di intelligenza) e così gli emarginati trovano la guida di cui hanno bisogno. La rivolta, nel maggio 2034, è violenta. Ma la storia si conclude prima che se ne possa conoscere l’esito. Michael Young, alla fine, si chiede se potrà avere un durevole successo e osserva che “probabilmente è troppo tardi”.
La diffusione di opinioni critiche
Ci sono somiglianze, tutt’altro che casuali, fra la storia immaginata da Michael Young e tre classici sulla degenerazione delle società moderne: Brave New World di Aldous Huxley, Animal Farm e 1984 di George Orwell (anche se nei loro libri non è usata la parola “meritocrazia”).
L’eccellente libro di Aldous Huxley è stato pubblicato nel 1932 (in italiano il titolo è tradotto Il mondo nuovo) ed è fondamentale sull’argomento. È una metafora, non una profezia, ma sono straordinarie le intuizioni di problemi che oggi stiamo affrontando.
Anche 1984 di George Orwell, pubblicato nel 1948, non è una previsione del futuro, ma una trasfigurazione letteraria di ciò che già allora si poteva constatare (e ha introdotto nel linguaggio il termine “grande fratello”). È altrettanto noto, e sempre rilevante, il concetto “orwelliano” di disuguaglianza demeritocratica descritto tre anni prima (1945) in La fattoria degli animali.Insomma sembra che sia difficile pensare a una “gerarchia basata sul merito” senza coglierne i problemi. Ma il fatto è che il concetto, nato come perplessità, si è poi diffuso (più in teoria che in pratica) in senso vagamente positivo. Cosa, sostanzialmente, corretta e ragionevole. Ma difficilmente applicabile se non se ne valutano le complessità.
Prima di arrivare a “che cosa c’è di buono” nella meritocrazia, sono da citare altri tre libri che la vedono in senso critico.
Uno può sembrare uno scherzo di fantasia, benché il tema sia amaramente serio. The Marching Morons di Cyril Kornbluth (1951). Non usa il termine meritocrazia, che non era ancora stato inventato, ma il concetto è analogo. Il protagonista è un bieco personaggio che esce dalla “crioconservazione” in un futuro dove, in seguito al controllo delle nascite nella popolazione più evoluta e alla smisurata riproduzione dei più arretrati, una minuscola minoranza di intelligenti governa un’immensa moltitudine di imbecilli. Il malvagio “resuscitato” offre all’élite una crudele soluzione per ridurre il problema di una crescita incontrollata: promettere idilliache vacanze su Venere, caricare gli incauti turisti su astronavi e scaraventarli nello spazio. Ma alla fine subisce anche lui la stessa sorte.
Nel 2006, negli Stati Uniti, ne fu ricavato un inutile film con il titolo Idiocracy – una narrazione rozzamente comica su un ipotetico futuro in cui l’intelligenza è estinta e l’umanità è totalmente rincretinita. Mal concepito e peggio realizzato, non ha alcun valore neppure come umorismo.
Il Principio di Peter
Un testo fondamentale sulla meritocrazia è The Peter Principle (1969) di Laurence Peter. Il titolo è così noto da essere diventato, in inglese, un’espressione proverbiale, citata come tale nei vocabolari. Ma in pratica sono scarsi i tentativi di risolvere il problema.
Concepito in un quadro culturale in cui la meritocrazia è considerata vincente – e sostanzialmente desiderabile – il principio di Peter afferma che «in un’organizzazione meritocratica ognuno viene promosso fino al suo livello di incompetenza».
Laurence Peter definisce ironicamente la materia del suo studio “scienza della gerarcologia”. Spiega come una struttura gerarchica, se basata su una giusta valutazione del merito, tenda a promuovere ogni persona meritevole a un livello più alto. Se una persona sa fare bene una certa cosa la si sposta a farne un’altra. Il processo continua fino a quando ognuno arriva al livello di ciò che non sa fare – e lì rimane.
Il risultato è che nell’organizzazione si diffonde continuamente l’incompetenza. E le persone competenti si trovano sempre più spesso alle dipendenze di incompetenti, che le ostacolano nello svolgimento del loro lavoro.
Gli insegnamenti di Peter sono ampiamente ignorati, non solo perché sono scomodi, ma anche perché le persone al vertice delle organizzazioni non amano sentirsi dire che hanno scelto e promosso i loro dipendenti in modo sbagliato – o, peggio ancora, che sono proprio loro ad aver raggiunto il fatale livello di incompetenza.
La situazione oggi è ancora più grave di come la descriveva Laurence Peter – perché il concetto di “merito” è sempre più confuso. Le “promozioni” sono spesso dovute alla protezione di potenze oligarchiche, al gioco delle apparenze o a intrighi che hanno poco a che fare con la “competenza”. Oppure al predominio delle speculazioni finanziarie, di cui parleremo più avanti.
La Legge di Parkinson
In Parkinson’s Law la parola “meritocrazia” non compare, anche perché è stato pubblicato nel 1957, un anno prima del libro di Michael Young. L’ironica, quanto severa, analisi di Cyril Northcote Parkinson riguarda principalmente le disfunzioni dei sistemi gerarchici e dei processi decisionali. Ma non mancano osservazioni sulle balordaggini di valutazione del merito.
Per esempio un capitolo del suo libro, I princìpi della selezione, è dedicato ai metodi con cui si sceglie una persona cui affidare un ruolo di responsabilità. Offre una scherzosa, ma preoccupante, descrizione di come possano essere diffusi (e anche “istituzionalizzati”) criteri che nulla hanno a che fare con le capacità di svolgere adeguatamente quel compito. Sarebbe lungo citare qui il suo ampio e pittoresco elenco, ma non è difficile trovare esempi di questa sindrome.
In un altro capitolo, La paralisi spasmodica, Parkinson definisce una perniciosa infermità chiamata injelitance (che potremmo, pressappoco, tradurre “gelosincompetenza”). Osserva che «il primo segno di pericolo è rappresentato dalla comparsa, nella gerarchia, di un soggetto che racchiude in sé un’elevata dose di incompetenza unita a un altrettanto consistente quantitativo di gelosia». Questo personaggio «è facilmente riconoscibile dall’ostinazione con cui si affanna per estromettere tutte le persone più abili di lui e dalla strenua resistenza che oppone alla promozione o alla nomina di chiunque potrebbe dimostrarsi migliore».
Ma c’è un problema in più: la malattia è contagiosa. Si sviluppa «una gara di stupidità, con persone che fanno finta di essere ancora più acefale di quanto siano in realtà». Alla fine si raggiunge «uno stadio nel decorso di questa malattia quando, dal vertice alla base dell’organizzazione, non brilla più nemmeno una scintilla di intelligenza». Perciò «l’organizzazione è morta. Può giacere in coma per vent’anni, o gradatamente decomporsi, anche se dopo lungo tempo potrebbe teoricamente resuscitare». È preoccupante constatare come troppe organizzazioni decerebrate siano artificialmente tenute in piedi – talvolta perfino resuscitate, senza che sia guarita la loro demeritocrazia.
Il “darwinismo sociale”
e la glorificazione dell’ingiustiziaC’è anche una perversa scuola di pensiero, il cosiddetto “darwinismo sociale”, proclamato nell’Ottocento da Herbert Spencer e altri economisti. Il concetto di “sopravvivenza del più adatto” inteso come spietato predominio di chi ha più successo (in particolare dei più ricchi) a scapito di chi ne ha meno e perciò non merita di sopravvivere se non come suddito asservito ai voleri dei potenti. Oggi quella velenosa teoria è abbandonata da tutti, anche dagli economisti. Ma in pratica è ancora spietatamente applicata in molte situazioni e in molti modi diversi, con una tendenza ad aggravarsi in anni recenti.
C’è un’ostinata stupidità nella moltiplicazione di violenza, repressione, oppressione, persecuzione, sfruttamento. Problemi che c’erano e non si risolvono. Altri che nascono o crescono con trionfante ottusità. Sembra che la natura umana sia irrimediabilmente autolesionista. Ma non è così.
Fin dai tempi dell’illuminismo era chiaro che l’ingenua visione del bon sauvage, come l’aveva immaginata Jean-Jacques Rousseau, non trova conferma nei fatti e nella storia. Cioè non è vero che l’uomo, “buono” e civile allo stato di natura, sia reso barbaro e crudele dalle istituzioni “moderne”. Ma non è vero neppure il contrario: cioè che l’uomo sia “per natura” egoista e malvagio – e che ogni possibilità di convivenza civile debba derivare da un’imposizione autoritaria.
Gli studi sull’evoluzione hanno fatto molti progressi grazie a quasi 150 anni di evoluzione scientifica dai tempi di Darwin. Per esempio si è verificato “il ruolo centrale della fiducia nell’evoluzione umana”. Ogni specie che si possa definire “umana”non è mai totalmente collettiva, ma neppure totalmente individuale. Sopravvive solo con un equilibrio dinamico fra i due fattori.
Sarebbe ingenuo credere che l’evoluzione possa avvenire senza contrasti e conflitti. O che la natura umana sia dominata dall’altruismo, dalla solidarietà e dall’attenzione al “bene comune”. Ma è altrettanto sbagliato pensare che civiltà, etica, collaborazione e solidarietà siano contrarie al carattere strutturale e genetico della nostra specie. Sono necessarie alla sua sopravvivenza – e soprattutto a un’evoluzione che non sia solo l’arte di sopravvivere, ma anche quella di crescere e migliorare.
Premiare il demerito: la speculazione finanziaria
Un esempio vistoso di demeritocrazia è la (cosiddetta) crisi economica in cui stiamo vivendo. Che non nasce dai problemi (esistenti e complessi) dell’economia reale, ma dallo sciagurato predominio delle speculazioni finanziarie, che premiano chi ha l’astuzia di truccare i conti – o la fortuna di approfittare di un momento favorevole quando un’onda speculativa deforma le oscillazioni del mercato.
Le conseguenze sono spesso catastrofiche per chi poi deve raccogliere i cocci, ma intanto chi ha giocato d’azzardo (se non si è limitato a scappare con i soldi) può trovarsi “promosso” molto al di là delle sue capacità di gestire un’impresa o di produrre risultati in un mercato reale.
Ci sono fenomeni, purtroppo non rari, che vanno oltre il principio di Peter – come la promozione a livelli più alti di chi era già incompetente nel ruolo in cui si trovava. Un altro problema è l’imperversare di acquisizioni, fusioni e concentrazioni. Si perdono le identità e le culture che avevano portato le imprese al successo – cioè le competenze nel saper fare qualcosa meglio delle altre. Molte persone vengono eliminate dalla struttura non perché non siano competenti, ma perché nella fusione si creano doppioni di ruolo (e anche perché il costo dell’operazione viene in parte recuperato con la riduzione dei costi di personale).
Nel ribollente calderone dell’organizzazione rimescolata i ruoli si sovrappongono e si confondono. Così non si premiano le persone più qualificate, ma quelle più gradite alla fazione che prende il sopravvento. I giochi di potere e le manovre di corridoio prevalgono su ogni criterio di merito o capacità. Anche se sopravvivono alla strage, le persone competenti sono spesso spostate in ruoli per cui sono inadatte – e comunque demotivate da un clima in cui far bene conta poco.
L’impegno per la qualità non è premiato, la competenza non conta, si bada alla sopravvivenza nel giro tortuoso degli intrighi e delle apparenze. Insomma il classico principio di Peter continua a fare danni, in modo tanto più grave quanto più si mescola con altre disfunzioni.
Aristocrazia e altre deformazioni
Se ritorniamo ad Aristotele (o, più in generale, alle parole che derivano dal greco) vediamo che aristocrazia vuol dire “governo dei migliori”. Ottima idea – in teoria. Ma chi decide quali sono i “migliori”? Con quale criterio? Vediamo che in pratica l’aristocrazia si è quasi sempre trasformata in tutt’altro – privilegio ereditario, feudalesimo, consorteria fra prepotenti o designazione “dall’alto” raramente basata su un reale merito. Come è accaduto con molti altri concetti le cui “buone intenzioni” originali sono degenerate fino ad alterarne il significato.
C’è anche un problema, oggi come sempre, di prospettiva. Chi ha avuto successo tende a pensare che il modo con cui l’ha ottenuto sia merito. E perciò che meritocrazia voglia dire premiare e promuovere i suoi simili.
Ci sono parole ampiamente considerate negative. Come plutocrazia, autocrazia, burocrazia. O, con altre desinenze, oligarchia, gerarchia, tirannia, dittatura. Ma, per quanto concettualmente disprezzate, in pratica continuano a moltiplicarsi. C’è anche chi scherza con idiocrazia, ma non mancano esempi di come possa essere tragicamente vero.
Un caso particolare è quello di monarchia. Per tanti millenni autocrazia ereditaria, largamente accettata come legittima “per diritto divino”, è diventata (in dieci paesi europei) “costituzionale”, con un ruolo di identità e tradizione nazionale, ma non di governo. Sono più numerose le monarchie (di nome o di fatto) nel resto del mondo, ma ormai poche quelle in cui chi un autocrate si chiama re o imperatore.
Perfino democrazia, la più desiderabile e consapevole forma di governo, spesso degenera – e altrettanto spesso la parola è stata, ed è ancora, usata per definire sistemi di potere che poco o nulla hanno di democratico.
La demeritocrazia
(e il destino dei meno meritevoli)Sarebbe interminabile un elenco delle situazioni e dei comportamenti che provocano e moltiplicano la demeritocrazia. Ognuno, osservando i fatti, può aggiungere esempi e interpretazioni. In generale, si può applicare anche in questo senso il concetto che riguarda la stupidità. Non è eliminabile, ma non è invincibile. Capirla e conoscerla vuol dire controllarla e ridurne le conseguenze.
Ma c’è un altro problema. Che cosa ne facciamo dei “meno meritevoli”? Immaginiamo (per quanto improbabile possa essere) che un criterio di scelta e ridefinizione dei ruoli sia infallibilmente meritocratico. Ne consegue, inevitabilmente, che qualcuno sia scartato – e rimanga senza lavoro, oppure sia demotivato da una mancata promozione. Non solo si produce un danno sociale, ma anche un degrado crescente di efficienza e qualità all’interno dell’organizzazione.
Oltre a evitare promozioni all’incompetenza, è importante aver cura di chi è rimasto dove è bene che sia. O più in generale di chi, benché a livelli non elevati nella gerarchia, svolge compiti necessari e insostituibili. Farlo con meccanismi formali o con generica (spesso ipocrita) benevolenza serve a poco – può essere irritante quando è vacuamente rituale. Ma, al di fuori di ogni schematismo, una cura attenta e sincera dei valori umani è molto più importante di qualche banale cerimonia.
Sono poche le persone totalmente prive di merito. Ma, anche in quel caso, nessuna società civile può permettersi di ignorarle. Perfino i criminali devono essere trattati con umanità. A parole, questa è la legge – e un’opinione diffusa fra le persone più consapevoli. Ma anche nella patria di Cesare Beccaria i fatti sono spesso di disgustosa barbarie.
Accade anche che i meccanismi scartino, o non sappiano valorizzare, il merito migliore. Le persone più attente, brillanti, davvero innovative, sono spesso bizzarre rispetto alla cultura dominante. Impazienti, impertinenti, irriverenti, disobbedienti, non convenzionali. Scoprire e incoraggiare il talento è un’arte. Difficile, quanto preziosa.
Il merito non è potere
– e spesso il potere non è meritoNon è una pignoleria etimologica chiederci che cosa succede quando “merito” si combina con “crazia”. Le parole che finiscono con -crazia o -archia sono tutte, in qualche modo, pericolose. Come lo è il concetto di potere.
Perché un’organizzazione o una comunità umana, dalla più piccola combriccola fino al governo del pianeta, possa funzionare, è necessario che a qualcuno sia dato un adeguato “potere”. Quando è inteso come responsabilità, funziona bene. Ma troppo spesso diventa prepotenza. Perché c’è un meccanismo, nella natura del potere, che funziona in modo antievolutivo – cioè favorisce i meno adatti.
Come fa una persona ad avere potere? Qualche volta ci arriva senza volerlo. A qualcuno si dà fiducia perché ci si fida di quella persona. In quel modo il potere viene spesso attribuito a persone capaci, competenti, ben motivate e con un forte senso di responsabilità. Questo processo ha buone probabilità di generare potere meritevole e meritato. Ma ne vediamo assai meno esempi di quanto ci piacerebbe.
Il motivo è che c’è concorrenza. Una forte, talvolta feroce, spesso ansiosa, sempre impegnativa competizione per il potere. Le persone che non cercano il potere in quanto tale, ma badano di più al bene altrui, hanno meno tempo ed energie da spendere per conquistare il potere – o anche per cercare di conservare quello che hanno. Mentre le persone assetate di potere, anche indipendentemente dai suoi effetti sulla società, si concentrano sulla lotta per il potere. Con conseguenze tutt’altro che meritocratiche.
Diceva Friedrich Nietzsche: «si paga caro l’acquisto del potere; il potere istupidisce». Il potere è una droga, uno stupefacente. Molte persone al potere sono afflitte da megalomania. Indotte a pensare che “poiché” stanno al potere sono migliori, più capaci, più intelligenti, più sagge del resto dell’umanità.
Sono anche circondate di cortigiani, seguaci e profittatori che rinforzano continuamente quell’illusione. Vittime di quel perverso meccanismo non sono solo i governati – che subiscono il giogo degli intermediari oltre a quello dei vertici. Sono anche, spesso, i “sommi potenti”, che diventano prigionieri del loro entourage.
Perciò del potere è sempre bene diffidare. Non ammirarlo, non assecondarlo, né passivamente seguirlo, senza aver verificato che chi ce l’ha se lo meriti.
Che cosa succede con merito-crazia? Sarebbe bello, se non fosse difficile, dare responsabilità solo a chi la merita. Ma comunque c’è un problema nel concetto. Ci possono essere (e in pratica sono tante) persone straordinariamente “meritevoli” che non hanno la capacità, né il desiderio, di “comandare”. Perciò un sistema “meritocratico” deve, prima di tutto, saper riconoscere, giustamente premiare, affettuosamente ammirare, il merito di chi ci dà un prezioso contributo senza avere, né desiderare, alcuna “crazia” né “archia”.
In un sistema armonioso e intelligente si può capire e usare bene la differenza delle capacità. Alcune persone possono avere migliori doti organizzative, e perciò ruoli di gestione, senza per questo avere un “rango” superiore a chi in altro modo dà un contributo non meno importante.
L’efficienza di quel metodo è ampiamente dimostrata. Ma purtroppo continuano a prevalere le strutture gerarchiche. Che sono le meno efficienti, ma gradite ai burocrati – e ai dirigenti troppo spesso motivati da carrierismo estraneo a ogni valore di qualità.
Le ambiguità del “merito”
C’è una domanda fondamentale: che cosa si intende per “merito”?
Ogni sistema che voglia definirsi meritocratico con un metodo formale è costretto a irrigidirsi in uno schema che sia aritmeticamente misurabile. Deve perciò affidarsi a un meccanismo di esami o di valutazioni attitudinali rigidamente definito. Molto simile, se non uguale, a quelli usati per misurare il “quoziente di intelligenza” – che, notoriamente, non funzionano. Per vari motivi, di cui il più importante è che sono definiti secondo schemi culturali che premiano l’omologazione e ostacolano la diversità, incoraggiano l’obbedienza a scapito dell’indipendenza di giudizio, promuovono l’abitudine e puniscono l’innovazione.
Per questo motivo l’oligarchia immaginata da Michael Young rischierebbe un progressivo intontimento, chiudendosi in una ripetitiva convenzionalità. Ma anche al di fuori di scenari ipotetici non mancano esempi reali di culture che degradano nell’abitudine e nel dogmatismo, per l’incapacità di riconoscere il merito (e l’intelligenza) delle persone e delle idee che non si adeguano ai loro preconcetti.
Occorre anche ricordare che non può esistere alcun concetto universale di “merito”. La stessa persona può essere eccellente in un ruolo, scadente in un altro. Ogni concetto rigido di “mansione” conduce all’inefficienza. (Da tutta la vita sto dicendo che gli organigrammi non funzionano perché le persone non sono rettangolari – e ho avuto la fortuna di poter verificare quali ottimi risultati si ottengono quando si riesce ad adattare la struttura alle risorse umane, non viceversa).
Stiamo assistendo, purtroppo, a un’imperversante diffusione della demeritocrazia. Un problema che c’è sempre stato – e che si potrebbe capire meglio se non ci fosse una diffusa tendenza a dimenticare le lezioni della storia. Ma senza trascurare il fatto che la situazione di oggi è per importanti motivi diversa da ogni epoca precedente.
In sintesi, il problema è di dimensioni. L’umanità non è mai stata così numerosa – e con un così grande potere di influire sull’ambiente di tutto il pianeta. Le lezioni della storia rimangono valide e utili, ma non sono sufficienti per guidarci in una situazione mai prima sperimentata. La demeritocrazia è diventata gravemente insostenibile.
È tipico, quanto disastroso, che in situazioni come questa ci sia un crollo della fiducia e una diffusione dello scaricabarile (quando qualcosa non funziona è sempre “colpa di qualcun altro”).
È difficile, ma non è un’utopia
Insomma il concetto di “meritocrazia” è discutibile – e può essere interpretato in modi molto diversi. Ciò non significa che sia sbagliato. Al contrario, quando funziona è non solo moralmente e umanamente desiderabile, ma dà anche ottimi risultati.
Chi ha esperienza di ambienti di vita e di lavoro in cui il clima è di collaborazione e rispetto reciproco, di forte motivazione, di riconoscimento del merito, sa bene quanto sono gradevoli e quanta qualità sono in grado di produrre. Ma la percezione è più emotiva che razionale, più istintiva che formale, più umana che schematica. E qui sta il problema. È molto difficile che il “merito” si possa definire e gestire secondo criteri standardizzati, burocratici o normativi.
Il tema della meritocrazia è stato – e continua a essere – ampiamente discusso. Molti pensano, non senza motivo, che sia un’utopia. Purtroppo lo è, se si immagina che possa essere universale e omogenea, applicabile a tutto e a tutti secondo uno schema rigido e con un unico criterio. Ma ciò non vuol dire che sia impossibile.
Con flessibilità e buon senso, sensibilità e comprensione, si può davvero dare valore al merito – molto più e molto meglio di quanto accada nella maggior parte delle organizzazioni (comprese quelle che immaginano, o fingono, di essere meritocratiche). E anche in ogni genere di rapporti umani.
Più che un metodo, è un’idea. Più che una disciplina, è un ideale – come tale irraggiungibile in “perfezione assoluta”, ma fertile e desiderabile come atteggiamento e aspirazione.
Potremmo, se ne avessimo davvero il desiderio, fare enormi progressi nel riconoscere il merito, dovunque sia. Ogni impegno in quel senso è, in sé, meritevole – ma anche nel “migliore dei mondi possibili” non riusciremmo mai a scoprire tutte quelle persone che, senza mai avere, né desiderare, le luci della ribalta, stanno migliorando una parte, piccola o grande, del mondo in cui viviamo. A quei tanti generosi “ignoti” probabilmente nessuno dedicherà mai un monumento. Ma meritano la nostra perenne gratitudine.
Alcuni link
A proposito di intontire, come metodo per asservire e dominare,
(che non è solo immaginato nel libro di Michael Young)
vedi Tettontimento.
Una più estesa spiegazione del principio di Peter e delle sue conseguenze
è nel capitolo 6 di Il potere della stupidità.
Una nuova traduzione italiana di La legge di Parkinson
è stata pubblicata da Monti & Ambrosini Editori nel gennaio 2011.
A questo libro e alla sua importanza
è dedicato il capitolo 5 di Il potere della stupidità.
Un’analisi più estesa della demeritocrazia
si trova in La stupidità del potere,
capitolo 10 di Il potere della stupidità.
A proposito di “darwinismo sociale”
vedi L’evoluzione dell’evoluzione
e Stupidità: istinto o cultura?
(in particolare le parti 5 e 6)
dove si trovano anche alcune osservazioni
sulla pericolosità della demeritocrazia
nella fase evolutiva in cui ci troviamo.