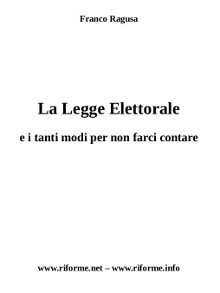
di Franco
Ragusa
| Leggi
del Diritto Pubblico e Costituzionale:
Approfondimenti |
|
|
Sentenza No Porcellum: qualche complicazione di
troppo, purtroppo, ad uso e consumo della malapolitica
Franco Ragusa 14/01/2014 (ultimo aggiornamento:
18/01/2014)
Pur nella
relativa semplicità delle questioni
sottoposte al suo esame, la sentenza 1/2014 della
Corte Costituzionale, che ha finalmente cassato
alcune parti del Porcellum, verrà sicuramente
ricordata non tanto per la chiarezza, quanto per
alcune complicazioni interpretative di troppo.
In primo luogo
i criteri adottati per lo scrutinio di
proporzionalità e ragionevolezza per
decidere sul premio di maggioranza del Porcellum,
attraverso la verifica “che il bilanciamento
degli interessi costituzionalmente rilevanti non
sia stato realizzato con modalità tali da
determinare il sacrificio o la compressione di uno
di essi in misura eccessiva e pertanto
incompatibile con il dettato costituzionale.”
Come inizio
non c'è male, visto il labile confine
facilmente variabile, in quanto “Tale giudizio
deve svolgersi «attraverso ponderazioni
relative alla proporzionalità dei mezzi
prescelti dal legislatore nella sua insindacabile
discrezionalità rispetto alle esigenze
obiettive da soddisfare o alle finalità che
intende perseguire, tenuto conto delle circostanze
e delle limitazioni concretamente sussistenti”.
Si tratta
cioè di “valutare se la norma oggetto di
scrutinio, con la misura e le modalità di
applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al
conseguimento di obiettivi legittimamente
perseguiti, in quanto, tra più misure
appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei
diritti a confronto e stabilisca oneri non
sproporzionati rispetto al perseguimento di detti
obiettivi.”
Hai detto nulla! Per quanto
riguarda il Porcellum, ormai sappiamo bene che “le
suddette condizioni non sono soddisfatte”.
Ma sembrerebbe
trattarsi, più che altro, di un caso
specifico, dove il meccanismo premiale che si
attiva, “allo scopo di garantire la
stabilità del governo del Paese e di
rendere più rapido il processo decisionale,
ciò che costituisce senz’altro un obiettivo
costituzionalmente legittimo”, è
però tale da rovesciare, tenuto conto
dell'impianto proporzionale adottato, “la ratio
della formula elettorale prescelta dallo stesso
legislatore del 2005, che è quella di
assicurare la rappresentatività
dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette
norme producono una eccessiva divaricazione
tra la composizione dell’organo della
rappresentanza politica, che è al centro
del sistema di democrazia rappresentativa e
della forma di governo parlamentare prefigurati
dalla Costituzione, e la volontà dei
cittadini espressa attraverso il voto, che
costituisce il principale strumento di
manifestazione della sovranità popolare,
secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”
Per essere
quindi chiari arriviamo al dunque con una domanda:
il premio di maggioranza senza soglia minima di voti
va censurato tenuto conto degli effetti concreti,
con riguardo, cioè, all'eccessivo premio in
seggi che potrebbe essere in ogni modo ottenuto da
una lista rispetto ai voti effettivamente
ricevuti, o perché irragionevole in
riferimento, per lo più, all'impianto di base
che è di tipo proporzionale?
A leggere un
altro passaggio delle argomentazioni della Corte
sembrerebbe confermata la seconda chiave di lettura.
Il principio
fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48,
secondo comma, Cost.), “infatti, pur non
vincolando il legislatore ordinario alla
scelta di un determinato sistema, esige comunque
che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con
pari efficacia alla formazione degli organi
elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume
sfumature diverse in funzione del sistema
elettorale prescelto. In ordinamenti
costituzionali omogenei a quello italiano, nei
quali pure è contemplato detto principio e
non è costituzionalizzata la formula
elettorale, il giudice costituzionale ha
espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora
il legislatore adotti il sistema proporzionale,
anche solo in modo parziale, esso genera
nell’elettore la legittima aspettativa che non si
determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e
cioè una diseguale valutazione del “peso”
del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione
dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un
pregiudizio per la funzionalità dell’organo
parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio
2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22
maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952).”
La distinzione non è di poco conto, in
quanto dai sostenitori e fondamentalisti delle
forzature maggioritarie sono subito giunti i
"chiarimenti" per spiegare, ad esempio, che tutte e
tre le proposte avanzate da Renzi sarebbero
compatibili con la sentenza.
Ma è proprio così?
Non proprio.
Che la
specificità del sistema elettorale adottato
imponga criteri più rigorosi in un verso
piuttosto che in un altro, nulla toglie
all'esigenza, implicitamente confermata dalla
Consulta, di intervenire in via generale sui
meccanismi di trasformazione dei voti in seggi
laddove questi potrebbero consentire “una
illimitata compressione della
rappresentatività dell’assemblea
parlamentare, incompatibile con i principi
costituzionali in base ai quali le assemblee
parlamentari sono sedi esclusive della
«rappresentanza politica nazionale»
(art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del
voto e quindi della sovranità popolare, ed
in virtù di ciò ad esse sono
affidate funzioni fondamentali, dotate di
«una caratterizzazione tipica ed
infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra
le quali vi sono, accanto a quelle di
indirizzo e controllo del governo, anche le
delicate funzioni connesse alla stessa garanzia
della Costituzione (art. 138 Cost.):
ciò che peraltro distingue il Parlamento da
altre assemblee rappresentative di enti
territoriali.”
Questo
passaggio, che distingue Camera e Senato dalle altre
assemblee rappresentative di enti territoriali,
è importantissimo per valutare appieno i
limiti entro i quali i meccanismi premianti, diretti
o indiretti che siano, finalizzati a facilitare
l'azione di governo, debbono soggiacere.
Il Parlamento è sede esclusiva della
rappresentanza politica nazionale, per cui
ciò che potrebbe essere ritenuto in qualche
modo "digeribile" per le assemblee di rango
inferiore, non può esserlo per l'Organo che
svolge, oltre alle funzioni di indirizzo e controllo
del governo, le delicate funzioni di garanzia della
Costituzione.
Tant'è
che sul punto la sentenza conclude in maniera
chiara: “Le norme censurate, pur perseguendo un
obiettivo di rilievo costituzionale, qual
è quello della stabilità del governo
del Paese e dell’efficienza dei processi
decisionali nell’ambito parlamentare, dettano
una disciplina che non rispetta il vincolo del
minor sacrificio possibile degli altri interessi e
valori costituzionalmente protetti, ponendosi
in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3,
48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta
disciplina non è proporzionata rispetto
all’obiettivo perseguito, posto che determina una
compressione della funzione rappresentativa
dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto
di voto, eccessiva e tale da produrre
un’alterazione profonda della composizione della
rappresentanza democratica, sulla quale si fonda
l’intera architettura dell’ordinamento
costituzionale vigente.”
Alla luce di
queste conclusioni, appaiono quindi quanto mai
forzate tutte quelle interpretazioni che fingono di
ignorare che anche altri meccanismi elettorali
potrebbero comprimere, sotto il profilo degli
effetti concreti, la rappresentatività
dell’assemblea parlamentare.
E a ben
vedere, i premi in seggi del precedente Mattarellum
erano stati, sino alle ultime elezioni del 2013,
superiori al premio di maggioranza ottenuto dalle
due coalizioni vincenti con il Porcellum nel 2006 e
nel 2008.
Peggio ancora
sarebbe con l’ultima proposta di Mattarellum
corretto, con l’aggiunta di un premio al premio
indirettamente già ricevuto.
Lo stesso si
avrebbe, guardando sempre ai possibili effetti sulla
rappresentanza, anche con il modello spagnolo,
peggio ancora se corretto secondo i desiderata del
sindaco Renzi.
E come
valutare, alla luce dei pessimi risultati della
legge per l’elezione dei sindaci (ormai
rappresentativi di una scarsa percentuale
dell'intero corpo elettorale) e tenuto conto del
principio fissato dalla Consulta, tutte le ipotesi
di doppio turno ora sul tavolo?
Peraltro,
anche dalle censure riguardo ai premi di maggioranza
a livello regionale per il Senato, giungono altre
indicazioni.
“... oltre al difetto di
proporzionalità in senso stretto della
disciplina censurata, anche l’inidoneità
della stessa al raggiungimento dell’obiettivo
perseguito, in modo più netto rispetto alla
disciplina prevista per l’elezione della Camera
dei deputati. Essa, infatti, stabilendo che
l’attribuzione del premio di maggioranza è
su scala regionale, produce l’effetto che la
maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia
il risultato casuale di una somma di premi
regionali, che può finire per rovesciare il
risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di
liste su base nazionale, favorendo la formazione
di maggioranze parlamentari non coincidenti
nei due rami del Parlamento, pur in presenza di
una distribuzione del voto nell’insieme
sostanzialmente omogenea ... In definitiva,
rischia di vanificare il risultato che si intende
conseguire con un’adeguata stabilità della
maggioranza parlamentare e del governo.”
Ciò che
la Consulta rileva, è che pur in presenza di
risultati sostanzialmente omogenei, la lotteria dei
premi regionali rischia di vanificare l'obiettivo
della Governabilità.
Tutto vero, ma
tutto ciò, per l'appunto, accadeva, ad
esempio, anche con il Mattarellum. Con maggioranze
solidissime alla Camera; maggioranze fortemente in
bilico al Senato.
Di questo sono
ovviamente consapevoli i sostenitori della
governabilità a tutti i costi, per cui
anche le tre proposte di Renzi, come più
volte segnalato, prevedono formule premianti di tipo
non dichiarato, Mattarellum e il cosiddetto
Ispanico, ma con in più ulteriori elementi
correttivi per garantire la vittoria certa di una
lista.
Ma anche su
questo c'è un passaggio della sentenza, un
inciso tra parentesi, che non andrebbe trascurato
alla luce di eventuali aspetti problematici che
potrebbero derivare dalla somma di più
correttivi: “Le disposizioni censurate non si
limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo (ulteriore
rispetto a quello già costituito
dalla previsione di soglie di sbarramento
all’accesso, di cui al n. 3 ed al n. 6
del medesimo comma 1 del citato art. 83, qui non
censurati) ...”
Il passaggio,
peraltro, pone più di un interrogativo circa
la liceità o meno delle soglie di
sbarramento.
Se si adottano dei correttivi per garantire la
governabilità, come e perché limitare
la rappresentatività delle opposizioni,
privilegiandone alcune a danno di altre?
O d’altro canto: se già si riduce la
rappresentatività, escludendo milioni di
voti in conseguenza delle soglie di sbarramento,
può essere tollerabile un’ulteriore
alterazione della rappresentatività con
l’attribuzione di un premio di maggioranza?
Ma in ogni caso, infine, quale interesse
costituzionale potrebbe esservi nell’escludere
milioni di voti dall’essere rappresentati in
Parlamento?
Sulla carta,
infatti, le soglie di sbarramento non
garantiscono l’obiettivo
di rilievo costituzionale, qual è quello
della stabilità del governo del Paese e
dell’efficienza dei processi decisionali
nell’ambito parlamentare.
Sulla questione delle liste bloccate, infine, la sentenza sembra dapprima privilegiare gli effetti concreti, per poi introdurre, però, elementi facilmente suscettibili di dubbia interpretazione.
La normativa è tale per cui, “La
scelta dell’elettore ... si traduce in un voto di
preferenza esclusivamente per la lista, che – in
quanto presentata in circoscrizioni elettorali
molto ampie, come si è rilevato – contiene
un numero assai elevato di candidati, che
può corrispondere all’intero numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende,
di conseguenza, difficilmente conoscibili
dall’elettore stesso.
Una simile
disciplina priva l’elettore di ogni margine di
scelta dei propri rappresentanti, scelta che
è totalmente rimessa ai partiti.
“... In
definitiva, è la circostanza che alla
totalità dei parlamentari eletti,
senza alcuna eccezione, manca il sostegno della
indicazione personale dei cittadini, che ferisce
la logica della rappresentanza consegnata nella
Costituzione.”
Il principio fissato è sin troppo
chiaro: se il meccanismo di voto, al di là
dei formalismi, è tale per cui, nella
sostanza, l'elettore che vota la lista non
può scegliere fra gli eleggibili di quella
lista, si ferisce la logica della rappresentanza
consegnata nella Costituzione.
Ma
addirittura, se si va a fare un confronto con altre
esperienze di altri paesi, si scopre che “Simili
condizioni di voto, che impongono al cittadino,
scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche
tutti i numerosi candidati in essa elencati, che
non ha avuto modo di conoscere e valutare e che
sono automaticamente destinati, in ragione
della posizione in lista, a diventare deputati o
senatori, rendono la disciplina in esame non
comparabile né con altri sistemi
caratterizzati da liste bloccate solo per una
parte dei seggi, né con altri
caratterizzati da circoscrizioni elettorali
di dimensioni territorialmente ridotte, nelle
quali il numero dei candidati da eleggere sia
talmente esiguo da garantire l’effettiva
conoscibilità degli stessi e con essa
l’effettività della scelta e la
libertà del voto (al pari di quanto accade
nel caso dei collegi uninominali).”
Ed eccolo
quindi qui il paradosso: da un mero rafforzativo dei
concetti espressi attraverso il confronto con quanto
avviene in altri paesi, si arriva all’introduzione
di quegli elementi, poco sopra accennati, facilmente
suscettibili di dubbia interpretazione.
Ma cosa cambia
se le liste sono corte anziché lunghe sotto
il profilo rilevato, e cioè che “alla totalità
dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione,
manca il sostegno della indicazione personale dei
cittadini”?
E cosa cambia
se nel collegio uninominale il candidato è
più facilmente conoscibile, ma la ratio del
voto dell'elettore è sempre la stessa,
cioè indirizzata a contribuire la vittoria
elettorale di una lista e che, quindi, si vota
la lista e, per forza di cose, il candidato imposto
dalla lista?
A quest’ultimo
riguardo, però, c’è da ragionare circa
gli effetti generali che il voto in un collegio
uninominale potrebbe costituire in riferimento
ai diversi modi di assegnazione dei seggi. Effetti
dei quali la Consulta potrebbe aver tenuto conto
nell'accennare ai collegi uninominali.
Si pensi, ad esempio, al modello tedesco.
L’elettore
vota su due schede, una per la scelta uninominale ed
una per la scelta proporzionale, ma la scheda che
realmente conta, ai fini della distribuzione finale
dei seggi, è quella proporzionale.
In altre
parole, con la scelta uninominale l’elettore tedesco
non ha l’angoscia di sprecare un voto o di decidere,
con quel singolo voto, chi finirà per
dominare il Parlamento anche solo in virtù di
un voto in più degli altri.
Le stesse considerazioni potrebbero essere
fatte per l’elezione del Senato in vigore sino al
1993 in Italia, prima dell’introduzione del
Mattarellum.
Gli elettori
votavano per dei candidati uninominali, ma l’alta
soglia da raggiungere per l’assegnazione del
collegio, il 65%, era tale per cui il singolo voto
pesava molto meno ai fini dell’asso piglia tutto
che abbiamo invece conosciuto con il Mattarellum,
dove un collegio poteva essere vinto anche con basse
percentuali di voto (Per buona parte dei seggi vinti
nei collegi del nord nel 1996, si stava intorno a
percentuali del 30-35%, questo per la presenza di
tre forze politiche di peso equivalente almeno in
quell’area del Paese: Polo delle libertà,
L’Ulivo e Lega Nord).
Dopo averci quindi lasciato con alcune
incertezze che daranno modo alla politica di poter
avere tutti ragione e nessuno torto, la sentenza si
chiude, finalmente, con una certezza:
“La
normativa che resta in vigore per effetto della
dichiarata illegittimità costituzionale
delle disposizioni oggetto delle questioni
sollevate dalla Corte di cassazione è
«complessivamente idonea a garantire il
rinnovo, in ogni momento, dell’organo
costituzionale elettivo», così come
richiesto dalla costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012).”
In altre
parole, il Porcellum non c’è più,
sostituito da una legge di risulta ripulita dagli
aspetti di incostituzionalità, già
pronta per essere utilizzata.
Anche per
quanto riguarda il voto di preferenza, sono
sufficienti “interventi normativi secondari,
meramente tecnici ed applicativi della presente
pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra
indicate”.
Pertanto,
chiunque si ostinerà a sostenere di voler
fare una nuova legge elettorale per abrogare il
Porcellum, potrà da ora in poi essere
definito un bugiardo.
Altresì, la Corte non ha potuto che
ribadire la continuità degli Organi
Costituzionali, rinviando gli effetti concreti della
sua decisione “esclusivamente in occasione di
una nuova consultazione elettorale, consultazione
che si dovrà effettuare o secondo le regole
contenute nella normativa che resta in vigore a
seguito della presente decisione, ovvero secondo
la nuova normativa elettorale eventualmente
adottata dalle Camere.”
Ma a ben vedere, un Parlamento formalmente
legittimo per garantire la “continuità dello
Stato”, dove tutti i parlamentari sono stati eletti
solo grazie alle liste bloccate, e dove,
altresì, una buona parte di loro ha potuto
beneficiare anche del premio di maggioranza,
dovrebbe avere o no il buon gusto di astenersi
dall’andare oltre la legge di risulta che fa seguito
alla sentenza della Corte Costituzionale?
Ed il Presidente della Repubblica Napolitano,
infine, avrebbe dovuto o no interrogarsi,
nonché interrogare il Parlamento, circa
l’opportunità di proseguire ulteriormente la
legislatura in corso?
Certo, la
Consulta ha ribadito la continuità dello
Stato, ma un messaggino alle Camere, anche solo per
dimostrare di aver compreso che anche la sua
Presidenza, sotto il profilo politico, non è
propriamente legittima, forse sarebbe stato il caso
di farlo.
|
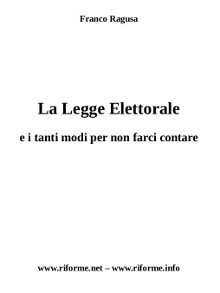 di Franco
Ragusa
|