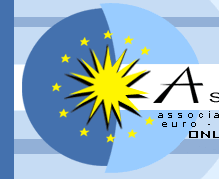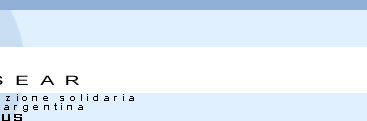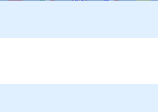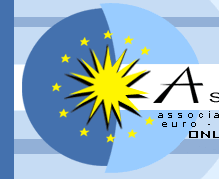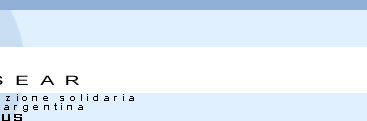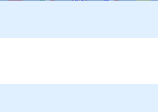|
Cento
fabbriche vivono. Anche senza industriali
Raúl Zibechi
da Buenos Aires
“FABRICA
CERRADA, fabrica tomada” [fabbrica chiusa, fabbrica occupata], è una delle
parole d’ordine divenute popolari in Argentina dopo l’insurrezione del 20
dicembre del 2001. Con quattro anni di recessione alle spalle e livelli di
disoccupazione e sottoccupazione che raggiungono la metà della popolazione
attiva, sono sempre di più i lavoratori che si rendono conto che quando perdono
il lavoro vengono espulsi definitivamente dall’economia formale e sono
condannati a vagare nel limbo del lavoro precario e malpagato, ad arrangiarsi o
a far qualcosa per proprio conto. Per questo, afferrarsi al lavoro come a una
ciambella di salvataggio è stata la via che migliaia di persone hanno cominciato
a percorrere quando i padroni hanno deciso di abbandonare la barca della
produzione per scommettere sulla speculazione.
In Argentina sono ormai più di cento le fabbriche occupate e che producono:
sommate alle 200 del Brasile costituiscono un vero e proprio movimento che
comincia a coordinarsi con altri settori già alla ricerca di vie alternative. Il
movimento di recupero delle imprese si è messo in moto lentamente agli inizi
degli anni ‘90, quando l’apertura dell’economia nazionale ha messo sul lastrico
molte imprese che di colpo sono state considerate improduttive, malgrado molte
di esse avessero beneficiato del sostegno statale sia diretto, tramite prestiti
agevolati e investimenti, che indiretto, attraverso il protezionismo
sull’industria nazionale che aveva garantito loro un mercato esclusivo.
Tessile
Brukman
I primi tempi
sono in genere i più difficili. Le poco più di cento operaie della fabbrica
tessile Brukman, un’impresa che produceva vestiti da uomo nel quartiere Once di
Buenos Aires, rimasero perplesse quando il padrone sparì alla fine di dicembre
mentre il paese si incendiava. Da mesi il padrone pagava solamente una minima
parte dello stipendio, appena un dollaro al giorno, ma aveva accumulato un
debito salariale già da cinque anni. Passavano i giorni, e nella fabbrica non si
vedeva nessun dirigente, così alcune operaie decisero di rimanere dentro. Celia
è una di loro: non aveva la minima esperienza sindacale, aspettava un miracolo
che le permettesse di continuare a lavorare e percepire anche solo una minima
parte dello stipendio.
In diversi casi, i padroni hanno pianificato con tutto il tempo necessario lo
svuotamento delle imprese, indebitate per cifre milionarie con lo stato e con i
fornitori, e in questa strategia furono aiutati anche dalla mafia sindacale
della Cgt ufficiale.
Nella gran maggioranza dei casi, la decisione di mettersi a produrre è maturata
dopo un lungo processo del collettivo dei lavoratori. Non è mai stata una
decisione automatica, ma è sempre stata attraversata da molteplici dubbi,
insicurezze e paure. A volte, c’è voluto più di un anno per rimettere in moto la
fabbrica. Alcune imprese possono contare sulle materie prime abbandonate dal
padrone, altre se le sono dovute cercare o se le sono procurate tramite
donazioni o con l’appoggio popolare senza poter contare quasi mai su prestiti,
almeno nei primi tempi.
Nonostante molti punti in comune, la battaglia giudiziaria è uno di essi, le
esperienze sono molto diverse tra loro. Da una miniera del sud, Yacimientos
carboniferos Rio Turbio, con più di mille lavoratori, che è stata nuovamente
statalizzata dopo tre anni di lotta, fino alla piccola e moderna tipografia
Chilavert, situata in un quartiere di Buenos Aires. In quest’ultima, gli operai
hanno impedito il trasloco delle macchine proprio mentre il padrone svuotava
l’impresa, l’hanno occupata e hanno incominciato a lavorare stampando volantini
e manifesti per le organizzazioni sociali.
Il panificio
Cinco
La solidarietà
è un elemento chiave, soprattutto nella prima fase dell’autogestione, quando
bisogna “aguantar” [tenere duro], una parola che sintetizza la volontà di lotta
e resistenza di fronte all’accerchiamento della polizia e del padrone. È
emblematico un caso avvenuto quest’anno nella zona nord di Buenos Aires. Il
panificio Cinco aveva chiuso nell’ottobre del 2001, licenziando 80 lavoratori
senza pagar loro la liquidazione. Nell’aprile scorso, l’assemblea del quartiere,
nata dopo le giornate di dicembre, per ottenere pane a miglior prezzo s’è unita
a un gruppo di 20 operai del panificio Cinco. Insieme, abitanti del quartiere ed
ex-operai, hanno occupato il panificio e hanno resistito 50 giorni ai tentativi
di sgombero.
La solidarietà del quartiere è stata impressionante: assemblee, piqueteros e
militanti della sinistra hanno montato una tenda all’entrata della fabbrica per
garantire la sicurezza, hanno fatto tre feste, un corteo di quartiere, un
escrache [protesta ad personam] all’impresario, una manifestazione per il primo
maggio, e poi incontri, dibattiti e attività culturali.
Poi si è deciso di formare una cooperativa [i partiti di sinistra proponevano
invece la statalizzazione della fabbrica con il controllo operaio] e ora sono
riusciti a ottenere dal parlamento provinciale l’esproprio e la “donazione” alla
cooperativa dei locali, delle macchine e del marchio della fabbrica. Adesso
producono e vendono pane a prezzi più bassi di quelli di mercato agli ospedali,
alle mense popolari e agli abitanti del quartiere.
Stato o
cooperative?
Un dibattito
profondo attraversa il movimento fin dalla nascita: quale statuto dare alle
fabbriche recuperate? Due le proposte: la proprietà statale con il controllo
operaio o la formazione di cooperative autogestite. La prima viene dalla
sinistra, soprattutto dal Partito operaio [Po] e dal Movimento socialista dei
lavoratori [Mst] ma anche da settori del Partito comunista e dei socialisti.
L’idea è parte dell’immaginario del movimento comunista e rivoluzionario
internazionale e viene adottata senza la minima modifica né autocritica:
consiste nella statalizzazione dell’impresa che, da quel momento, potrà contare
su sovvenzioni statali, ma rimarrà alla mercé della politica dei diversi
governi, mentre i lavoratori controllano e fiscalizzano la gestione.
La proposta cooperativa non prevede la delega della direzione a istanze esterne
al collettivo operaio, il quale assume così ogni responsabilità e rischio,
compresi quelli della commercializzazione dei prodotti. Chi è favorevole alle
cooperative autogestite in molti casi si propone di modificare la classica
organizzazione fordista del lavoro sostituendo i capi e, a volte, mettendo in
discussione la stessa figura del capo officina.
Fino ad oggi, la maggioranza delle imprese autogestite ha scelto la creazione di
cooperative.
Nel 2001 è nato il Movimento nazionale di imprese recuperate [Mner] in cui
confluiscono più di 60 imprese autogestite. Jorge Abellí, dirigente del settore,
sostiene che “consegnare le imprese che abbiamo recuperato e rimesso in funzione
con molta fatica a questo stato mafioso non sembra la cosa più opportuna”.
Abellí è membro di una cooperativa avicola di Rosario che è stata chiusa nel
1998 mettendo cento operai sulla strada. Dopo aver occupato gli impianti e
resistito agli sgomberi e alle pressioni [”Abbiamo passato l’inverno chiusi
nella fabbrica dormendo sulle scatole di cartone”, dice], gli operai hanno vinto
la causa e, dalla fine del 1999, hanno ripreso la produzione.
Le imprese recuperate appartengono a ogni settore: le più grandi sono quelle
metalmeccaniche e siderurgiche. Ci sono giornali e tipografie, ma la maggior
parte è nel settore alimentare. Hanno in media 70 lavoratori e sono diffuse in
tutta l’Argentina. “Non è la stessa cosa gestire una piccola impresa di 15
lavoratori o la più grande fabbrica di trattori del paese”, commenta Abellí.
Si riferisce a un caso emblematico, quello della Zanello di Cordoba, una grande
fabbrica di trattori, l’unica del paese, con 400 operai. Una sentenza
giudiziaria l’ha assegnata ai lavoratori il 28 dicembre. A febbraio hanno
lanciato sul mercato un nuovo modello progettato dagli operai e dai tecnici in
base a un ingegnoso accordo. Hanno organizzato un’”alleanza strategica” che li
ha portati alla creazione di una società anonima, la cui proprietà è divisa in
parti uguali tra gli operai della cooperativa, ora circa 280, i dirigenti e i
tecnici [che in questo modo possono ottener maggiori benefici che non entrando a
far parte della cooperativa], e i concessionari, che hanno messo il capitale per
far riprendere la produzione.
In marzo sono riusciti a fabbricare e a vendere due trattori e oggi, malgrado la
crisi, ne producono e vendono uno al giorno a un costo inferiore del 30 per
cento a quello dei trattori della John Deere. È certamente una soluzione
eterodossa, ma quando si tratta di grandi imprese che producono in settori di
tecnologia avanzata che hanno bisogno di grandi investimenti in macchinari non
sembrano esserci soluzioni semplici.
Oltre alla mancanza di capitale e di materie prime, un grave problema per le
fabbriche autogestite è quello dell’amministrazione. Quando chiudono gli
impianti, infatti, i primi a sparire sono gli amministratori. “La nostra
gestione è precaria ma trasparente e democratica”, dice Abellí. Molte delle
imprese autogestite pagano gli stipendi ogni venerdì e lo stesso giorno mettono
in bacheca un rapporto sulle entrate e le spese in modo che ogni socio della
cooperativa sia al corrente della situazione economica. Il Mner ha fatto un
accordo con l’associazione delle piccole e medie aziende e con l’Università
tecnologica per ricevere un appoggio nella formazione di personale
amministrativo e dirigenti d’impresa.
Economia
solidale
Per quanto
riguarda la commercializzazione, il consumatore viene considerato l’alleato
principale, per questo ci si rivolge alle assemblee di quartiere e agli altri
settori del movimento sociale che lavorano per un “consumo consapevole”. Ma ci
si appoggia anche ai municipi e si tende a rifornire soprattutto ospedali e
scuole. I lavoratori della Brukman, per esempio, hanno fatto una riconversione
dalla produzione di abiti a quella di grembiuli per le scuole e di camici per
ospedali, l’obiettivo era quello di dare un contenuto sociale alla produzione e
avere un mercato più sicuro.
Il bar Alameda
Ma gli esempi
di produzione autogestita vanno molto al di là delle fabbriche e tendono a
generalizzarsi in tutto il movimento popolare. Un buon esempio è quello
dell’assemblea di Parque Avellaneda, un quartiere relativamente centrale di
Buenos Aires. Agli inizi di giugno, gli abitanti organizzati hanno occupato un
bar abbandonato, l’Alameda, l’hanno restaurato e, con l’appoggio di altre
assemblee, hanno attrezzato un locale bar e un ristorante popolare cui
partecipano ora più di 120 persone. Fanno il pane e cucinano e hanno creato una
cooperativa che produce e vende pane a mense popolari e agli abitanti del
quartiere, ora iniziano a produrre anche articoli per l’igiene domestica.
Nel bar recuperato funzionano oltre 20 laboratori che vanno dall’aiuto
scolastico per i bambini fino agli orti biologici, e poi danza, ceramica, yoga,
comunicazione alternativa, autostima e falegnameria. Gli abitanti del quartiere
sono organizzati in otto commissioni per gestire tutte le attività di un vero e
proprio centro culturale e produttivo. È stato creato così uno spazio-assemblea
in cui confluiscono una trentina di assemblee della città e della provincia che
hanno obiettivi simili. In alcuni casi, molte assemblee di quartiere sono
passate dagli acquisti comuni e dalle prime esperienze di baratto [Trueque] all’autoproduzione
di alimenti, in altri a quella di farmaci di base e in altri ancora all’autocostruzione
di case.
Lo spazio-assemblea ha già promosso due incontri di economia solidale a luglio e
agosto nell’ex bar Alameda. Hanno partecipato assemblee, piqueteros, fabbriche
autogestite e gruppi di studenti. Quaranta delegazioni hanno discusso quale
definizione usare. C’è chi propone “economia di resistenza” e chi pensa a una
rete di appoggio agli abitanti minacciati di sgombero. Nelle conclusioni,
riportate dal giornale “Alameda”, si propone di “difendersi reciprocamente dagli
attacchi di chi comanda e di cominciare ad aprire prospettive di lavoro e di
dignità attraverso l’utilizzo delle fabbriche abbandonate, delle terre non
coltivate e delle case vuote”. Quelli di Alameda pensano che “il vento inizia a
soffiare dalla parte dei piccoli” e rivolgono un appello per “articolare gli
sforzi e non essere dispersi dai potenti”.
Un dato particolarmente interessante dell’attuale realtà argentina è l’intreccio
delle diverse iniziative. Le assemblee entrano nella produzione così come i
piqueteros del quartiere di Solano in quello di Quilmes; gli uni e gli altri si
coordinano con le fabbriche autogestite nella speranza di scambiare prodotti;
uniscono gli sforzi per imparare dai successi e dalle sconfitte di ciascuno;
condividono la solidarietà nei confronti della fabbrica di ceramiche Zanon, nel
lontano sud, che ha lanciato sul mercato un modello di piastrelle disegnato dai
mapuche, e così via. La rete, giorno dopo giorno, si fa sempre più complessa, va
e viene, si allaccia e crea nodi, si separa e unisce di nuovo.
La storia
della Impa
Un altro caso
esemplare è quello delle Industrie metallurgiche e plastiche di Argentina [Impa],
che sorge nel cuore di Almagro, un quartiere popolare di Buenos Aires. L’impresa
è stata fondata da alcuni tedeschi nel 1918, era una fonderia di rame. Nel 1935
fu la prima a fondere l’alluminio e, alla fine della seconda guerra mondiale, fu
nazionalizzata dal governo di Juan Domingo Peron. Nell’Impa si fabbricarono gli
unici aerei a reazione prodotti in America latina e le biciclette con le quali
giocavano i bambini argentini. Nel 1961, il governo chiuse alcuni impianti e
decise di convertirla in una cooperativa ma in realtà fu sempre gestita come
un’impresa dai suoi dirigenti.
A metà degli anni novanta, l’impresa di alluminio Aluar iniziò a fare
concorrenza in forma sleale all’Impa producendo i lingotti necessari alla
fabbricazione della carta di alluminio, il prodotto principale dell’impresa
negli ultimi anni. Così, alla fine del 1997 nella fabbrica rimaneva solo un
pugno dei 500 operai che vi avaevano lavorato. La chiusura era imminente, era
già stata tagliata la luce, ma con l’aiuto di alcuni sindacalisti gli operai
occuparono gli impianti, organizzarono una mensa popolare con l’appoggio degli
abitanti e dei commercianti del quartiere e cacciarono la vecchia direzione per
nominare un nuovo consiglio di amministrazione. Decisero così di tornare a
produrre. Erano appena 15 operai [oggi sono 136]. Riuscirono a procurarsi un po’
di materia prima, la riciclarono, ottennero un prestito per riallacciare la luce
e iniziare i primi passi di un lungo percorso che li ha portati a essere punto
di riferimento di tutto il movimento.
Ci sono state due decisioni drastiche. La prima fu l’acquisto di rottami di
alluminio per abbassare i costi ed eludere la concorrenza della Aluar vincendo i
dubbi di tutti i lavoratori che pensavano di non essere in grado di produrre con
materia prima riciclata. Misero in funzione l’altoforno sotto gli sguardi
scettici di tutti. Il successo del processo di fusione e la qualità del
materiale ottenuto rivelò invece che la vecchia divisione del lavoro tra tecnici
e operai, tra quelli che sanno e comandano e quelli che non sanno e obbediscono,
non è che una forma di sottomissione e di controllo dei lavoratori.
La seconda riguardava i lavoratori più anziani. “Abbiamo avuto sempre lavoro per
80 o 90 persone ma ne impieghiamo 136, molti di noi non sono potuti andare in
pensione perché sono stati derubati. Così stanno qui e ci aiutano, spazzano,
puliscono, collaborano come possono. È stata una decisione dell’assemblea, che
ha pensato fosse più giusto e dignitoso farli restare nella fabbrica dove
lavoravano da più di 30 o 40 anni invece di dare loro un sussidio e lasciarli a
casa”, dice il presidente della cooperativa Oracio Campos, un 65enne dai tratti
somatici indigeni. Lo dice così, con una semplicità che commuove, senza rendersi
conto che sta ribaltando tutta la teoria economica, e forse anche la continuità
del loro progetto, a causa di un testardo umanesimo che chiamano “solidarietà di
classe”.
Il capitale?”I
compagni”
Le assemblee
informative sono alla base del funzionamento della fabbrica. “Bisogna muoversi
con molta democrazia e trattare bene i compagni perché è l’unico capitale che
abbiamo”, dicono. Hanno sostituito i capi con i coordinatori di area o di
officina, che si incaricano di dividere il lavoro, e sono riusciti a creare
alcuni gruppi di lavoro per democratizzare l’attività lavorativa. Ma non sono
ingenui: “In alcune sezioni funzioniamo in modo verticale, perché il mercato
esige decisioni molto rapide e non c’è tempo per niente”, assicura Eduardo Murúa,
ex sindacalista di 41 anni che lavora come direttore. Ora la principale
produzione dell’Impa è fatta di stoviglie usa e getta, tappi per dentifrici,
involucri per dolci e vassoi per il catering.
Sull’organizzazione del lavoro, intanto, si producono cambiamenti incredibili,
dovuti più al buon senso che alle posizioni ideologiche. Un’operaia della
Brukman dice risoluta: “Ora abbiamo più libertà nel lavoro e più solidarietà tra
di noi, prima eravamo divisi tra il primo e il secondo piano, adesso stiamo
tutti insieme e ci autorganizziamo”. Le operaie avevano deciso di cambiare la
distribuzione dei macchinari e, in questo modo, hanno cambiato il sistema di
controllo. Abellí, un uomo sempre molto con i piedi per terra, è d’accordo con
la necessità di combattere i “vizi del capitalismo”, ma sostiene che “la
produzione non può essere un processo decisionale permanente”.
L’iniziativa più importante dell’Impa, quella che la distingue da tutte le altre
imprese recuperate e che farebbe invidia perfino a Dario Fo, è la creazione
della Fabrica ciudad cultural [Fabbrica città culturale]. Quasi quattro anni fa
è stato messo su un centro culturale autogestito diretto da un gruppo di 40
giovani in cui funzionano 35 laboratori e si fanno corsi, feste, cinema, teatro
e molte altre cose.
In realtà, il progetto è nato come una specie di ombrello, si cercava la
solidarietà degli abitanti del quartiere e del movimento sociale per risolvere
il problema del debito contratto con la Banca Nacion, che supera i due milioni
di dollari e che potrebbe portare alla messa all’asta degli impianti. “Soltanto
dopo abbiamo capito che era una forma per ricambiare la società per la
solidarietà che riceviamo”, dice Murua. Campos ride e ricorda quando sono
spuntati i punk, “i pelati con orecchini”. Gli operai non ne volevano sapere.
Ora mangiano tutti assieme nella mensa che hanno battezzato con il nome di
Azucena Villaflor de Devicenti, la scomparsa fondatrice delle Madres de Plaza e
Mayo, un’operaia metalmeccanica.
Chi va in fabbrica all’imbrunire, quando la produzione rallenta e arrivano i
giovani, passa da un’officina rumorosa in cui operai sporchi di grasso
armeggiano con le macchine che sputano rotoli di alluminio a uno spazio contiguo
separato da un piccolo corridoio nel quale, nel silenzio più assoluto, un gruppo
di studenti, riuniti intorno a una modella, disegna un nudo. Le attività
culturali sono molte: per esempio si pubblica una rivista che si chiama IMPActo
e tutti sono molto fieri.
Fabrica ciudad
cultural
Nel 2001 all’Impa
è stato realizzato il Festival internazionale di cinema di Buenos Aires, e nel
1998 hanno ricevuto la visita di Orlando Borrego, il compagno del Che nella
Sierra Maestra che ha inaugurato un ciclo di conferenze. Mentre la fabbrica
continua a funzionare, tutti sono orgogliosi del fatto che non ci sono mai stati
incidenti tra gli universitari, gli anarcopunk, le giovani che posano nude, gli
omosessuali e i vecchi operai e le operaie che hanno frequentato la scuola solo
per due o tre anni. Conoscere l’Impa, vedere quelle persone che producono e
creano, è come toccare il cielo con un dito.
In Brasile
La prima
esperienza di recupero di imprese fallite in Brasile iniziò nel 1991. La
fabbrica Calzature Makerli aveva chiuso l’impianto mettendo sul lastrico 482
lavoratori, così alcuni tecnici del Dipartimento intersindacale di studi e
statistiche, con l’appoggio del sindacato dei lavoratori dell’industria di San
Paolo e del movimento popolare, misero in piedi la prima impresa di autogestione
produttiva.
Nel 1994 nacque l’Associazione nazionale dei lavoratori delle imprese
autogestite [Anteag] con l’obiettivo di coordinare le diverse imprese che
nascevano all’ombra della crisi industriale. Attualmente, Anteag ha uffici in
sei stati e segue i progetti di autogestione cercando di integrarli con le
iniziative delle Ong, i governi statali e i municipi.
Contribuire a risolvere il gravissimo problema del finanziamento è uno dei
compiti più importanti dell’associazione. Oggi Anteag lavora con 160 progetti di
autogestione che coinvolgono 30 mila lavoratori. Esistono imprese autogestite in
ogni settore dell’industria, dall’estrazione mineraria [Cooperminas, per
esempio, ha 381 lavoratori] al tessile [decine di piccole imprese, quasi tutte
di donne], fino ai servizi turistici e alberghieri.
Per Anteag, l’autogestione è un modello di organizzazione che combina la
proprietà collettiva dei mezzi di produzione e la partecipazione democratica
nella gestione. Ma implica soprattutto l’autonomia: le decisioni e il controllo
delle imprese appartengono ai loro membri. Queste definizioni inducono Anteag a
considerare che l’assunzione di professionisti per la gestione
dell’amministrazione delle imprese deve costituire un’eccezione e che queste
dovrebbero invece essere controllate dal collettivo.
Per i lavoratori delle imprese autogestite, una delle principali difficoltà è
quella di “ricominciare a pensare”. Anteag sostiene che “la cultura paternalista
ha fatto sì che i lavoratori aspettino che qualcuno faccia le cose al loro
posto”. Alcuni sono convinti di dover delegare tutto ai padroni, altri al
sindacato e altri al governo. Naturalmente, molti timori spuntano al momento in
cui bisogna assumersi le responsabilità e i rischi e farsi carico delle
difficoltà derivanti da una gestione democratica e trasparente. Grandi
difficoltà ci sono anche per comprendere che il consolidamento del collettivo
umano è l’obiettivo fondamentale dal quale dipende la continuità dell’impresa.
Ma l’autogestione è anche un progetto di vita, può diventare un punto di
riferimento sociale per ampi gruppi di lavoratori e far parte delle possibili
alternative al sistema che sorgono dalla base sociale. Per concretizzare queste
aspirazioni, Anteag giudica un passo determinante “la rieducazione del
lavoratore finalizzata alla ricerca di un nuovo significato del lavoro, della
fiducia nelle proprie capacità e, soprattutto, in quella di guidare il processo
di autogestione spezzando il percorso storico della propria sottomissione”.
Carta/Brecha
|
|
|