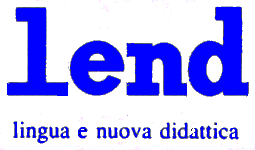
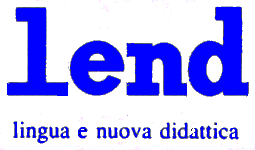
Il Consiglio dei ministri ha approvato i sei articoli del decreto che affida la delega per la riforma della scuola. L’ultimo articolo decreta l’abrogazione della legge n. 30 votata dal Parlamento il 10 febbraio del 2000. Il provvedimento di delega annulla tutto l’impianto ed azzera ogni continuità con la riforma precedente. Scompare il termine "obbligo scolastico", termine presente nella nostra Costituzione. Si cancella, di fatto, l’innalzamento dell’obbligo varato nel gennaio del 1999. La legge delega si limita a stabilire il diritto-dovere all’istruzione e formazione per 12 anni. Mediante l’utilizzo della delega è inoltre vanificato il diritto ad un dibattito parlamentare ampio e ad un confronto pubblico approfondito.
Il sistema duale descritto nel documento Bertagna e ratificato nella legge delega, con un canale d’istruzione formale ed un altro parallelo dell’avviamento al lavoro, reintroduce una scuola che differenzia per censo ed appartenenza. Con la canalizzazione precoce all’età di tredici/quattordici anni si restaura una divisione precoce fra coloro che sanno e coloro che non sanno. Il "sapere" sarà dispensato nei licei, scuole dell'eccellenza riservate ad alunni selezionati. E’ tutto il contrario di quanto raccomandato nel Libro Bianco di Edith Cresson che pone al centro dell’azione formativa il superamento dei divari sociali e culturali e propugna il diritto di tutti alla cultura. L’impianto proposto è vecchio, conservatore, foriero di ristagno culturale. Percorsi scolastici solo addestrativi e diplomi di basso profilo non rispondono neppure alle attese più avanzate del mondo del lavoro che, invece, richiede saperi forti aggiornabili lungo tutto l’arco della vita.
Mentre nel resto d'Europa si cerca di rimediare alle cesure intermedie nell'iter scolastico da noi si ripropone la separazione medie–elementari. Anche in questo caso si rischia di vanificare un lungo, paziente iter sperimentale intrapreso con la creazione degli istituti comprensivi, mirato a ricomporre la continuità fra i segmenti della scuola di base.
Un articolo della legge finanziaria ha già rivoluzionato l’esame di stato: la composizione delle commissioni d’esame é tutta interna, sono, infatti, eliminati i membri esterni, viene, di conseguenza, abolita ogni forma di controllo sulla preparazione degli studenti e sulla qualità del lavoro svolto nella scuola. L’esame di stato era un fattore unificante della scuola pubblica, garantiva, in qualche modo, percorsi comuni. Il processo di regionalizzazione in atto spinge la scuola verso una dimensione sempre più localistica. Un decentramento spinto porta inevitabilmente alla parcellizzazione dei contenuti, cristallizza le disuguaglianze geografiche e sociali, rischia di creare tante scuole chiuse a difesa della propria identità specifica. Una disomogeneità nei percorsi formativi comporta l’abolizione del valore legale del titolo di studio.
La riforma degli organi collegiali prospetta una scuola sempre meno centro di progettazione educativa, cosa che invece era negli intenti della legge sull’autonomia. Le soluzioni semplificatorie volte a riportare gli insegnanti in classe, ognuno dietro la propria cattedra, in una scuola luogo di sola istruzione, con riunioni collegiali ridotte al minimo, possono suonare gratificanti. In realtà mortificano e banalizzano il lavoro del docente, poiché ne minano alla base ogni potenzialità progettuale e tolgono motivazione alla riflessività e alla cooperazione.
L’introduzione dei Consigli di amministrazione in luogo dei Consigli di Istituto, sembra voler sancire un futuro costellato da tante scuole micro-aziende. Il Consiglio di amministrazione prevede un numero ridotto di membri eletti a fronte di vari esperti nominati di diritto. Il dirigente scolastico diventa un amministratore delegato e, di conseguenza, stabilisce l’ordine del giorno del consiglio, lo convoca e lo presiede. Il Collegio dei docenti, scomposto in dipartimenti disciplinari, si limita ad elaborare, coordinare e monitorare il piano dell’offerta, non può più decidere su gli indirizzi generali né sulla gestione quotidiana dell’istituzione scolastica. Il consiglio di classe è abolito. Si prevede una valutazione "in forma collegiale periodicamente alla fine dell’anno scolastico secondo norme indicate dal regolamento d’istituto deliberato dal Consiglio d’Amministrazione". Le nuove modalità di valutazione equiparano il profitto degli allievi al loro comportamento, mescolano la valutazione del profitto con la valutazione del funzionamento dell’istituto, introducono misurazioni oggettive ad ogni livello scolare.
In molti paesi dell’Unione si sono riveduti i vecchi curricoli e li si sono calibrati su percorsi differenziati attenti ai processi di apprendimento e alle varie tipologie dell’intelligenza. L’impostazione curricolare è comunque finalizzata alla promozione culturale, allo sviluppo cognitivo dei giovani e all’acquisizione di consapevolezze culturali e di competenze sociali e linguistiche. Da noi, in netto contrasto con le ricerche europee, si tenta di scardinare un’impostazione pedagogica che pone lo studente al centro nella costruzione dei percorsi di studio. Le competenze sono sostituite da conoscenze, i curricoli diventano piani di studio, la modularità è considerata con sospetto in quanto strumento capace di svilire le discipline che, invece, si vogliono rivalutare nelle forme più tradizionali. Le competenze trasversali pare non meritino miglior considerazione.
L’asse culturale della riforma Moratti si ispira ad una visione di scuola dominata da logiche aziendali-privatistiche, tese a penalizzare tutto ciò che sa di pubblico. La parola chiave ribadita in pronunciamenti e in contesti diversi è competizione. E’ rimesso in discussione il modo di essere, l’esistenza stessa della scuola della repubblica definita dalla Costituzione. Fino ad ora era sempre prevalsa, pur fra mille contraddizioni ed intralci burocratici, un’idea nazionale di sistema educativo pubblico. Si fa strada ora una scuola accerchiata da agenzie formative private alla caccia di finanziamenti erogati dallo stato. La "scuola per crescere" dell’attuale Ministro è solo uno slogan, la sua riforma, in realtà, ci riporta anni addietro, ad una concezione classista che si credeva ormai superata.
Il futuro che si intravede è quello di una scuola meno laica, più povera di risorse dequalificata nella sua funzione pubblica. La scuola vive una stagione di incertezza, di tensioni e conflittualità, in uno scenario normativo agitato dall’irrompere continuo di proclami e messaggi apparentemente rassicuranti, ma autoritari nella sostanza. Fra molti insegnanti serpeggia un forte senso di straniamento di fronte al susseguirsi di tante riforme incompiute, mai realizzate. Ancora una volta, nel nostro paese, ragioni della politica prevalgono sui bisogni veri di formazione ed innovazione.
Oggi servirebbe una scuola che costruisca connessioni e intrecci fra discipline diverse, che colleghi il sapere al saper fare e al saper apprendere, che sappia rispondere alle sfide di una società multietnica e multiculturale favorendo l’integrazione fra culture differenti.
Si dovrà, come sostiene Edgar Morin, "far posto a un tipo di conoscenza capace di inquadrare le cose nei loro contesti, nella loro complessità, nei loro insiemi. E’ necessario sviluppare l’attitudine naturale della mente umana a situare tutte le informazioni in un contesto e in un insieme… Occorre insegnare metodi che permettano di cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra le parti entro un mondo complesso".