|
|
Nebbie edificate in mondi .
Note su Iacopo Lubrano
Alessandra RuffinoRecensione alle ‘Scintille Poetiche’, a cura di Marzio Pieri e con una nota di Luana Salvarani, Trento, La Finestra 2002. pp. 494; cof. con incl. cd-rom contenente le Prediche quaresimali. € 100
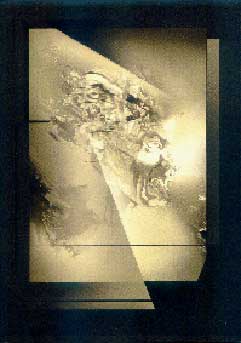
«Se il fine della poesia fosse la meraviglia, il suo tempo non si misurerebbe a secoli, ma a giorni e a ore, e forse a minuti», scriveva Jorge Luis Borges nell’Aleph, e tanto a basti a spianare il campo da barocchi manualismi. Un tempo misurato a secoli è però ancora tempo della storia ed «ottimo lambicco per la chimica morale», avrebbe detto Iacopo Lubrano.
Confrontando la concezione del tempo lubraniana (in cui il molteplice modifica il senso delle cose, ritmandone la deperibilità) con quella di Giordano Bruno (in cui il molteplice aspira a autoconoscersi nell’unità del divenire), Cosimo Ortesta affermava che la poesia, col suo tèssere insieme spazio e parole, finiva per sottrarli al continuum della materia. Il fine (quello dichiarato, almeno) della poesia del predicatore napoletano è trarre “moralità” anche dalla considerazione dei mimina d’un baco da seta. Venticinqu’anni dopo il saggio di Ortesta (Giacomo Lubrano: il tempo del verme, in «Paragone», 326 [1977]), Marzio Pieri, curatore dell’edizione integrale delle Scintille Poetiche [1690] per La Finestra editrice di Trento, dedicando il libro a Giorgio Bàrberi Squarotti, lo preludia meditando sulle considerazioni fatte da Bàrberi stesso sullo stile di Giordano Bruno, la cui esperienza di scrittura – al levarsi del Barocco – dischiuse mondi ove la lingua, prima che tecnica e grammatica, era dunamiV. La lingua è la più potente forma simbolica, tant’è che sopravvive alla perdita della voce (Lubrano fu colpito da afasia d’origine neurotica), travasandosi – e resta aperto l’interrogativo se per volontà o per impotenza – nelle pagine delle Scintille Poetiche e sistemando l’opera lubraniana tra i poli di un’interminata dialettica tra oralità (che è tempo) e scrittura (che è spazio). Se la parola pronunciata o cantata è presenza, quella scritta è passato o futuro. La scrittura può compensare l’infortunio della voce soppressa e riuscire nella fissazione (anche in senso chimico) delle varietà della natura, grazie all’astrazione di un linguaggio che, come notò Claudio Sensi, dà all’“arcimondo” della parola completa autonomia (cfr. L’“Arcimondo” della parola. Saggi su Giacomo Lubrano, Padova, Liviana 1983). Per quanto infatti – in conformità al suo ruolo di religioso – censuri le lascivie stilistiche del Marino, Lubrano, al pari del poeta di Adone (che, si rammenti, fu assai più manierista che marinista), indirizza il suo linguaggio all’immaginazione, prima che – come prassi allegorica vorrebbe – al senso morale. Sconfinando in un topos anche troppo prevedibile, Lubrano invitava: «Voi che a’ sogni credete, / Fermatevi, godete» (Scintille, III, iv). Il sogno, prima di essere assunto nei teatri secenteschi, fu in età manierista lasciapassare che licenziava le più ardite invenzioni. Interessa perciò, in tal senso, il riferimento di Lubrano alle grottesche dipinte a inizio Cinquecento da Giovanni da Udine nell’ode La Fata Morgana nel Faro Siciliano, (Scintille, II, vii, 141-42), nella cui «cadre, décidément maniériste, – spiega Marziano Guglielminetti – Lubrano place de façon baroque toute une série de métaphores, encore une fois rendues abstraites par le langage, mais en réalité suggérées par la Nature elle-même» (Giacomo Lubrano poète baroque, in «XVIIe Siècle», 197 [1997], p. 724). Nell’arte lubraniana, infatti, il paragone arte/natura ha ancora toni di gara: si vedano ad esempio due quadretti mitologici: uno, da Scintille, II, xvi, In lode del Padre Don Ippolito Falcone… per lo libro intitolato narciso al fonte, vv. 8-24, con Narciso:
L’infelice Garzon in riva a l’acque
Limpide più di argento,
Senz’ingiuria di vento,
Vide a fresco ritrarsi, e sì gli piacque
La sembianza che nacque
Da quel mimo pennello,
Che idolatra sorrise al proprio Bello.
Arde, e dubbio non sa come ribolle
Nel giel nuova la fiamma:
La mira, e si rinfiamma,
E comincia a temer quanto pur volle.
Sente di amor già molle
Illiquidirsi l’alma;
E le tempeste sue pinge la calma.
Tronca mezzi sospir’, cenni di Amante,
Stese le braccia al Rio.
Muto gli dice: - o mio! –
E l’altro, tratto dal lamento Nella morte di D. Isabella inferma di idropisia e già vicina alle nozze, vv. 68-81, con Danae:
Ei [scil. Giove] da la sesta Sfera
Dànae prigioniera
Mira chiusa fra l’ombre, e n’arde a’ sguardi;
Vuol e può, ma tra due
Pensa a come celar le fiamme sue.
Pazzo Amor quanto sai!
Smaltasti a nubi d’oro
Tutta l’aria in tesoro,
Gocciolando dal Ciel fulmini e rai.
Quella luce che piove
In auree stelle è Giove:
Gràndina sconosciuto; e dove mai
Non entrò piè mortale,
Con assedii di brine, un Nume assale.
Se i critici – evidentemente – devono concordare sull’affinità di stile tra i due poeti napoletani, c’è una percezione di luogo che li differenzia: alla Napoli chic di Posillipo del cavalier Marino, padre Iacopo oppone la Napoli di Pozzuoli e del Vesuvio, tinta di fumo e d’ombra, ove «la Terra anco è mortal» (I, cxxxii) e contrappesa l’azzurrina altezza di spazî già «ove rilusse / Colorito un Empireo» (I, cxxxvi, ma cfr. anche cxxxiv-cxxxv, sonetti Per le rovine della Cupola nella Chiesa del Giesù, rimasti solo ne’ quattro angoli gli Evangelisti dipinti dal Lanfranchi). L’atmosfera di questa Napoli-sopra-il-vulcano, stravolta da sismiche furie e desertificata da fiamma che dal ciel piove, non compone, tuttavia, un luogo per meditare sulla disgrazia, ma si fa scena della gloria d’un San Gennaro-Ercole, in una visione che traduce in extremis, mitologie pagane mai sopite.
Come fa notare Giancarlo Alfano nell’introduzione a un’intelligente antologia della poesia del Seicento napoletano (Tre catastrofi. Eruzioni, rivolta e peste nella poesia del Seicento napoletano, a cura di G. Alfano, M. Barbato e A. Mazzucchi, Napoli, Cronopio 2000), nella Napoli flagellata da pestilenze, sedizioni popolari ed eruzioni si va stabilendo, secondo una sorta di regìa dedotta dall’immaginario collettivo, una scena ove un orizzonte d’umane rovine contrasta con le macchine di un cielo gremito d’angeli e di sacrosante vergini capaci di sedare coi loro veli vulcani e terremoti. Il modello rappresentativo ed autorappresentativo (e Alfano guarda con acutezza alle coeve iconografie elaborate da Ribera, Preti e Lanfranco) si fa così attivo da determinare la nascita di generi specifici quali la veduta a volo d’uccello della città di Napoli, che educa lo spettatore a un esercizio di visione basato su un doppio movimento di uscita dal proprio spazio e di ritorno in sé, con conseguente meditazione sulla storia come rovina, secondo uno schema (individuato da Barthes in Loyola) di “ortodossia dell’immagine”. Questo processo consente inoltre di considerare come al Lubrano, scoperto poeta primario da novecenteschi lettori di poesia, si fosse arrivati attraverso un cannocchiale rovesciato che dall’algida e siderale poesia di Mallarmé condusse alla pirotecnica e flagrante poetica lubraniana. Ma il viaggio à rebours dal moderno all’antico e un pur fantastico gemellaggio Napoli-Parigi (Napoli e Parigi sono le due sole capitali, diceva romanticheggiando Stendhal) non bastano a comprendere l’esperienza mistica d’una poesia al cui incontro si va solo accettando l’affondo nella notte del senso lungo un itinerario che tocca le stazioni di Alessandria, Gerusalemme, Roma e Bisanzio.
Ad attraversare la notte, infatti, possono non bastare le luci d’un fuoco che illumina a giorno la tenebra, ma forse qualche scintilla solamente, o forse una luce fuori-natura: perciò, le corrispondenze spericolate poste da Lubrano non operano nel campo – già esteso – dell’analogia, ma aspirano alla percezione simultanea dei contrarî (appoggiandosi al concetto, caro ai mistici, della ‘santa stupidità’), e tendono all’identità o alla tautologia, quella, per intendersi, antonomastica dell’Ego sum qui sum, oggetto d’una serie di sonetti in Scintille, I, lxxiii-lxxvii. Vi è comunque, nel gesuitismo secentesco, un côté mistico che tende a una Gerusalemme romanzesca, ossia a un luogo abolito o desiderato ancora, ma che è ancora, appunto, luogo della mente. E piace ricordare, a questo punto, un breve saggio del finissimo Yves Bonnefoy, L’architettura barocca e il pensiero del destino, tra le cui righe si rinviene, nella topica contrapposizione Borromini/Bernini, il senso di una lettura del Barocco more mistico della cui opportunità il Pieri s’interroga riguardo a Lubrano. Leggere Lubrano in senso borrominiano significherebbe riscoprire le pointes gotiche del predicatore e spostare l’asse di lettura su quella che Bonnefoy ha definito «immaginazione desiderante». Borromini creava oggetti non inseribili nella realtà perché esistenti su un piano interamente mentale e astratto. In quel saggio, edito nel 1979 da Sellerio nel libro Un sogno fatto a Mantova, Bonnefoy suggerisce come necessario alla comprensione del Barocco il recupero del rapporto tra l’arte secentesca e quel tipo di statuaria, riscoperta nel Quattrocento, che «aveva ravvivato l’insidia del numero, della proporzione celata in ogni cosa reale, e della perfezione “assoluta” di cui è capace quell’armonia». Bene. Il poeta moderno Adonis (richiamato da Pieri nel suo saggio), ragionando su come il pensiero poetico arabo si fondi sul canto, cioè su numero e armonia, riporta allo stesso tipo di seduzione. E proprio nelle composizioni per musica del Lubrano, come chiarisce Luana Salvarani nella nota Simultaneità lubraniane che accompagna l’edizione La Finestra, si coglie appieno il senso storico della poesia del predicatore gesuita. Eppure, vorrei aggiungere, l’intonazione di certi brani di Lubrano va oltre il programma del ‘trar moralità’: talvolta in senso shakesperiano, talvolta anticipando (perfino nel gusto per la nota di costume) la rocaille. Nel primo caso, oltre a monodie ove il metronomo scandisce il tempo d’un periodico «vita mortal che sei?» (III, ii, Brevità di nostra vita, ma cfr. l’attacco ‘fortissimo’: «Mortalità che sei? Ove ti scondi / Se puoi perire a un alito di Fato?» in I, cxxx, Terremoto orribile accaduto in Napoli nel 1688), si veda l’esemplare Lamento de la Prencipessa di Massa a la vista del core di D. Francesco Toraldo suo sposo…, vv. 47-53 e 120-26, che declama frenesie erotico-macabre da donna-di-dolori valdughiana (e infatti, in explicit al suo La Tentazione, Milano, Crocetti 1985, Valduga – che appartiene a quel Novecento degl’eredi di Mallarmé che optò per un far poesia fedele alla retorica e alla forma – pose un passo da La Vigna Mistica dell’Anima, compresa nelle Prediche Quaresimali):
Quale più cupo bosco infra de’ monti
Nell’ombre sue m’accoglia,
vivo solo alla doglia.
Voraggini, voraggini!
Pensieri, che volete?
Caliggini, caliggini!
Occhi miei, che vedete?
[…]
Mi svenarò le luci,
T’aprirò nel mio petto,
Oh mio sposo, oh mio core,
Ricca del sangue mio urna d’amore;
Et ad onta di morte
Godremo in questo loco
Io del cenere tuo, tu del mio foco.
In direzione opposta alla dismisura d’un immenso dolore, stanno i «minuti piaceri» di certi episodî tutti (auto?)-compiaciuti di un’enumerazione caotica e paratattica (si vedano anche i componimenti dedicati a spine e fiori del “Dittico lucchese” dell’ed. Pieri), del cui tenore proporrei a campione non un passo in versi, ma uno in prosa latina dalla dedicataria agli epigrammi Suaviludia Musarum ad Sebethi ripam [1690], nella quale – cito nella versione pieriana – si cicaleggia in tal fatta:
Le nobildonne d’oggi vantano le più recenti delikatessen e certi tipi esotici di lussuose leccornie, gli è che il mondo muliebre è tutto chiuso in questo microcosmo dei minuti piaceri. Rivestono gli scrigni di preziosi gingilli minutissimamente lavorati e si giudicano fra di loro per via di questa ostentazione del superfluo. Vedere una bella suppellettile è divertirsi a curiosare o ludibrio di pigrizia? Tavolini, caraffe, vasellame, carrozze e altre raffinate sottigliezze del medesimo genere, tutte affinate in punta, e non solo per pascere gli occhi.
[Nobiles hodieque foeminae recentissimas blanditias et exotica quaedam luxuriae scitamenta jactitant, muliebri Mundo in voluptatulae microcosmum contracto. Scrinia pretiosi rerum miculis minutim elaboratis exornant; atque ista superflua ostentatione se censent. Videre est integram supellectilem, curiosae solatium, an ludibrium desidiae? Mensulas, lagenulas, alveolos, quadrigulas, aliasque id generis argutias in puncta concisas, nec tenui ad pascendos oculos tantum impendio, da Scintille Poetiche, Trento, La Finestra 2002, p. 338].
La spinta a oltrepassare la parola che ossessiona Lubrano si esprime nel duplice tentativo di superarla sia nella dimensione temporale, attraverso la musica, sia in quella spaziale, attraverso l’invenzione di immagini, la composizione di quadri e la fissazione in gesti. La voce soppressa di cui si diceva, infatti, non dà luogo solo al canto ma autorizza pure il gesto muto del mimo. E va bene che la mimica (additiva o sostitutiva) dell’italiche genti, quelle del Sud in specie, sia proverbiale, ma la relazione tra gesto, teatro e quella pittura che sfonda le vòlte – nient’affatto celesti – delle chiese con prospettive piene di capriole angeliche “nel” Nulla (svelando, insieme a paradisi artificiosi, il sostanziale nichilismo della Controriforma), ecco, la relazione tra queste forme posa su un comune carattere di sintesi, cioè su un criterio d’origine classiche (si pensi, per esempio, alla differenza tra la visione analitico-descrittiva dei pittori nordici, e le sintesi compositive dei pittori mediterranei), che simultaneamente, in Lubrano, convive con il proliferante caos delle cose.
«A gesti senza voci il suon succede: / Parla a gli occhi visibile la mente: / Pien di lingue è il silenzio, il guardo sente» (I, lxxxviii): il gesto del predicatore-mimo compendia in cifre gli affetti e condensa in visibile parlare o (per dirla come nella predica scelta come ouverture all’edizione delle Scintille) in «mutolezza eloquente». La sintesi che porta al gesto è la stessa che porta all’emblema, sicché – a leggerlo anche di scorcio – questo libro di ferro e fuoco offre una miniera di aforismi («ogni giorno è un funeral de gli Anni» I, xlviii; «Non ogni fior è pronubo del frutto» I, li; «L’Alba de’ falli, è l’Espero de’ mali» II, xi; «Gemello de l’Onor nacque l’affanno» II, xviii, ecc.).
Al sommario di decomposizione stilato da padre Iacopo, si accompagna, con pari, zelo lo spargimento di sali (che nel suo caso son metafore, antomàsie, prosopopee, still lifes o – à la De Chirico – ‘nature silenti’ di parole) che preservano dalla corruzione la realtà. Sembra davvero voglia rendere scintilla la polvere, ed affinare a furia di fuoco la ruggine del mondo, smaltando «a nubi d’oro / tutta l’aria in tesoro» ed incorruttibile oro. È un tipo di metodo che giustifica il ricorso all’immagine dell’operazione condotta in vitro, ma per qualche imprevista alchimia pare che dai lambicchi lubraniani, proprio mentre si contempla la vanitas della «nebbia edificata in mondi» (II, vii, 62), si sprigionino torme di spiritate parole che sfuggono di mano al loro demiurgo, figurando, con autonoma dunamiV, arcimondi inescrutati ancora.
Airesis:
Le Ragioni dell'Eresia | Il Giardino dei Magi
|
Ars Regia | Ex Oriente |
Ethnikà |
I Labirinti della Ragione
Le Stagioni della Follia | Lo
Sposo Divino | L'Arte delle Muse
Sectio Aurea | Therapeutiké
| Stati Altri di Coscienza
| Recensioni | Comitato
Scientifico | Links
Indice Generale
| Cerca nel Sito
| Contatta
la Redazione |
Vuoi essere aggiornato?