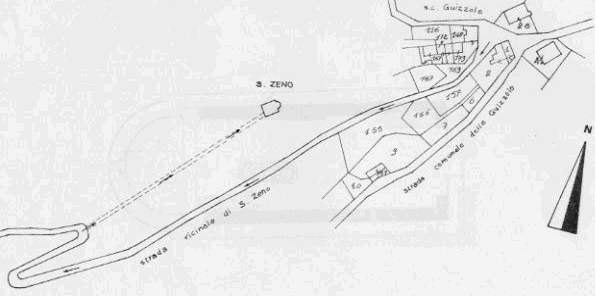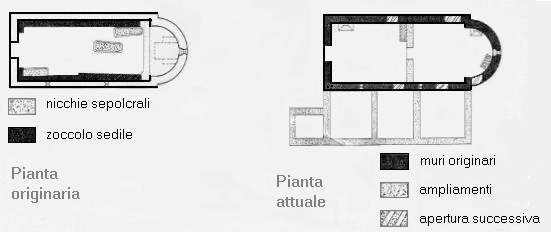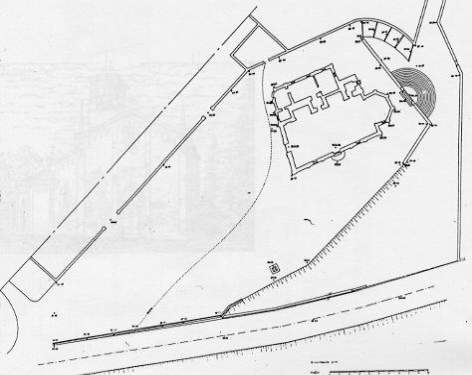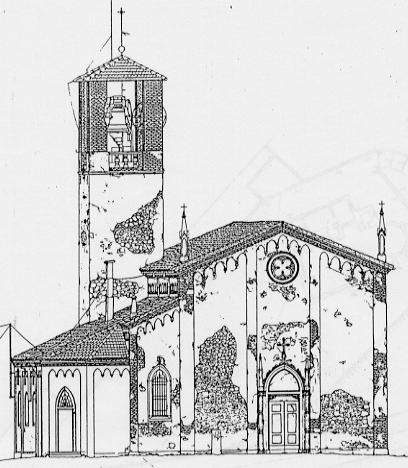Archeologia a Costabissara.
5) IL PERIODO ALTOMEDIOEVALE
Sommario:
a) I secoli bui delle invasioni barbariche.
b) L'inizio del feudalesimo e
l'incastellamento.
c) La diffusione del Cristianesimo e le prime
chiese.
d) La Chiesa di San Zeno.
e) La Chiesa di San Giorgio.
a) I secoli bui delle invasioni barbariche.
Anche nel vicentino i secoli che seguono la caduta dell'impero
romano sono bui; il riferimento non è alla gravità della decadenza,
quanto all' estrema povertà di documentazione. Anche qui per riempire il vuoto esistente
si ricorre a qualche
nozione di carattere generale .
Nel periodo di Odoacre, che aveva deposto l'ultimo imperatore
romano nel 476, e durante la prima parte del regno di Teodorico, che aveva
condotto gli Ostrogoti in Italia, il territorio della penisola viene difeso da
nuove invasioni barbariche, assicurando un periodo di pace e di convivenza, sia
pure non facile, tra i due popoli. Nella seconda parte del regno la
conflittualità si accentua e scoppia una guerra tra goti e bizantini, con
tragiche conseguenze per gli abitanti della penisola: la triade apocalittica - la
guerra, la fame e la peste - miete vittime anche nel vicentino. La riconquista da parte
dell'Impero d'Oriente nel 553 non porta a miglioramenti nella condizione
popolare per l'esosità fiscale degli amministratori bizantini. Dal punto di
vista politico è importante la decisione di Giustiniano di affidare importanti
funzioni amministrative ai vescovi; in tal modo si riconosce uno stato di
fatto, che vede nelle chiese episcopali (prima tra tutte quella papale) e nei monasteri i
nuovi centri del potere, oltre che religioso, anche culturale, economico e
quindi politico.
In tale contesto, nel 568 i Longobardi di Alboino entrano e
conquistano l'Italia; quasi
certamente seguendo la via Postumia, giungono dalle nostre parti da
Treviso ed occupano Vicenza, togliendola ai Bizantini, che si ritirano e si
concentrano a Padova. Non sono attestati episodi particolarmente cruenti o
distruzioni saccheggiatrici, ma dev'essere intervenuto un qualche accordo di
convivenza con le autorità religiose e politiche. Tuttavia l'evento non può
che essere traumatico per la popolazione: un esercito barbaro e potente
s'impossessa del territorio, impone nuovi comandanti e tutto lascia presagire
profondi mutamenti negli usi, nei costumi, nella religione, nelle leggi; la
città è nelle mani del duca e del gastaldo e la periferia è divisa in corti
con nuovi insediamenti ad un tempo civili e militari; la separazione etnica è
rigida e l'elemento romano, al principio, non può che essere di fatto
sottomesso.
Col tempo la convivenza tra longobardi e romani migliora,
soprattutto per l'introduzione di leggi più vicine al diritto romano e per la,
sia pur contrastata, conversione al cattolicesimo dei longobardi; la progressiva
integrazione tra i due popoli è alla fine inevitabile. Tuttavia, la
politica di avvicinamento alla chiesa di Roma (vi rientra la donazione di Sutri
del 728) non è sufficiente ad evitare la chiamata in Italia dei Franchi da parte del papa (che teme l'accerchiamento longobardo dei ducati del Nord e del
Sud).
Nel 774 Carlo Magno pone fine al dominio longobardo.
L'impero carolingio dura solo pochi decenni (fino all'887) e rimane
incompiuto il suo tentativo di costruire un impero universale, fondato sulla
fusione di romanità, germanesimo e cristianità. Nel Vicentino il subentro dei
Franchi segna probabilmente un trauma, ma poi la sostituzione del potere
comitale a quello ducale si rivela per la popolazione un evento dove gli aspetti di
continuità mostrano la prevalenza.
b) L'inizio del feudalesimo e l'incastellamento.
Il IX e il X secolo vedono un periodo di disgregazione del
potere centrale e la conseguente
formazione del sistema feudale italiano. I conti, funzionari pubblici
dell'imperatore, perdono gradatamente il loro potere a favore delle famiglie
locali più potenti e delle autorità religiose, vescovi ed abati, che
acquisiscono diritti, proprietà ed autonomia.
L'autorità regia (da Berengario I del
Friuli a Ottone I di Sassonia) si afferma dalla cruenta conflittualità tra grandi
feudatari. Come accennato, un aspetto fondamentale di questo complesso e confuso
fenomeno sta nella politica regia o imperiale tesa ad acquisire alleati, concedendo
ai propri seguaci, ed in particolare ai vescovi conti (che non offrivano
preoccupazioni successorie), importanti diritti fiscali o di
giurisdizione o di proprietà curtense; tra queste concessioni vi è il diritto
di erigere fortificazioni, gradite anche alla popolazione come difesa dalle
improvvise, devastanti e ripetute incursioni unghere.
I primi incastellamenti sono semplici torrazzi e recinti di
palizzate, luoghi di rifugio temporaneo di uomini e bestie, posti in posizione
atta alla difesa; in breve si arricchiscono di opere murarie e di difesa
sempre più efficaci, fino a cingere le città ed i villaggi pievani od a
costruire i possenti castelli signorili.
Il territorio di Costabissara non sfugge a questo processo
generalizzato. Il libro dei feudi cita un castello d'investitura vescovile sul
colle di San Zeno, detto "mons castri". Oggi sono visibili solo alcuni
resti delle mura e si ricorda il nome di "Donna Berta" che gli è
misteriosamente attribuito. Nel 1813 il Maccà così lo descrive: "Di esso
esiste un pezzo della sua muraglia di tale altezza, che mirasi anche in
lontananza. Essa è grossa tre piedi, ed è formata con pietre rozzamente
quadrate a somiglianza delle mura antiche della città di Vicenza; e si mirano
anche nella stessa muraglia come nelle dette mura di Vicenza alcuni forami
rotondi."
Le fonti citano due altri castelli. Seguiamo il Dalla Cà, che
scrive all'inizio del 1900: "Il secondo castello prendeva il nome di
Pizamerlo dal nome stesso del colle sopra il quale sorgeva, ed esisteva poco
lungi dal primo sopra una collina più alta, a Sud-Est fra la chiesa
Parrocchiale di S. Giorgio, e quella di S. Zenone. Di questo non rimane in tale
località alcuna traccia che possa dare una benché minima e lontana idea
dell'antica sua esistenza. Il terzo, a differenza degli altri due sunnominati,
trovavasi pure in collina, ma presso il luogo borgato."
Quest'ultimo castello
fu distrutto da Ezzelino III, ma venne poi ricostruito dai Bissari, divenuti
feudatari nel 1285; successivamente sono intervenuti vari ampliamenti e
trasformazioni, fino all'ultima sistemazione ottocentesca in romantico stile
neogotico. Ci si riferisce al castello Bissari-Sforza-Colleoni (poi De
Buzzaccarini), nel quale ancora oggi vi sono dei richiami al primo castello
bissaro: quattro eleganti finestre gotiche originali
abbelliscono il piano superiore del prospetto Nord ed all'angolo Nord-Est lo
spessore e la fattura della muratura sembrano la base dell'antico torrione. Si
ritiene probabile, attorno al X secolo, un incastellamento, cioè la costruzione
di un muro fortificato comprendente oltre alla torre la chiesa di San Giorgio,
l'intero declivio e l'attuale villa San Carlo.
c) La diffusione del Cristianesimo e le prime chiese.
Fino al V secolo d.C. sono riscontrate sopravvivenze di culti
della paganità; l'introduzione del cristianesimo nel Veneto avviene tra il III
e la metà del IV secolo d.C., a partire dai centri maggiori e primariamente da
Aquileia e lungo le principali vie di transito; successivamente la nuova
religione si irradia gradualmente verso tutte le zone periferiche. La prima
comunità cristiana di Vicenza ben presto si presenta caratterizzata da fervore
e da prosperità e sono molti i benefattori che decidono di finanziare
basiliche, cappelle e sacelli.
La tesi prevalente vede Vicenza dipendere dalla diocesi di
Padova fino al VI secolo e diventare sede vescovile dal 589/591 col primo
vescovo Oronzio, che aderisce allo scisma antipapale dei Tre Capitoli promosso
dal patriarca di Aquileia. Nel 568 il territorio di Vicenza è invaso dai
Longobardi, che restano a dominarlo per due secoli finendo col fondersi con la
popolazione locale. Portano, come in precedenza gli Ostrogoti, il Cristianesimo ariano, assai diverso da quello
teologico del IV secolo: è un cristianesimo adattato allo spirito semplice e
bellicoso dei barbari paganeggianti, sfruttato abilmente dal re Alboino per
unificare in chiave nazionale varie tribù germaniche; San Michele arcangelo,
con la spada sguainata e lo sguardo truce, ne è il simbolo principale.
La conflittualità tra la chiesa ariana e quella cattolica (a
sua volta divisa tra romana e scismatica) corrisponde alla profonda diversità
culturale dei due popoli, ma i Longobardi assicurano una convivenza
sostanzialmente pacifica; anche gli edifici religiosi riflettono il dualismo tra
esuberanza barbara e semplicità classica. Dopo alterne vicende si giunge nel
698 all'adesione di tutto il popolo longobardo al cattolicesimo ed alla
contemporanea fine dello scisma aquileiese; all'insegna del cavaliere vittorioso
San Giorgio, la chiesa cattolica riprende unita la propria espansione,
supportata vigorosamente dal potere politico anche nella successiva dominazione
carolingia (nel 774 è la completa sottomissione dei Longobardi ai Franchi di
Carlo Magno).
Nel territorio di Costabissara è probabile che la primitiva
chiesetta di San Giorgio sul colle, che poi diventerà parrocchiale, trovi la
propria origine in quei momenti, a servizio di una fara (comunità parentale
armata) longobarda. Risale a quel periodo anche la chiesetta oltre l'Orolo di Santa Maria in
Favrega; si conosce la data di fondazione, che risale al 752, ma l'attuale non conserva
che qualche traccia medioevale più recente; era dipendente
dal potente monastero di Nonantola nel Modenese, al cui fondatore, S. Anselmo,
vennero donate terre vicentine dal figlio del duca longobardo del Friuli Vettari,
pure di origine vicentina. Al di qua dell'Orolo, in località "campi San
Pieri" (via Piave) dalle arature sono emerse tracce di un'altra chiesetta
risalente a quei periodi e loro contemporanea doveva essere un'altra cappella,
alla quale si attribuiscono alcune fondazioni trovate nell'aia e nella vigna di
una casa cinquecentesca dietro villa San Carlo. Ma il maggior interesse archeologico è oggi per la
chiesetta di San Zeno, costruita in epoca longobarda o carolingia, situata su un
declivio a nord est di quella di San Giorgio.
d) La Chiesa di San Zeno.
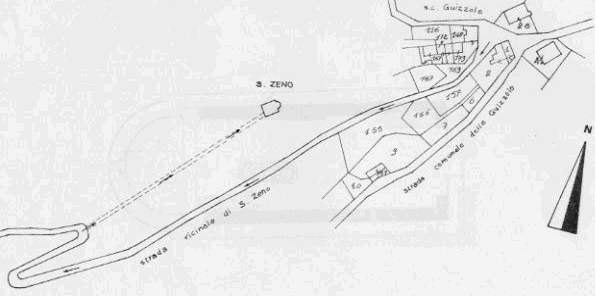 |
La chiesetta di San Zeno, dedicata al vescovo africano di Verona
Zenone, vissuto nel IV secolo, è posta sulle pendici dell'omonimo colle, in posizione dominante sulla
pianura; probabilmente era in relazione col sovrastante castello, citato
come vescovile nel libro dei feudi. Il Maccà nel 1813 localizza la
chiesa
sotto la cerchia dei resti delle mura del castello e la descrive come povero romitorio di un frate. |
La fondazione della chiesa risale forse già ai secoli VII-VIII
ed è tra le più antiche cappelle protocristiane del vicentino; mentre
altre chiese coeve risentono dell'influsso longobardo (cristianesimo ariano),
quella di San Zeno meglio rappresenta la continuità con la tardo romanità
(cristianesimo cattolico); infatti, sia l'impianto che alcuni elementi originali
(come l'arco del portale e la finestrella absidale) sono semplici, equilibrati
nelle proporzioni ed eleganti. Numerosi sono gli interventi successivi: di
ampliamento in larghezza ed in altezza, di costruzione di divisori e di
ricostruzioni delle strutture; sono via via sempre più rozzi ed orientati a
criteri di modesta funzionalità abitativa.
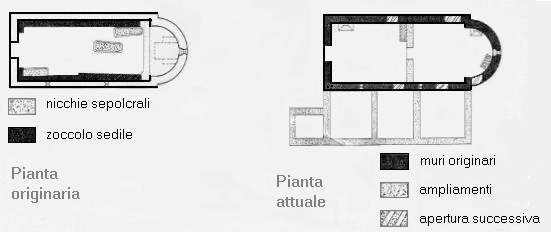 |
E' costituita da un'unica navata,
che costituisce il corpo di fabbrica originario lungo m. 12,70 e largo m. 5,20;
l'abside, rivolta ad oriente, ha un raggio di m. 2,15. In adiacenza, successivamente, è stato costruito un altro corpo con finalità
probabili di sacrestia o romitorio; di quest'ultimo rimangono solo le fondazioni,
ora interrate,
ed una piccola parte di elevato. |
Le parti murarie che più conservano l'assetto originario sono
il muro di facciata, con un arco a tutto sesto di impronta romana, e la parte
absidale ad arco ribassato, classica ed antimonumentale; caratteristici sono il
pavimento e lo zoccolo interno, che corre lungo le pareti laterali con funzione
di sedile, ricavati direttamente dalla roccia del monte. Sul
pavimento sono scavate tre tombe. Ovunque si rintracciano mattoni ed embrici di
fattura romana.
|

|
Facciata prima e dopo il parziale ripristino
(si è
abbattuta la parte superiore non originale, adibita a granaio; fino
all'ultima guerra vi abitavano due famiglie di contadini).
La copertura originaria doveva essere a capriate
semplici, ma non ne resta nessuna traccia; sono però numerosi gli
embrici di fattura romana.
|
 |
 |
Fianco
prima e dopo il parziale ripristino;
a questa parete era addossata la parte
ampliata, adibita a sacrestia o romitorio
sono diversi i mattoni romani utilizzati o riutilizzati
|
 |
 |
Il muro
esterno dell'abside; l'edera copre la classica finestrella; assieme
all'arco d'ingresso rappresentano gli elementi originari della costruzione
.
Due delle tre tombe scavate sul pavimento, costituito
dalla nuda roccia. Ossa umane trovate
attorno alla chiesa denunciano un uso cimiteriale.
Parte del sedile corrente lungo i lati della
navata. |
 |
 |
Frammenti di plutei, a
probabile chiusura dell'altare, con eleganti decorazioni con occhielli ad
ogiva annodati e combinati con diagonali incrociate.
Frammenti di architrave di
"pergula", in pietra di Vicenza, con decori superiori a
"cani correnti" ed inferiori a treccia biviminea; risentono
dell'influsso bizantino. |
 |
 |
Affresco di
Angelo: è l'unico trovato al momento del recupero; si è operato lo
strappo dal muro per la sua salvaguardia.
In una visita arcipretale del 1639 l'altare,
probabilmente spostato rispetto alla posizione originaria, si presentava "decentemente ornato da pitture raffiguranti
la Vergine, S. Zenone e S. Francesco".
In quell'epoca l'oratorio veniva ufficiato in rare
occasioni (principalmente in occasione della festa dell'Immacolata),
portando dalla parrocchiale gli arredi sacri a cura della popolazione; una
visita vescovile del 1768 constatava la presenza di un frate francescano
eremita, che conservava mele cotogne sull'altare, uova, frumento, camicie
ed altro a suo uso sul pavimento. Si cita anche un campanile con una
campanella benedetta pendente. |
e) La Chiesa di San Giorgio.
Secondo l'ipotesi di Attilio Previtali l' impianto originario
della chiesa di San Giorgio è longobardo, dovendosi risalire al periodo seguito
alla vittoria del re cattolico Cuniperto sull'ariano Alachis (688-700). Si
è già citata l'ipotesi di un incastellamento di tutta l'area, suffragato da
alcune tracce di muratura, ma di questo e della chiesa di San Giorgio primitiva
non esistono resti archeologici tali da assicurare una seria datazione.
L'orientamento è comunque quello classico delle prime chiese, con la facciata
ad occidente e l'abside ad oriente; le pareti che si incontrano con un angolo di
82° simboleggerebbero l'inclinazione del capo di Cristo crocefisso.
Le fonti scritte rimandano comunque a tempi assai antichi.
Un primo documento scritto è del 1186; si tratta della conferma papale
del privilegio di decima sulle culture concesso dal vescovo di Vicenza Pistore
ai Canonici (a reiterazione di quanto concesso subito dopo il 1000 dal vescovo
Girolamo), nella quale si cita la chiesa parrocchiale di Costa Fabbrica. Quanto
accaduto successivamente è interessante, ma va oltre l'ambito della presente
ricerca.
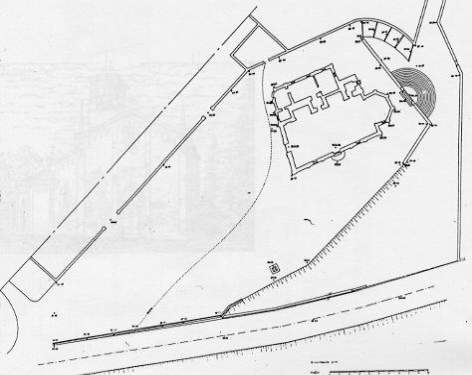 |

|
| rilievo Ceccon,
Lovato, Menin, Traverso anno
accademico 1988-89; Istituto Universitario di Architettura di Venezia
(degli stessi Autori il prospetto della facciata) |
|
La Chiesa attuale è frutto di una
ricostruzione, attorno alla metà del 1400 in periodo veneziano, ad opera
dei Bissari, alla cui giurisdizione familiare il Vicariato di San
Giorgio apparteneva. L'aspetto attuale dipende soprattutto dal
restauro operato nel 1859, che ha conferito un aspetto neogotico. Nel 1868
si è abbattuto il campanile di mattoni a cipolla e si è costruito quello
oggi esistente. |
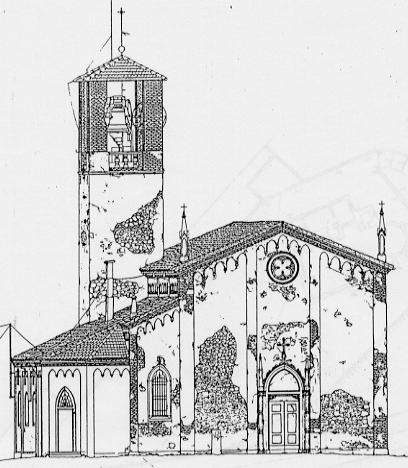
|