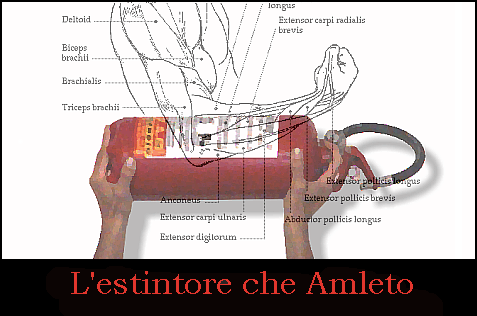Reggio Emilia 7 luglio 1960
REGGIO. «Il cielo era diventato improvvisamente di piombo, una cappa
opprimente calò all'improvviso sulla città. Mentre lasciavamo la piazza,
a occidente si stagliarono lingue rosse di fuoco...». Il ricordo di un
tramonto è la prima immagine che viene in mente a un
testimone-protagonista di quel 7 luglio. Assieme alle mani. Mani che oggi
si muovono mentre rievocano i fatti di allora e che allora vissero quei
momenti. Le mani che quel giorno fremevano mentre lanciavano sassi in
risposta ai proiettili della polizia di Tambroni. Le mani ferme di
chirurgo che cercavano di strappare alla morte i feriti. Le mani di un
giovane cronista che tremavano al momento di scattare la foto del corpo
senza vita di uno dei «Morti di Reggio Emilia».
E oltre le mani, gli occhi, le teste di coloro che oggi, a 42 anni di
distanza, ricordano quel 7 luglio che verrà rievocato e onorato dal
segretario della Cgil Sergio Cofferati.
Le mani che tremano, sono quelle di un giovane cronista, oggi storico
della Resistenza, Antonio Zambonelli, all'epoca studente universitario e
maestro elementarelementare, che quell'anno passerà l'estate nella redazione
reggiana dell'Unità.
LA REPRESSIONE. Quel giorno Zambonelli era in piazza, con la macchina
fotografica al collo. Ma aveva un motivo in più, oltre il lavoro di
cronista, oltre il desiderio di documentare una giornata che si annunciava
carica di tensione: «Qualche settimana prima - racconta Zambonelli - il
30 aprile, avevo partecipato a una manifestazione contro Almirante, venuto
a Reggio per un comizio. Camminavo in via Emilia San Pietro urlando slogan
contro i missini che, cantando le canzoni del ventennio, stavano entrando
nella sede di via Roma. Arrivarono i carabinieri e fui "catenato":
su di me usarono i "ferri", quelle catene che si usavano per
portare i detenuti in tribunale. Svenni, caddi a terra, mi sveglia
all'ospedale e dove fui denunciato per adunata sediziosa».
L'aria, a Reggio, era quella: c'erano già state le lotte alle «Reggiane»,
il livello di conflittualità sociale non era mai stato così alto dal
dopoguerra, la polizia reagiva con la forza a ogni manifestazione di
piazza, e per contro, cresceva tra i giovani un movimento che il sindacato
e il Pci faticavano a «disciplinare».
MAGLIETTE A RIGHE. Spiega Giuliano Rovacchi, ex consigliere comunale e
ragazzo di allora: «Eravamo idealmente figli della Resistenza, eravamo
quasi tutti iscritti alla Fgci, frequentavamo le riunioni del partito, ma
non eravamo inquadrati. Vestivamo con roba importata, i jeans e le famose
magliette a righe. Il nostro rapporto con il partito e lo stesso sindacato
era spesso conflittuale». E la prova si ebbe proprio quel 7 luglio, come
spiega lo stesso Rovacchi: «Aspettavamo che il sindacato si decidesse fin
dalla sera prima. Allora la Cgil non era mai stata per scioperi politici.
Così, c'era attesa dalla sera prima e i dubbi furono sciolti soltanto al
mattino, quando cominciarono a girare le auto con gli altoparlanti».
E la manifestazione partì, ma non poteva restare sui binari decisi dalla
questura che aveva a sua volta ricevuto ordini precisi da Roma: «Erano
vietati gli assembramenti - ricorda Zambonelli - e la manifestazione
avrebbe dovuto tenersi all'interno della Sala Verdi, dove però c'erano
pochi posti».
Poco avvezzi ai diktat del Pci, i giovani con la maglietta a righe non
vollero saperne di quello che aveva loro ordinato la polizia.
IN GRUPPO A CANTARE. «Ricordo - dice Rovacchi - che ci mettemmo davanti
al monumento dei caduti, in un bel gruppo, a cantare...».
Un assembramento pacifico, ma pur sempre un assembramento è. E così,
poco dopo le tre del pomeriggio, dopo che l'altoparlante fissato su
un'auto della Cgil aveva inutilmente chiesto ai manifestanti di evitare
gli assembramenti, ecco la reazione della polizia: «A un certo punto -
ricorda Zambonelli - cominciarono i caroselli degli automezzi della
polizia. Ricordo un'autobotte della polizia che in piazza cercava di
disperdere la folla con gli idranti».
A quei getti d'acqua e ai primi fumogeni, i manifestanti risposero: «Eravamo
nei pressi dell'Isolato San Rocco - ricorda Rovacchi - dove c'era un
cantiere. Entrammo e raccogliemmo di tutto, assi di legno, sassi...». La
mente corre al G8 di Genova e non sarà l'unico parallelo con quei giorni
di un altro luglio di sangue. «Altri manifestanti - dice Zambonelli -
buttavano le seggiole dalle distese dei bar della piazza».
LE RAFFICHE. Poi, all'improvviso, la colonna sonora di quel caos cambiò:
«Si sentirono i primi colpi d'arma da fuoco, le prime raffiche, ricordo
le fronde degli alberi che cadevano a terra» dice Zambonelli.
«Teng-teng, si sentiva questo rumore, teng-teng. Erano pallottole - dice
Rovacchi - e noi ci ritirammo sotto l'isolato San Rocco. Vidi un
poliziotto scendere dall'autobotte, inginocchiarsi e sparare, verso i
giardini, ad altezza d'uomo». Più tardi, ai giardini, si troverà il
corpo senza vita di Afro Tondelli, forse colpito da quei proiettili.
Zambonelli, nel frattempo, aveva smesso di fotografare: «Molti di noi
pensavano a cercare un riparo, mentre il rumore delle raffiche s'infittiva
sempre di più. C'è anche una foto che mi ritrae ingloriosamente mentre
scappo». E Zambonelli, la macchina fotografica ancora al collo, fugge
verso la chiesa di San Francesco, verso le Poste: «Allora - spiega lo
storico reggiano - da quelle parti c'era la sede del Gaf, il Gruppo
artigiani fotografi. Entrai e da lì chiamai a casa, per tranquillizzare
mia madre, ma non vi riuscii, per via di un equivoco: le dissi che ero
dentro al Gaf e lei capì soltanto che ero dentro, pensò che fossi in
galera. Si sarebbe tranquillizzata solo qualche ora dopo, quando rientrai
a casa».
NIENTE RITIRATA. Non aveva alcuna intenzione di rientrare a casa - e con
lui gli altri ragazzi con le magliette a righe - il giovane Rovacchi: «La
macchina del sindacato - ricorda - girava tra i tumulti e l'altoparlante
ci invitava a lasciare la piazza, che la manifestazione era finita. Ma noi
non avevamo alcuna intenzione di ritirarci, qualcuno incitava addirittura
alle barricate. Non avremmo sgomberato la piazza almeno fino a quando la
polizia non spariva. E così fu. Mentre correvo inciampai su un corpo
senza vita, vicino al negozio di Zamboni. Era il corpo di Reverberi, ma lo
capii soltanto dopo».
LA FOTO NON SCATTATA. Il racconto di Zambonelli è sempre più incalzante:
«Da dentro il Gaf - spiega - sentivamo che le urla e gli spari non si
placavano. L'hanno ucciso, e poi scappiamo. Voci che si sovrapponevano,
voci mescolate agli spari. Ci affacciammo da un terrazzino e
vedemmo un capannello di gente. Erano attorno al corpo senza vita di Lauro
Farioli. Feci per scattare una foto ma le mani mi tremavano, non vedevo
l'obiettivo, chiesi a Fulgenzio Codeluppi di aiutarmi. La foto la scattò
lui...».
ALL'OSPEDALE. La giornata non era finita, per questi ragazzi protagonisti
e spettatori di qualcosa di molto più grande di loro. «Volevamo notizie
dei feriti - spiega Zambonelli - e così, cercai con altri di entrare in
ospedale (che era ancora in via Dante), ma c'era la polizia in assetto di
guerra: figuriamoci se si fermavano di fronte a uno pseudo-tesserino da
giornalista». Qualcun altro, come Rovacchi, entrò con uno stratagemma:
«Raggiungemmo la sede della Croce verde e convincemmo gli infermieri a
caricarci sulle ambulanze. E su quelle entrammo». Alla fine anche
Zambonelli riuscirà a passare da un'uscita secondaria: «Entrai in uno
stanzone e quello che vidi mi portò, laico com'ero, a un gesto che non
facevo mai. Con le mani tremanti feci il segno della croce: davanti a me
c'erano feriti ammucchiati ai morti, corpi squartati, irriconoscibili,
ammassati uno sull'altro».
IL RICORDO DEL SECOLO. Poche stanze più in là, i chirurghi erano alle
prese con la loro «giornata particolare». Uno dei testimoni dell'epoca,
il professor Riccardo Motta ricorderà quel giorno come il più importante
del secolo.
«In sala operatoria c'eravamo io, il professor Pampari e il collega
Parisoli. Ricordo nitidamente quelle terribili ore, ne passammo dodici di
fila in sala operatoria, arrivava gente in condizioni disperate. Sembrava
una situazione di guerra: Non c'era tempo per parlare, mentre cercavamo di
fare il possibile avvertivamo, pesantissimi, l'appressione e il dolore dei
parenti».
vedemmo un capannello di gente. Erano attorno al corpo senza vita di Lauro
Farioli. Feci per scattare una foto ma le mani mi tremavano, non vedevo
l'obiettivo, chiesi a Fulgenzio Codeluppi di aiutarmi. La foto la scattò
lui...».
ALL'OSPEDALE. La giornata non era finita, per questi ragazzi protagonisti
e spettatori di qualcosa di molto più grande di loro. «Volevamo notizie
dei feriti - spiega Zambonelli - e così, cercai con altri di entrare in
ospedale (che era ancora in via Dante), ma c'era la polizia in assetto di
guerra: figuriamoci se si fermavano di fronte a uno pseudo-tesserino da
giornalista». Qualcun altro, come Rovacchi, entrò con uno stratagemma:
«Raggiungemmo la sede della Croce verde e convincemmo gli infermieri a
caricarci sulle ambulanze. E su quelle entrammo». Alla fine anche
Zambonelli riuscirà a passare da un'uscita secondaria: «Entrai in uno
stanzone e quello che vidi mi portò, laico com'ero, a un gesto che non
facevo mai. Con le mani tremanti feci il segno della croce: davanti a me
c'erano feriti ammucchiati ai morti, corpi squartati, irriconoscibili,
ammassati uno sull'altro».
IL RICORDO DEL SECOLO. Poche stanze più in là, i chirurghi erano alle
prese con la loro «giornata particolare». Uno dei testimoni dell'epoca,
il professor Riccardo Motta ricorderà quel giorno come il più importante
del secolo.
«In sala operatoria c'eravamo io, il professor Pampari e il collega
Parisoli. Ricordo nitidamente quelle terribili ore, ne passammo dodici di
fila in sala operatoria, arrivava gente in condizioni disperate. Sembrava
una situazione di guerra: Non c'era tempo per parlare, mentre cercavamo di
fare il possibile avvertivamo, pesantissimi, l'appressione e il dolore dei
parenti».