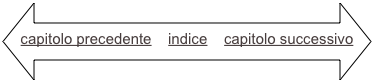Iscrizione all’università

Con tutto quello che mi era capitato negli ultimi tempi non avevo chiare le idee a quale facoltà iscrivermi. In verità mio padre avrebbe voluto che diventassi un dentista “denti guasti e dentiere da riparare ci saranno sempre” diceva e avevo anche letto vari libri su medici e chirurghi, perciò optai per medicina e mi iscrissi. Alla prima lezione di anatomia, vedendo il professore che sballottava da un’ora il braccio di un poveraccio indicando questo e quel muscolo, quell’osso e quel tendine capii che non faceva per me.
Passai a ingegneria, non per niente avevo fatto lo scientifico e me la cavavo bene con la matematica e la fisica. Ma ormai ero una matricola e non sfuggii alla sorte che toccava ai novizi. Convocato assieme ad altri sventurati in un’osteria ci trovammo davanti alla corte degli anziani che ci fecero subire un sacco di angherie. Anzitutto ci fecero bere senza mangiare, perciò dopo un po’ eravamo brilli. Ci misero in mutande e avremmo dovuto rispondere che cosa erano gli anelli, i penelli, i monelli e i trabucos, i vari tipi di peli dell’inguine. Chi non rispondeva subiva un ulteriore maltrattamento. Ma la cosa peggiore era il ferro rovente nel sedere. Con gli occhi bendati ci fecero sdraiare a pancia sotto e ci infilarono a turno un pezzo di ghiaccio nel didietro, l’effetto era tremendo. Alla fine, seminudo e completamente ubriaco di clinton, il famoso vino di uva fragola, fui costretto ad arrampicarmi sulla statua al centro della piazza principale di Padova con in testa mezza anguria che avevo dovuta svuotare con le mani legate dietro la schiena. Alla fine tutti al casino (così si chiamavano allora le case di tolleranza) costretto a un’ ingloriosa performance, sesso e vino non vanno d’accordo, ma ricordo che la “signora” mi disse “Non ti preoccupare carino, la prossima volta andrà meglio”.
Ma non era solo quello il problema. “Senz’acqua la papera non galleggia” , dicono i napoletani, senza soldi io non sapevo come andare avanti. Le diecimila lire che mi aveva dato mio padre erano quasi finite. Aspettando la provvidenza decisi di dare l’unico esame facoltativo di ingegneria, l’esame di lingue. Dato che parlavo discretamente il tedesco pensavo che sarebbe stata una passeggiata, invece mi misero davanti un trattato di ingegneria meccanica che avrei dovuto tradurre. C’erano termini tecnici che non sapevo neanche esistessero. Non ci provai nemmeno e consegnai il foglio in bianco. Ero più avvilito di quando dovevo strisciare sotto i reticolati.
Un giorno venne a trovarmi mio padre e mi portò altre diecimila e la mia amata macchina fotografica, la favolosa Rolleiflex che mi fece sentire subito più fiducioso. Intuivo che avrei risolto i miei problemi con la fotografia. Cominciai a spargere la voce, le prime foto le feci agli studenti del teatro universitario che avevano messo in scena “le Coefore” di Eschilo. In seguito feci ritratti, foto tessera, riproduzioni di calchi in gesso, tutto ciò che capitava e divenni autosufficiente. Andai spesso al teatro Verdi quando c’erano le compagnie di rivista, fotografai Billi & Riva, Walter Chiari, Tognazzi, Vanda Osiris, i comici, le soubrette e le ballerine. Tutti gradivano essere fotografati e la sera dopo consegnavo le foto e riscuotevo. Fui fregato solo una volta da un soldato americano di origine napoletana che per le foto di una soubrette mi rifilò delle Americanlire fuori corso.
Mi ero trasferito in un appartamento con altri studenti presso un’affittacamere, vedova di guerra che mi permise di usare un corridoio come sala di posa. Andavo a sviluppare e stampare le foto in un laboratorio di cui mi aveva dato la chiave il figlio di un professore, anche lui appassionato di fotografia. L’ho rincontrato a Roma tanti anni dopo, scriveva su un giornale di cinema. Il cibo ormai non era più un problema, per questo gruppo di studenti mi ero offerto di fare la spesa e cucinare come avevo visto fare a mia madre. Eravamo sei, facevo giganteschi piatti di pastasciutta, gran risotti e pian piano mi azzardai ad arrostire polli e cuocere carni e verdure. Si divideva la spesa. Le montagne di panini non erano più necessarie. Come lavoro alternativo feci il facchino, aiutavo un cugino che aveva preso in affitto un nuovo locale a trasferire dei camion di mobili da un locale all’altro. Così iniziai una nuova vita, niente più soldati, niente più armi, niente più bombardamenti, niente più la fame lancinante degli ultimi anni.
Comunque per incrementare i miei modesti introiti accettai la proposta di un laureando in veterinaria. Si trattava di vendere un prodotto che preservava i polli da una malattia alla gola, una specie di angina, per cui i polli non facevano più le uova e infine morivano. Si trattava di spennellare ogni tanto la loro gola. Partivo la mattina in bicicletta con un borsone pieno di questo medicinale, giravo le campagne intorno a Padova fermandomi a ogni casolare o fattoria. Le contadine mi dicevano: “Si, ghe vorria na cossa per salvar le gaine, ma da metere nel paston, no gavemo tempo de ciaparle una par una”, tutti così dicevano e io continuai a girare le campagne sperando che qualcuno avesse voglia di fare un tentativo. Dopo qualche giorno dovetti rinunciare e restituii il borsone. Avevo venduta una sola boccetta guadagnando una lira.
© 2005-2006 Erico Menczer