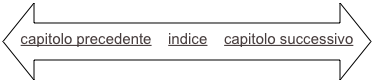Padova

Febbricitante per la fatica e la tensione, rimasi a letto un paio di giorni.
Quando mi ripresentai al comando ebbi una nuova sorpresa. Fui inserito in un gruppo di un centinaio di partigiani. Ci mandarono alla stazione di Susak, saremmo dovuti andare sui monti a snidare i cetnici, seguaci di re Pietro, già alleati dei tedeschi, che si nascondevano nei boschi. Benché io sia nato da quelle parti non ho mai capito bene chi fossero questi fedeli di re Pietro, sapevo che avevano deciso di non tagliarsi né i capelli né la barba finché re Pietro non fosse tornato. Ne avevo visti parecchi con i tedeschi, con barba e capelli fino alla cintura. Per me, italiano, era difficile districarmi tra tante etnie, serbi, cetnici, kossovari, croati, ustascia, sloveni, ecc. Re Pietro era riuscito a tenerli tutti uniti fino all’invasione italiana e dopo la guerra ci era riuscito anche Tito, ma dopo la sua morte erano rinate le antiche rivalità etniche e religiose che non sono tuttora sopite.
Un partigiano aveva due liste con i nostri nomi, una parte doveva salire su di un camion per andare in una zona, gli altri dovevano salire sul treno destinati ad un' altra zona. C’era tanta confusione. Approfittai di questo per dire a un compagno che sarei andato al mercato lì vicino a cercare della frutta. Andai, con fucile e zaino e la mia stella rossa, a comperare delle pere ma invece di tornare al raduno me ne andai a casa con la massima indifferenza. Calcolai che sul camion avrebbero pensato che ero salito sul treno e viceversa. Infatti non mi cercò mai nessuno. Chiuso in casa, dopo aver sepolto in cantina il fucile lubrificato e protetto, non si sa mai…, aspettai che mio padre ottenesse un permesso di espatrio per raggiungere Padova dove avrei dovuto frequentare l’università.
Ottenuto il permesso, mio padre mi trovò un passaggio su un camion che doveva portare a Vicenza un carico di barili di acciughe salate. Lasciata la valigia sul camion, approfittai che gli autisti dovevano caricare i barili, per andare a salutare la figlia di amici per la quale avevo una certa simpatia, anzi, ne ero proprio innamorato e lei mi ricambiava. Si chiamava Paola aveva sedici anni, aveva le treccine, era bellissima. “Noi abbiamo dei cugini a Padova,” mi disse, quando seppe del mio trasferimento “vai a trovarli, forse anche noi andremo a Padova, ci potremmo rivedere lì”. Però mi dilungai troppo nei saluti e vidi dalla finestra che il camion stava partendo senza di me. Ero disperato, “Prendi la bicicletta, corri, lo puoi raggiungere” mi disse il padre della fanciulla offrendomi una bicicletta, saltai in sella e partii a tutta velocità. Ma c’erano tante salite e discese tra Fiume e Trieste, sentivo il puzzo disgustoso delle acciughe che detestavo, ma non riuscivo a raggiungerlo. Dopo una trentina di chilometri mi fermarono a un posto di blocco, mi chiesero il lasciapassare ma era nella valigia sul camion, mi interrogarono, cercai di spiegare che dovevo andare a studiare in Italia, forse mi credettero, comunque mi chiusero in uno sgabuzzino in cui potevo stare solo in piedi o accovacciato, pieno di cimici e altri insetti. Passai una notte infernale senza chiudere occhio pensando alle candide e profumate lenzuola di bucato di mia madre. La mattina seguente avevo le caviglie gonfie. Dopo un altro interrogatorio mi ridiedero la bici e mi rimandarono indietro.
Tornato a casa, mio padre con un nuovo lasciapassare mi trovò un altro passaggio e mi fece salire sul camion pur di vedermi partire. “Non ti voglio vedere più, facci sapere quando arrivi” mi disse abbracciandomi. All’arrivo a Trieste trovai un altro passaggio su un camion carico di profughi e giunsi finalmente a Padova dove avrei dovuto iniziare una nuova vita. La prima notte mi ospitò un amico di famiglia laureando, nella sua stanza alla casa dello studente. C’era un letto solo, ma abituato com’ero a dormire dovunque, dormii benissimo sul pavimento. Ormai ero ufficialmente un profugo, come migliaia di altri istriani e fiumani che giornalmente optavano per rimanere italiani ed erano costretti ad abbandonare le loro case e i loro averi per andare nei campi di raccolta, o per raggiungere altre destinazioni tra cui il Canada, il Sudamerica, o l’Australia.
Il giorno seguente seppi che c’era un collegio che ospitava giovani profughi della Venezia Giulia finché i collegiali erano in vacanze. Ci andai, c’ erano già altri ragazzi fiumani e istriani, mi assegnarono un letto, per il cibo andavamo alla mensa del partigiano dove ci davano a mezzogiorno una fetta di mortadella e una cucchiaiata di patate bollite, la fame non era ancora debellata. Completavamo il magro pasto con le patate dolci americane arrosto, che vendevano sui carrettini e che non avevo mai viste prima. Il famoso caffè Pedrocchi nel centro di Padova era la nostra base, sempre affollato da studenti e da soldati inglesi. Mi divertivo a vedere questi soldati che, seduti intorno ai tavolini, cominciavano a bere birra. Quando sui tavolini le bottiglie vuote non ci stavano più, le mettevano per terra e dopo un po’ non si potevano più muovere finché, completamente ubriachi, se ne tornavano negli alloggi.
La fame è il miglior condimento al mondo.
Elredo de Rievaulx
© 2005-2006 Erico Menczer