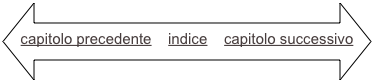Fine della guerra

I giorni seguenti non uscii mai da casa, Con mio padre ascoltavamo il colonnello Stevens da radio Londra per avere notizie circa la possibile fine della guerra. Dopo pochi giorni venimmo a sapere che gli americani non sarebbero mai arrivati, per accordi presi tra gli alleati. I tedeschi, incalzati dalle squadre partigiane, cominciarono ad arrendersi e a tentare di rientrare in Germania. Ci sentimmo defraudati, perdemmo lo spettacolo di cui parlava il Giornale Radio, delle Jeep americane cariche di soldati che giravano nelle altre città liberate tra le acclamazioni della folla e la distribuzione di cioccolate e gomme americane ai bambini. Invece da casa vedevamo l’arrivo dei partigiani jugoslavi che festeggiavano la vittoria, cortei con bandiere e cartelli inneggianti a Tito, balli tradizionali e tanta allegria. Era comprensibile che fossero felici dopo quello che avevano dovuto subire per due anni, dalla Slovenia al Montenegro, braccati dai tedeschi e dai fascisti, vivendo nei boschi e soffrendo la fame e il freddo. Ed era prevedibile che molti covassero vendetta. Niente lasciava supporre che pochi anni dopo si sarebbero combattuti ferocemente, ognuno per la propria indipendenza.
Le guerre non finiscono da un giorno all’altro, ci vogliono mesi o addirittura anni per tornare alla normalità. Migliaia di soldati italiani hanno impiegato mesi per tornare dalla Russia, molti morirono di freddo per la strada, tanti si accasarono con le vedove russe e non tornarono più. Mussolini li aveva mandati a combattere nella neve, a fianco dei tedeschi, con gli scarponi di cartone. Dovevano conquistare la Russia come avevano tentato i francesi di Napoleone, invece il risultato fu che l’Italia perse l’Istria e la Dalmazia e migliaia di soldati nei vari combattimenti o trucidati dai tedeschi dopo la resa. Cominciarono ad arrivare notizie dei campi di sterminio e sapemmo che fine avevano fatto gli ebrei che erano stati deportati in quei due anni. Mio padre tentò di avere notizie dei suoi parenti in Ungheria e Romania, ma sembravano tutti spariti, evidentemente finiti nei forni o nelle fosse comuni. E poi ci vogliono anni per sgomberare le macerie, ricostruire tutto ciò che è stato distrutto, ponti, strade, palazzi, industrie. Anche per me non era finita, dopo pochi giorni un editto del comando partigiano ordinava che tutti i maschi dai sedici ai sessant’anni dovevano presentarsi ai vari comandi di zona. Fummo interrogati, saputo che ero un fotografo ebbi l’incarico di fotografare tutte le manifestazioni, bande, cortei e festeggiamenti, da esporre nella bacheca del comando città. In caserma, in mancanza di divise, mi diedero una bustina con la stella rossa e un fucile tedesco con annesse munizioni. Andai volentieri in giro a fotografare tutto quello che poteva essere interessante per gli jugoslavi di Tito, cortei interminabili, raduni, balli popolari. Non c’era piazza in cui non si ballasse il kolo, un ballo che si fa abbracciati, in grandi cerchi girando in un senso e poi nell’altro cantando, come il sirtaki greco.
Dopo alcuni giorni mi ordinarono di unirmi a un gruppo di partigiani, dovevamo scortare dei prigionieri tedeschi fino in Dalmazia. Eravamo dieci. Mi diedero due pagnotte di pane tedesco per il viaggio e partimmo. Il raduno di questi tedeschi era a una quarantina di chilometri che facemmo a piedi arrivando in un vasto pianoro vicino al mare brulicante di prigionieri esausti, in pessime condizioni. Pensai a quanto si sentivano fieri quando passavano marciando e cantando le canzoni di guerra, armati fino ai denti, terrorizzando i civili. Senza le armi non erano più niente, dei poveracci affamati, con l’unico pensiero di salvare la pelle e tornare a casa. Mi venne da pensare che in fondo erano anche loro vittime del nazismo, che un dittatore pazzo li aveva indottrinati convincendoli che erano il popolo destinato a comandare su tutto il mondo. Come in Italia dove un dittatore dal balcone di piazza Venezia gridava: “Italiani, volete burro o cannoni?” – “Cannoni” rispondevano in coro migliaia di italiani che nell’euforia del momento si sentivano già di fare parte di un’ Italia grande, ricca e potente. Questi prigionieri invece, oltre che essere a terra per essere stati sconfitti, avevano perduto anche la dignità, senza più gradi né mostrine, né medaglie erano tutti uguali. Mi accorsi che nessuno aveva più l’orologio né anelli, erano già stati ripuliti. Chiesi a uno di loro da dove venivano, fu molto meravigliato che parlassi tedesco, per di più con accento viennese, mi disse che venivano da Gorizia, non erano arrivati lontano! Poi si avvicinarono altri, incuriositi da un partigiano che parlava tedesco. Uno di loro intuì dalla forma del mio zaino che avrebbe potuto contenere delle pagnotte e cominciarono a tirare fuori gli ultimi oggetti rimasti, per scambiarli con un po’ di pane, mentre io cercavo di allontanarmi. Ma ormai mi avevano circondato, dovevano essere proprio alla fame. Un prigioniero tirò fuori dalla tasca un portasigarette d’argento e me lo mise a forza in mano dicendo “di mio padre, mein Vater”, pur di andarmene gli diedi una pagnotta. Subito un altro tirò fuori un secondo portasigarette e me lo mise in tasca. Spezzai una pagnotta per tenermene un pezzo per il viaggio e gli diedi l’altra metà. Mentre loro si stavano dividendo il pane riuscii ad andarmene. Dopo sessant’anni conservo ancora i due portasigarette a ricordo di quella assurda giornata. Un ufficiale anziano, certamente di alto rango, forse un generale, ma piuttosto mal ridotto, si reggeva in piedi col bastone, accompagnato da una teutonica Schwester, infermiera impeccabile nella sua uniforme e la crestina, perfetta come appena uscita da casa: unica donna tra millecinquecento prigionieri.
Arrivò l’ordine di partire subito e di scortarli fino a un porticciolo distante qualche diecina di chilometri. Al nostro ordine di partire si incolonnarono per quattro e camminammo fino a notte, quando il capogruppo decise di fermarsi a dormire. I prigionieri spossati da chissà quante marce senza cibo né acqua, crollarono a terra. Erano talmente sfiniti che non c’era nulla da temere. Dormimmo tutta la notte senza problemi. All’alba ripartimmo. Dopo alcuni chilometri ci raggiunse un camioncino carico di scatoloni di cartone con dentro delle latte. Arrivato a metà della lunga fila scaricò gli scatoloni in mezzo alla strada e tornò indietro. Fu il pandemonio, con le poche forze rimaste i prigionieri si buttarono sugli scatoloni come un branco di lupi affamati, spingendosi con violenza per arraffare il più possibile. Davanti alla fame la ferrea disciplina teutonica non funzionava più. Sparai qualche colpo in aria, si bloccarono, ma visto che non c’era nessun morto tornarono alla carica e li lasciai fare. In poco tempo divorarono tutto. Era cibo dell’esercito americano, carne con patate, piuttosto salato, perciò ora erano assetati. Dopo alcuni chilometri arrivammo ad un casale con una fontana, ma far bere millecinquecento assetati fu una cosa impossibile. Tutti insieme con le gavette sotto alla fontana a gomitate e a calci cercando di riempirle. Quasi tutti rimasero a secco perché arrivò l’ordine di ripartire.
A notte fonda arrivammo al pontile dove una vecchia carretta arrugginita ci attendeva per imbarcarci. Ci volle tutta la notte per farli salire uno alla volta con una scala a pioli, disidratati e debilitati com’erano. Alcuni non ce la facevano a salire la scala, mettemmo delle ore a legarli ad uno ad uno con una corda per tirarli su. Alla fine arrivò un’ambulanza che aveva ricuperato quelli più deboli che non ce l’avevano fatta, ce li eravamo persi per la strada. Tirammo su faticosamente anche quelli. Salimmo anche noi della scorta e la carretta all’alba molto lentamente staccò gli ormeggi. I prigionieri erano ammucchiati nella stiva e sui ponti, dovunque ci fosse il minimo spazio per sedere o sdraiarsi. Io mi arrangiai in un angolo della sala macchine. Alcuni scopersero una manichetta dell’acqua e ci fu un’altra battaglia per averne un sorso finché il comandante la fece staccare perché era l’acqua che serviva per le caldaie della macchina. Non c’era nessun cesso sulla nave, i prigionieri avevano tutti la diarrea, facevano i loro bisogni seduti tutt’intorno alla murata di poppa. La carretta era lentissima, il carbone durò poco, i marinai e i macchinisti cominciarono a bruciare tutto quello che era di legno, ma alla fine la barca si fermò e aspettammo un rimorchiatore che dopo qualche ora venne da Zara.
Dopo cinque giorni di viaggio e un’altra fermata a Sebenico, giungemmo al porto di Spalato e cominciammo a far scendere i prigionieri ridotti ormai a larve. Un’altra squadra di partigiani ripuliti, eleganti nelle nuove divise, non mal ridotti come noi, li prese in consegna. Nessuno ci seppe dire dove li portavano. Qualcuno suppose che li avrebbero fatti lavorare in una miniera. Chissà quanti non sono mai tornati a casa, forse altri al posto della casa hanno trovato solo morti e macerie. Dopo un paio d’ore fecero imbarcare noi della scorta su un battello veloce e in tarda serata eravamo a casa.
La vittoria ha cento padri, ma la sconfitta è orfana.
Proverbio popolare
© 2005-2006 Erico Menczer