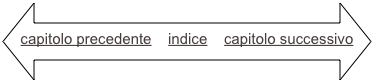Qui comincia l’avventura...

Pochi giorni dopo, un editto dei tedeschi invitava tutti i maschi giovani a presentarsi in piazza. Ci presentammo in centinaia, ci schedarono, ci fu ordinato di metterci a disposizione dell’organizzazione “Todt” che costruiva in tutta l’Europa fortini e trincee per il comando tedesco. Io capitai in un gruppo che doveva scaricare dai treni a giorni alterni sacchi di cemento o travi di legno. Eravamo parte italiani e parte slavi, non conoscevo nessuno, ci accomunava l’odio per questi crucchi che ci costringevano a collaborare, ci sfogavamo mandando loro tutte le parolacce che conoscevamo. Come di consueto le prime parole croate che imparai erano parolacce e bestemmie e pensavo tra me “Ho studiato tanti anni e faccio il manovale, altrochè il dentista, come voleva mio padre, potrò fare al massimo il muratore.” Ci pagavano poche lire e nessun indennizzo se qualcuno si feriva. Avevo studiato che gli egizi trattavano benissimo gli schiavi addetti a costruire le piramidi, ogni uomo era prezioso per trainare gli enormi blocchi di pietra su per le salite. Venivano pagati e curati. Qui invece ci trattavano peggio, fuori uno, ne veniva un altro. Lavori forzati e mai un grazie. Tornavo a casa la sera stanco morto, coperto di cemento, spesso si rompeva qualche sacco, e con le mani ferite dalle schegge, non ci davano nemmeno i guanti.
Andai avanti per delle settimane finché mio padre ottenne da un medico amico un certificato che mi esonerava dai lavori pesanti. Ma fu peggio, ormai ero nelle loro liste e pochi giorni dopo mi convocarono con un centinaio di giovani. Ci dissero di presentarci all’indomani alla stazione di Susak con uno zaino per partire per la Germania. Andai a casa angosciato per i miei genitori che finora per lo meno mi rivedevano la sera. La mattina dopo, mio padre mi fece mettere la sua bella giacca pesante da sciatore con le spalline di cuoio, per lo meno se avessi dovuto trasportare dei pesi… Mi salutarono piangendo e me ne andai pensando che forse non li avrei visti mai più.
Ma alla stazione di Susak arrivò un ufficiale croato pancione, in una immacolata divisa da SS completa di spadino, che ci propose un’alternativa. Potevamo scegliere se andare a lavorare in Germania oppure arruolarci in una cosiddetta “difesa territoriale” e rimanere in città. Optammo in massa per la seconda alternativa senza sapere di che cosa si trattasse. Andava bene qualsiasi cosa pur di non andare in Germania dove oltre a farci ammazzare di lavoro saremmo potuti crepare sotto ai bombardamenti americani. Portati nella caserma di Susak ci fecero indossare una divisa grigioverde con sul braccio lo stemma croato, la scacchiera bianca e rossa, le mostrine rosse ricamate in oro sul colletto e la bustina con la coccarda yugoslava blu, bianca e rossa. Ci sentivamo piuttosto ridicoli. Ci guardavamo l’un l’altro tra il divertito e il sorpreso. Ai piedi avevamo degli scarponi italiani chiodati, sempre quelli con la suola di cartone, e dal ginocchio in giù ci dovevamo avvolgere i polpacci con le antiche fasce che usavano i fanti al tempo di Caporetto. Al posto delle calze ricevemmo delle pezze di tela in cui ci dovevamo avvolgere i piedi prima di infilarli negli scarponi. Mi sembravo Marmittone il personaggio del Corriere dei Piccoli che mia nonna mi leggeva quando andavo all’asilo. Io non capivo ancora il croato, non so che cosa si dicevano i ragazzi, ma dalle facce capivo che pensavano di essere caduti dalla padella nella brace. Ci comandava un tenente tedesco delle SS impeccabile nella sua divisa verde chiaro e due sergenti croati, due burini che erano stati arruolati perché parlavano qualche parola di tedesco. Come unico vantaggio ci davano la sera oltre a una zuppa di tapioca o di rape, una pagnotta tedesca di pane nero, una confezione di margarina e due sigarette che io scambiavo con altra margarina e mi affrettavo a portare il tutto a casa dei miei. Non era semplice, dovevo chiedere al sergente il permesso di andare a casa, lui mi dava la parola d’ordine per rientrare, andavo di corsa a casa, poi dovevo ritornare in caserma entro le dieci con la parola d’ordine, altrimenti la sentinella non mi avrebbe fatto passare. Comunque la fame dei miei era arginata. Appena arrivato a casa si facevano una bella fetta di pane nero spalmato di margarina, era la loro torta.
Facemmo esercitazioni per qualche mese. Dovevamo marciare cantando canzoni di guerra croate e tedesche e obbedire al comando “A terra, in piedi, a terra, in piedi” per delle mezze ore, finché non ce la facevamo più, oppure strisciare sotto i reticolati, in mezzo ai sassi o nel fango o nella neve. Comunque non mi sembrava vero di cavarmela così a buon mercato. Il pomeriggio gara di smontaggio, pulizia e rimontaggio dei fucili mitragliatori e delle pistole. Un ragazzo si sparò una pallottola nel fegato e morì dissanguato. Fecero un frettoloso funerale col prete e la bandiera croata. Erano in maggioranza ragazzi slavi, alcuni parlavano un po’ di fiumano. Un sabato sera il tenente tedesco fece portare nella camerata una damigiana di vermut che pare i tedeschi amassero molto, i ragazzi slavi che non lo conoscevano bevvero finchè cominciarono a vomitare. Dopo un po’ il pavimento della camerata era pieno di vomito ed alcuni ragazzi ubriachi fradici ci erano caduti dentro, era uno spettacolo disgustoso. Io riuscii ad arrivare all’uscita e approfittando del caos me ne andai a dormire in un' altra camerata.
In quel periodo, oltre alle parolacce, imparai a capire e a parlare un po’di croato. Presa confidenza, mi raccontarono quello che i fascisti stavano facendo in Yugoslavia, rubavano il bestiame, impiccavano gli uomini, stupravano le donne, bruciavano fattorie e villaggi. Si divertivano a strappare i baffi ai contadini prima di impiccarli. Alcuni dei ragazzi che venivano dall’ Istria mi raccontarono che lì avevano fatto anche di peggio già negli anni trenta. Uccidevano con un colpo alla testa tutti quelli che si rifiutavano di parlare italiano. Vicino a Pisino avevano riempito di cadaveri un burrone e una vecchia miniera coprendo il tutto con dei camion di terra. Ultimamente si è parlato tanto di foibe, ma nessuno ha detto che le foibe l’hanno inventate i fascisti all’inizio del ventennio per costringere croati e sloveni a diventare italiani.
Una mattina i tedeschi ci fecero prendere gli zaini e ci portarono alla stazione di Fiume. Aspettammo a lungo un treno, poi partimmo per ignota destinazione. Dopo qualche ora uno scoppio sui binari fece deragliare il treno che dopo un violento sbattimento sulle traversine si rovesciò nella scarpata. Arrivarono delle scariche di mitra ma nessuno fu ferito. Eravamo in un bosco in piena notte. Faticosamente riuscimmo a uscire sfondando i finestrini. Dopo una lunga attesa arrivò, per continuare il viaggio, una locomotiva con un solo vagone merci, ci dovemmo entrare tutti, eravamo così stretti che stentavamo a respirare. Ma dopo qualche ora arrivammo a destinazione, era il castello di Duino, oltre Trieste, arroccato sugli scogli, in riva al mare. Il castello era bellissimo, gli ufficiali tedeschi occupavano le stanze e i saloni affrescati. In una grande sala da pranzo mangiavano a lume di candela, con posate d’argento, bicchieri di cristallo e preziose porcellane, serviti da camerieri in giacca bianca. A noi ci sistemarono nelle casematte adiacenti, le vecchie stalle, su dei pagliericci.
Il giorno dopo iniziò una serie di gare di marcia, ci avevano divisi in tre squadre. Si partiva alle sette, carichi di fucili, mitragliatori, mitragliatrici pesanti, il pesantissimo mortaio 91 diviso in tre parti, e munizioni. Dopo quaranta chilometri di marcia, carichi come somari, con le ossa rotte e i piedi in fiamme tornavamo al castello. La squadra che arrivava prima vinceva due fiaschi di vino. Andò avanti per dei mesi, alternando queste marce forzate a esercitazioni di tiro col mortaio, col cannoncino anticarro e il lancio di bombe a mano. Qualche volta dovemmo rimanere a dormire sul posto, quando pioveva dormivamo sotto la pioggia, la mattina bisognava spogliarsi, stendere la divisa al sole, aspettare che si asciugasse per ritornare a Duino. A turno dovevamo fare anche la guardia al castello, si faceva a coppie, dovevamo andare tutta la notte avanti e indietro tra le due entrate del castello per prevenire eventuali incursioni dei partigiani.
Gli abitanti del paesino adiacente al castello con i quali avevamo fraternizzato, dicevano che i tedeschi ci istruivano per mandarci a snidare i partigiani sulle montagne circostanti. Questo ci preoccupava non poco, dato che non erano queste le nostre speranze. Stavamo tutti aspettando notizie dell’arrivo degli americani. Avevano superato il Po e speravamo che ci volesse poco ai carri armati ad arrivare fino a noi.
Una notte, mentre ero di guardia con un ragazzo croato, arrivò un camion tedesco dal quale un sergente della Wehrmacht fece scendere e ci consegnò tre giovani partigiani. Uno perdeva sangue dalla testa, un altro zoppicava. Non ci diede spiegazioni, capimmo che non vedeva l’ora di sbarazzarsene, e ripartì subito. Parlai con loro, erano di vicino Monfalcone, avremmo dovuto metterli sotto chiave in un locale delle casematte, invece io proposi al mio compagno di lasciarli scappare e di scappare pure noi. Era da un po’ che ci stavo pensando e quella poteva essere l’occasione giusta. Il mio compagno fu d’accordo, i tre ragazzi sparirono nella notte e noi prendemmo i nostri zaini e, dopo aver orinato sulle provviste della mensa ufficiali, raggiungemmo di corsa la provinciale. In tempi normali si sarebbe chiamata diserzione. Avevamo deciso di tornare a casa, non prima però di trovare, nelle campagne circostanti, dei contadini che ci vendessero del cibo da portare alle nostre famiglie. Camminammo tutta la notte senza incontrare nessuno, le strade erano deserte, attraversammo dei paesini, sembrava una zona abbandonata da tutti, non una persona, neanche un cane. All’alba, superata Latisana, trovammo in periferia di Portogruaro una fattoria dove il contadino fu disponibile e ci diede due sacchi di farina bianca a quei tempi introvabile e dei pezzi di lardo in cambio di una moneta d’oro dal mio compagno e da me un vestito borghese che mia madre aveva insistito a mettermi nello zaino. Eravamo così allenati a portare armi pesanti che non facemmo molta fatica a rifare la strada di ritorno con circa trenta chili ciascuno nello zaino. Ma di giorno trovammo una sorpresa, un caccia americano faceva ripetutamente la nostra strada mitragliando, forse volevano semplicemente tenere la strada libera per l’arrivo degli americani. All’approssimarsi del caccia ci buttavamo nei fossi o sotto gli alberi.
Arrivati nei pressi del castello aspettammo la notte per passare inosservati. Superato questo ostacolo, incontrammo un carrettiere che ci diede un passaggio fino a Trieste, la città più vicina, dove avremmo potuto prendere il treno. Prima di entrare nella stazione ci strappammo dalla divisa stemmi, mostrine e coccarde in modo da sembrare soldati italiani sbandati. Temevamo anche i sanguinari capelloni cetnici che odiavano i croati e si divertivano a sgozzarli con le loro affilatissime baionette. Salimmo sul treno e la mattina seguente arrivammo a Fiume. Salutai il mio compagno che abitava oltre il ponte, non ci vedemmo mai più. Erano le sette del mattino. Suonai il campanello di casa, mi aprì mia madre che non aveva mie notizie da mesi, la sua gioia fu indescrivibile, ci abbracciammo con ancora lo zaino sulle spalle, poi arrivarono tutti e tolto lo zaino e visto cosa conteneva, mia madre andò di filato in cucina a preparare un dolce.
Fu il dolce più sudato ma anche il più buono di tutta la mia vita.
Raccontando a mio padre l’avventura con gli SS, felice di non aver dovuto mai sparare a nessuno, mi raccontò che anche lui, nonostante avesse fatto vent’anni prima la guerra con gli austroungarici contro l’Italia, aveva fatto di tutto per non sparare mai contro un italiano. Però aveva visto tanti morti e feriti, perciò aveva avuto quella reazione al fuciletto di legno che mi aveva regalato mia nonna.
Il Fascismo non è definito dal numero delle sue vittime, ma dal modo con cui le uccide.
Jean Paul Sartre
© 2005-2006 Erico Menczer