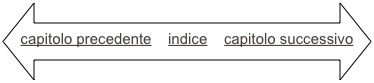Mio padre aveva un ottimo stipendio: Nel ’32, dopo vent’anni di lavoro, aveva fatto costruire la bella villa dove abitavamo. Un giorno un compagno di scuola mi fece una domanda che non mi aspettavo: “Come xe eser richi?” io risposi, “me par che xe normal”. Infatti, anche se alcuni miei compagni abitavano in appartamenti più modesti, facevamo la stessa vita, mio padre casa e ufficio, mia madre la casalinga, noi a scuola a piedi, come tutti. Niente lussi, tranne una radio con quattro cuffie per ascoltare le commedie alla radio, niente automobile, d’estate due settimane al mare o in campagna e stop. Molto raramente, nelle grandi occasioni, mio padre ci portava a mangiare gli scampi fritti dorati come li facevano solo alla trattoria l’Ornitorinco. Dalla villa in collina si vedevano, aldilà della valle, la Jugoslavia e il mare, un fiume divideva le due città, Fiume, italiana e Susak, jugoslava. A Susak andavo d’estate alla spiaggia con i miei amici, c’era solo da attraversare il ponte sul fiume esibendo la carta d’identità.
L’azienda di cui mio padre era uno dei direttori, era proprietaria dell’ unica raffineria in Italia, che forniva benzina e olio a tutta l’ Italia. Mi raccontò un giorno che, essendoci un grosso ammanco nella contabilità di un gestore siciliano, dovette andare di persona a controllare i libri contabili. Scoperta la causa dell’ammanco lo fece presente al gestore il quale se ne uscì dicendo “Qui ci scappa il morto”, mio padre in risposta “ma no, lei ha moglie e figli, ha una casa, ha tanti clienti, per carità non faccia pazzie” al che il gestore “lei non ha capito una minchia, a lei devo ammazzare se non s’aggiusta sta faccenda!” Finì che mio padre dovette trovare il modo per coprire l’ammanco ma tornò a casa sano e salvo.
Un giorno, insolitamente, aveva nevicato tantissimo, circa quaranta centimetri. Al mio primo tentativo di rimanere a casa, mio padre mi obbligò ad andare. Facevo la prima media, e coi miei pantaloncini sopra il ginocchio, come si usava allora, arrivai a scuola dopo una mezz’ora come un ghiacciolo. Il portone era chiuso, il bidello dalla finestra mi fece cenno di andarmene perché ero arrivato solo io. Tornai a casa ma mi rifiutai di andarci il giorno seguente. “Papà, ieri non c’era nessuno, con questa neve non ci sarà nessuno neanche oggi” . Mio padre, impietosito, acconsentì, ma il terzo giorno il capoclasse mi segnò un assenza. Fu l’unica assenza di quell’anno. Ero decisamente un secchione. In terza media cominciai a portare i knickerbocker che allora li chiamavano pantaloni alla zuava. A casa avevo tanti incarichi, strappare le erbacce, bagnare i fiori e aiutare mio padre a selezionare i francobolli di cui era un appassionato collezionista. Ma il mio passatempo preferito era stare nello sgabuzzino in fondo al giardino a costruire oggettini di legno. Dopo un paio d’anni mio padre mi insegnò i primi elementi di fotografia, sviluppare i rullini, stampare i provini e fu l’inizio di quello che sarebbe diventato il principale interesse della mia vita.
Al liceo ho avuto dei professori indimenticabili, tant’è che oggi, alla mia età, ricordo molto di quello che mi hanno insegnato. Il professor Uva di matematica e fisica era il terrore della scuola, nessuno osava fiatare durante la sua lezione, però spiegava benissimo, dal teorema di Pitagora alle leggi della termodinamica. Il professor Lengel, di scienze e chimica, ungherese, con un gran pancione, era anche spiritoso, faceva domande come: “Di che cosa è composta l’aria?” - “ossigeno e idrogeno, professore” – “Allora, basta accendere un fiammifero per far scoppiare il mondo, no?” Ma ricordo tutto, dalle elitre alle ghiandole surrenali. Il professor Droetto di filosofia, era il mio preferito. Ricordo la lezione che mi ha aperto gli occhi sulla religione, “questa bella favola che ci raccontano da bambini” diceva, “alla quale crediamo se e quando ci fa comodo, rimane soltanto una bellissima favola”. Già allora cominciai a guardare i preti con un certo sospetto che negli anni divenne certezza. Li vedo come inutili sfruttatori delle debolezze umane. Non ho mai avuto bisogno di invocare il loro dio, non ho mai avuto necessità di quello che loro chiamano fede. Sono arrivato alla mia veneranda età da onesto ateo, andando in chiesa raramente solo in occasioni particolari, per accontentare mia moglie.
In latino ero piuttosto scarso e una volta fui rimandato a settembre. Invece mi piaceva il disegno prospettico, ero stranamente attratto dalle linee e dai punti di fuga. Tutto filava liscio finché un giorno entrò in classe il preside annunciando che per le nuove disposizioni, i figli di ebrei non potevano più frequentare la scuola pubblica. Ci chiamò per cognome: “Budai, Menczer, Moravetz, Ravenna, Stern”. “Signor preside, ma come faremo per avere la maturità?” – chiesi timidamente. “Vedremo, ragazzi, vedremo...” ma era piuttosto imbarazzato. Ci alzammo, prendemmo le cartelle e uscimmo dalla classe seguiti dagli sguardi dispiaciuti dei compagni. Le scuole private a quei tempi non esistevano, avremmo dovuto studiare a casa per poi dare gli esami. Tornato a casa seppi che mio padre per la stessa ragione era stato licenziato dall’azienda in cui aveva lavorato per 26 anni. Dopo qualche giorno, arrivò al liceo una circolare e noi, figli di padre ebreo, ma di madre ariana, fummo riammessi a scuola, mentre i figli di madre ebrea non tornarono più. Anche per mio padre non arrivò nessuna circolare, fu licenziato da un giorno all’altro con una liquidazione, senza diritto alla pensione. Questa era la legge nazista, poi copiata pari pari dai fascisti. Sembrava inverosimile che un uomo di 44 anni che aveva sempre lavorato nell’azienda con grandi responsabilità, dovesse perdere il suo lavoro e nell’impossibilità di trovarne un altro. Se ne parlò molto in città, fu l’argomento principale per tanti giorni, ne parlò il rabbino nella funzione del sabato, invece dalla chiesa cattolica neanche un accenno.
Da allora, comunque, era facoltativo, ma consigliato, venire a scuola in divisa. I professori si rifiutarono, mentre alcuni miei compagni furono felici di indossare la divisa da avanguardista perché potevano portare alla cintura il pugnale col manico nero su cui spiccava il fascio in similoro.
La scuola

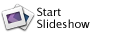
© 2005-2006 Erico Menczer