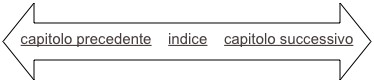L’infanzia

Sono nato nel 1926, negli anni in cui era meglio chiamarsi Benito o Galeazzo invece che Oscar o Walter, considerati nomi stranieri. I miei genitori mi vollero chiamare Eric come l’eroico principe nordico, ma all’anagrafe dovettero aggiungere la o finale.
La mia vita è stata piuttosto movimentata e forse non troppo banale. Sono nato a Fiume, bella città di mare, che per molti anni è stata Ungherese, era importantissima per l’Ungheria, era il suo unico sbocco sul mare, venne potenziato il porto da cui partivano le navi che portavano verso il sud il grano ungherese, costruirono i cantieri navali da dove uscivano bellissime navi, costruirono già nel 1860 il silurificio e la raffineria che fornì per anni la benzina e altri derivati del petrolio a tutta l’Italia dal Piemonte alla Sicilia. Era insomma una piccola città piena di attività industriali, c’era lavoro e benessere per tutti. Dopo la Grande Guerra è diventata Italiana, ora appartiene alla Croazia. In verità Fiume, negli anni 20 fu per breve tempo dichiarata Città Libera, e come tale avrebbe prosperato, libera da influenze sia jugoslave che italiane. Sennonché a un certo Gabriele D’Annunzio, memore delle sue gesta militari, il volo su Vienna e la “beffa di Buccari”, stanco di fornicare e di scrivere poesie, venne la voglia di fare l’eroe, in un impeto di patriottismo raccolse al sud qualche migliaio di reduci stanchi e disoccupati, li chiamò legionari e partì per annettere Fiume all’Italia. Dopo alterne vicende, in contrasto con il governo italiano, fu confinato in una villa sul Garda. Fu il fascismo a completare l’opera cercando di italianizzare le “terre redente”, la città ungherese e l’entroterra slavo. Molti di questi legionari, provenienti dal povero sud, capitati quasi per caso in questa città ricca e operosa, in breve si integrarono sia trovando lavoro sia sposando ragazze fiumane. Nacquero famiglie miste in cui si parlava un po’ di tutto, italiano, sloveno, ungherese, tedesco , siciliano, napoletano, ma più di tutto fiumano. Parlare italiano si chiamava ”parlare in lingua”. Gli italiani venuti dopo d’Annunzio, militari e burocrati mandati a italianizzare la città, mia nonna li chiamava “regnicoli”. Occupavano tutti i posti di responsabilità nei vari uffici amministrativi.
Con i nostri genitori parlavamo tedesco, ma all’asilo cominciai a imparare l’italiano però con i genitori continuai a parlare tedesco finchè a scuola cominciai a parlare italiano. Mia madre mi portava al cinema a vedere le comiche di Ridolini e degli stupendi Harold Lloyd e Buster Keaton che mi facevano sbellicare dal ridere. Una volta però, fece l’errore di portarmi a vedere un film drammatico, con scene di un mare in tempesta, navi in pericolo, vele strappate e marinai disperati. Ero terrorizzato e cominciai a frignare “Mama, gehen wir nach hause, bitte...” Andiamo a casa, ti prego… e non la facevo finita continuando a piagnucolare. Mia madre resistette finchè non ce la fece più e mi riportò a casa pentita di avermici portato. Rimediò portandomi a vedere le prime comiche di Charlot. Già allora mi piaceva tanto andare al cinema.
A tre anni i miei mi portarono a Budapest a conoscere i parenti ungheresi, zii, zie e cugini, e mi è rimasto un vago ricordo dello zoo e del famoso ponte a catene. Invece mi lasciò un segno indelebile il ricordo di un piccolo incudine di metallo che in casa di una zia mi cadde sul dito del piede. Gli strilli fecero accorrere tutta la parentela ma dopo messa una pomata e un cerottino tornò la calma. Tornati a Fiume ricominciai ad andare all’asilo e ricordo l’emozione per la nascita delle piantine di fagioli dai semi che avevamo piantati nell’orticello. Un altro ricordo è quando mia nonna mi regalò a Natale un piccolo fucile di legno che sparava al massimo ceci o piselli secchi. A me piacque molto, ma appena mio padre, che era stato in guerra e aveva ancora vivo il ricordo di tanti morti e feriti lo vide si rivoltò con rabbia verso mia nonna gridando: “mai più fucili in questa casa!” e lo ridusse in pezzi. Questa nonna il sabato mi portava qualche volta al tempio ebraico, l’altra nonna mi portava in chiesa la domenica, ma non saprei dire dove mi annoiavo di più. Già allora mi sembravano ridicole queste cerimonie del prete e dei chierichetti, questo bere e mangiare del sacerdote, la lettura in latino per me allora incomprensibile, con questa voce tra il sofferente e l’annoiato, i paludamenti e cambi di cappello e di orpelli, le scampanellate dei chierichetti annoiati. Non vedevo l’ora di uscire all’aria aperta e fare la passeggiata fino a casa. Non è che al tempio fosse molto diverso, ma la cerimonia , non so perché, mi sembrava un po’ più seria. Ricordo gli schiaffi presi dalla maestra elementare tutte le volte che non sapevo la poesia a memoria, nonostante i tentativi di mia nonna di farmela imparare. In terza elementare, appena uscito il maestro, non so perché, iniziavamo una furibonda lotta a cartellate, cazzotti e spintoni tra balilla e marinaretti. Avevo scelto di essere marinaretto perché la divisa da balilla la trovavo ridicola, quella dei marinaretti era molto più elegante e qualche volta ci portavano a remare con un barcone nel porto, mentre i balilla dovevano marciare sù e giù in mezzo alla polvere con i fucili di legno.
Nel ’36 l’azienda di cui mio padre era direttore commerciale, organizzò un viaggio a Roma in occasione di un’esposizione al Circo Massimo. Mi colpì il primo orologio subacqueo che continuava a camminare immerso in un bicchiere. Fu a Roma che feci le mie prime foto all’Altare della Patria e allo stadio dei marmi, che ancora conservo. Ricordo pure un viaggio in carrozzella con visita alle catacombe sull’Appia antica. Era un po’ pauroso camminare in quelle interminabili gallerie rischiarate solo dalla torcia della guida, mi venne il timore che non avremmo mai ritrovata l’uscita.
Al ritorno, quando andammo alla stazione, il presidente dell’azienda, dovendo rimanere a Roma, offrì a mio padre il suo scompartimento di prima classe. Io e mia sorella eravamo felici di fare per la prima volta un viaggio nelle comode poltrone di velluto rosso. Quando il treno stava per partire arrivò un giovane impiegato in divisa fascista con aquilotto e pugnale e, dato che nostro padre non era iscritto al fascio, ci fece sloggiare per far salire un paio di segretariette che entrarono squittendo e noi dovemmo ritornare in seconda. Fu una delusione, ma io e mia sorella contnuammo a sghignazzare perché il gerarchetto era balbuziente e ci mise un sacco di tempo per spiegarsi. Mia madre, bella ed elegante, di aristocratica famiglia austroungarica fece finta di niente.
Alle olimpiadi di Berlino, nel ‘36, successero cose imprevedibili. Mentre Hitler contava sulle immancabili vittorie della Germania, soprattutto nell’atletica, le medaglie d’oro più importanti, i 100 metri piani e il salto in lungo le vinse un nero americano che vinse anche nella staffetta 4x 100 con altri tre atleti di colore. Hitler, assertore della superiorità della razza ariana, non fece nulla per nascondere la sua rabbia. La medaglia d’oro di pugilato nei “pesi gallo” la vinse un dipendente dell’azienda di mio padre, Ulderico Sergo. In ufficio erano tutti euforici, la notizia apparve su tutti i giornali e ne parlò a lungo la radio. Nel cinema comico italiano la stella era Macario, un attore piemontese che aveva creato un personaggio divenuto famoso per alcune battute come “Ma lo vedi come sei?” che divenne la battuta tormentone tra noi ragazzi che non ne perdevamo uno dei suoi film.
Ci fu la guerra civile in Spagna, ma gli echi erano lontani. I giornali dell’epoca, asserviti al fascismo, riportavano solo le notizie delle vittorie dei franchisti. Noi sapevamo che molti antifascisti venuti da tutta l’Europa e dagli USA partecipavano a quella guerra, ma Hitler e Mussolini mandarono aerei e carri armati per aiutare Franco a battere le forze democratiche i cui capi erano stati eletti dal popolo. Dopo la vittoria di Franco fu prodotto in Italia il film “L’assedio dell’Alcazar” per esaltare l’eroica resistenza delle falangi del “Caudillo” aggredite dagli antifascisti.
La guerra per la conquista dell’Abissinia fu molto seguita. Quando tutte le potenze coloniali europee stavano decidendo di abbandonare le colonie perché davano più problemi che vantaggi, Mussolini ebbe la bella idea di andare a conquistare l’Etiopia. Eritrea e Somalia non gli bastavano più. Le copertine della “Domenica del Corriere” e di altri settimanali con le famose illustrazioni di Walter Molino facevano vedere le navi cariche di soldati col casco coloniale, in partenza per l’Eritrea da dove sarebbe partito l’attacco alle forze etiopi. Iniziata l’invasione, sia a casa che a scuola, segnavamo sulla carta geografica con le bandierine tricolori le conquiste dei soldati italiani contro gli abissini armati di lance e frecce. Nacque la canzone “Faccetta nera”. Caddero Adua, Macallè, Amba Alagi, Amba Aradam, e infine Addis Abeba. L’Etiopia fu chiamata Africa Orientale Italiana e nacque la sigaretta “Africa”. Grandi feste che culminarono col furto dell’obelisco di Axum che fu portato a Roma come trofeo e piantato all’inizio del Circo Massimo. L’ allora già famoso regista Blasetti girò “Luciano Serra, pilota” con Amedeo Nazzari.
A scuola ci furono i “Ludi iuveniles” , si trattava di scrivere un componimento sul Duce. Il premio ai migliori sarebbe stata la partecipazione al Campo Dux a Roma, un accampamento di tende erette nei pressi del Foro Italico, sarebbe venuto il Duce in persona a distribuire dei premi. Non mi sarebbe dispiaciuto tornare a Roma e stare in mezzo a ragazzi della mia età provenienti da tutta l’Italia. Perciò misi tutto l’impegno per vincere la gara, ed essere il migliore della scuola. Ma non vinsi, nonostante avessi scritto le lodi più sperticate di Mussolini, scrivendo che era il più grande, il più intelligente, il più bravo, il più coraggioso, ecc. ecc. Mio padre, quando gli dissi che non avevo vinto mi chiese : “Che cosa avevi scritto” e io glielo dissi. Mi guardò senza espressione e mi disse: “Bravo, bravo, hai fatto bene”. Dopo la grande vittoria nella campagna d’Africa, la domenica mattina alle otto dovevamo essere tutti in piazza in divisa, dai figli della lupa ai giovani fascisti, dalle piccole italiane alle donne fasciste. Dovevamo prepararci lungo il Corso in lunghe file, allineati per quattro, con in testa i tamburini e tante bandiere e gagliardetti. Verso le undici, al suono della banda, arrivava il Segretario Federale, un certo Genunzio Servidori tronfio come un pavone, col suo seguito di camicie nere, piene di medaglie guadagnate col manganello e l’olio di ricino, che ci passava in rivista. Sembrava un film di Fellini. Finita la musica, al grido di “Eia eia eia” bisognava rispondere in coro “Alalà!” Era l’imitazione del “Hip Hip… Hurrà” degli inglesi. Poi arrivava il “Rompete le righe!” bisognava rispondere “A noi!” e si sciamava verso casa mentre il Federale e il suo seguito si piazzavano nel bar principale, davanti alla casa del fascio, per prendere l’aperitivo e per leggere l’ultimo numero de “Le grandi firme” il giornale umoristico di moda in quel periodo.
Il pomeriggio prendevamo spesso il vaporetto che in mezz’ora ci portava ad Abbazia, bellissima località balneare ai piedi del Monte Maggiore, piena di giardini e di lussuosi alberghi e circondata da castagneti e ciliegi. Si ascoltava il concerto nel parco, si prendeva un gelato sulla passeggiata lungomare, poi di nuovo a casa col vaporetto. Si era formata l’alleanza tra Germania, Italia e Giappone, il Famoso “ROBERTO” dalle iniziali ROma BERlino TOkio. Doveva essere una guerra lampo invece durò sei anni dall’occupazione della Polonia alla bomba di Hiroscima e morirono tra militari e civili milioni di persone.
Se un milione di persone crede ad una cosa stupida, la cosa non smette di essere stupida.
Anatole France

© 2005-2006 Erico Menczer